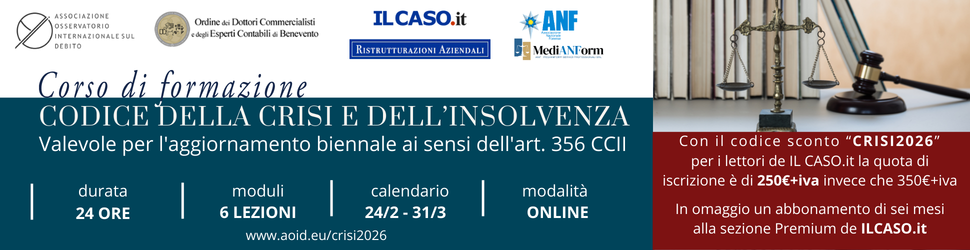CrisiImpresa
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 12/03/2015 Scarica PDF
La crisi delle società di calcio professionistico a dieci anni dal caso Napoli
Francesco Fimmanò, Professore ordinario di diritto commerciale presso l'Università delle camere di commercio "Universitas Mercatorum" di Roma e Vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei contiSommario: 1. Evoluzione del mercato delle imprese sportive ed asimmetrie di sistema; - 2. Norme organizzative interne federali e regole Uefa (licenze e fair play finanziario); - 3. Sub-ordinamento sportivo-convenzionale, ius singulare e situazioni giuridiche soggettive; - 4. La tutela della res azienda sportiva; - 5. Unitarietà funzionale ed accessorietà degli assets; - 6. La natura ed il ruolo del titolo sportivo; - 7. La questione della circolazione del titolo in caso di insolvenza della società di calcio professionistico; - 8. L’evoluzione delle norme organizzative federali in tema ed il ruolo della Covisoc.
1. Anche quest’anno non è mancato il campionato “giudiziario” del calcio con una variegata casistica di gloriosi clubs dichiarati insolventi o che comunque hanno gettato la spugna per ripartire dai “dilettanti”[2]. In realtà, l’espansione degli interessi economici e del rilevo sociale di alcuni comparti dello sport professionistico e la connessa esplosione di questioni interpretative riguardanti i rapporti tra ordinamento sportivo e statale, offrono l’occasione per una riflessione complessiva sulle società di calcio, sulle relative aziende (intese come complessi di beni e rapporti strumentali all’esercizio dell’impresa sportiva), sulle interrelazioni con il mercato ed infine sui rapporti tra diritto sportivo, diritto commerciale e fallimentare.
Con la crescente evoluzione del football professionistico, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) [3], a metà degli anni ’60, attuò la prima riforma delle società calcistiche, attraverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con la quale veniva imposto ai clubs, titolari di squadre militanti nelle principali serie, di adottare la forma delle società per azioni, mediante la predisposizione di uno statuto-tipo [4], nel quale veniva esclusa espressamente qualsiasi possibilità di attribuzione di utili agli azionisti o di plusvalenze derivanti dalle partecipazioni [5] .Nel 1974 il legislatore, poi [6], sancì che la base dell’ordinamento, al cui vertice si collocavano il CONI e le Federazioni suoi organi[7], era costituita da “società, associazioni ed enti sportivi” che “non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali”. Funzione di tali organismi, una volta riconosciuti dal CONI, era quella di inquadrare gli atleti, fossero essi professionisti o dilettanti[8].
La legge 23 marzo 1981, n. 91, essenzialmente concepita per il calcio[9], cristalizzava l’obbligo, per le società che stipulassero contratti con atleti professionisti di costituirsi nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata ed imponeva la previsione statutaria del totale reimpiego degli utili per lo svolgimento dell’attività sportiva. L’assoluto divieto di distribuzione degli utili veniva confermato dalla previsione che al socio, anche in sede di liquidazione della società, non potesse essere attribuito che il valore nominale delle partecipazioni, mentre libera di fatto da regimi vincolistici rimaneva la cessione delle partecipazioni sociali [10]. La c.d. legge 91 è stata radicalmente novellata dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, che tra l’altro abrogava il vincolo di destinazione degli utili della società sportiva all’attività sociale e, di converso, del divieto di distribuzione degli utili a favore dei soci [11]. L’intervento normativo, concepito per il calcio, ha avuto soprattutto la funzione di consentire la quotazione di società sportive nei mercati regolamentati[12].
In tema di sport dilettantistico un ulteriore tassello[13] ha esteso le disposizioni riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro. Infine la legge 21 maggio 2004, n. 128 [14], emanata per esigenze prettamente fiscali, ha inciso anche sul diritto sostanziale, prevedendo la possibilità di utilizzare anche la forma della cooperativa ed eliminando la necessità di inserire negli statuti l’obbligo, posto a carico della società, di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o all’ente di promozione sportiva, cui la società o l’associazione intende affiliarsi [15]. Inoltre, non si prevede più la necessità di stabilire le modalità di riconoscimento, a fini sportivi, delle società e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline associate a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI, anche su base regionale [16]. Il legislatore ha introdotto una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative [17] e che si inserisce nell’ordinamento giuridico come una peculiare categoria di diritto speciale, facendo emergere un sistema complessivo ibrido che vede nel contratto di società uno schema organizzativo neutro, idoneo, cioè, al perseguimento di attività tanto lucrative, quanto non lucrative, con una serie di problemi da risolvere sul piano interpretativo.
Sullo sfondo di questo quadro normativo, a partire dal 2005 è stato prima introdotto, per le società di calcio della massima serie che partecipano alle competizioni europee, un sistema di regole per ottenere le c.d. licenze UEFA [18] (Union of European Football Associations)[19] e poi, come vedremo meglio di seguito, un modello articolato di fair play finanziario.
In tale contesto, caratterizzato da una sorta di ibridazione ordinamentale, devono convivere nel rispetto dei principi costituzionali, le norme comuni di diritto civile e fallimentare, le norme speciali di diritto sportivo e le norme organizzative federali interne (c.d. NOIF) ed europee, cioè le disposizioni regolamentari delle singole federazioni (associazioni riconosciute) che evidentemente non possono che essere “conformi” alle leggi ed ai principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.
2. Questo quadro complessivo, fondato sulla esigenza, anche normativa, di separare l’ambito dello sport dilettantistico da quello professionistico[20] e da quello del calcio in particolare, in realtà ha risentito e tuttora risente di alcune palesi ambiguità. Le numerose vicende giudiziarie di questi ultimi quindici anni che hanno riguardato in particolare società calcistiche e Federazione di appartenenza rientrano, in realtà, nell’alveo più ampio della profonda crisi di identità che attraversa una parte del mondo dello sport professionistico e quello del football in particolare.
La crisi d’identità riguarda imprese che hanno voluto passare dal diritto speciale [21] al diritto comune e che hanno aspirazioni opportunistiche e velleitarie di collocazione un limbo ove in virtù di provvedimenti normativi eccezionali possano godere di speciali prerogative, provvedimenti cui sono stati attribuiti non a caso nomignoli del tipo salvacalcio, spalmadebiti, stoppa-Tar e così via. Il fenomeno appartiene ad una tendenza più generale diretta a creare sempre più frequentemente categorie di soggetti i cui rapporti sono regolati da uno ius singulare. Fenomeno deprecabile, in quanto nel migliore dei casi, finisce per originare privilegi e discriminazioni. In taluni casi, poi, non è tanto la ponderata volontà di sottrarre alla disciplina comune determinati soggetti a spingere il legislatore sulla strada della riforma, bensì l’incapacità a resistere alla pressione di gruppi organizzati, che spesso emotivamente e prepotentemente, chiedono e invocano questa o quella riforma. In tal modo, il potere legislativo, sollecitato da spinte corporative, si muove male e si trasforma, come sul dirsi in una machine a faire lois [22].
Più volte è stata proposta in passato una radicale novella alla legge n. 91 come emendata con D.l. n. 485, del 1996, che ha determinato una gestione del settore priva di controlli efficaci [23]. L’art. 10 è quello che, novellato nel 1996, introducendo il fine di lucro e la conseguente possibilità delle società sportive anche di quotarsi in mercati regolamentati [24], ha svincolato le società dall’obbligo del reinvestimento degli utili nell’attività sportiva ha esaltato il carattere imprenditoriale delle stesse, con rilevanti conseguenze per l’intero sistema.
In uno scenario in cui la scarsa patrimonializzazione delle società (a differenza ad esempio delle concorrenti inglesi proprietarie innanzitutto degli impianti sportivi[25]) e l’esiguità di ricavi accessori all’attività sportiva (provenienti dal merchandising, licensing, etc.) espone gli investitori all’alea dei risultati delle singole partite. La questione della proprietà e dell’organizzazione degli stadi (peraltro connessa alla emergenza della sicurezza riproposta dalle recenti vicende della finale 2014 di Coppa Italia), dei diritti televisivi e della complessiva mancata “aziendalizzazione”, lascia tuttora la sorte delle società alle mere possibilità patrimoniali dell’azionista. Al di la degli sforzi di introdurre meccanismi di salary cap e di fair play finanziario[26] è ancora diffusa la logica della mera “vetrina” per l’azionista e non della capacità reddituale dell’impresa. Qualche anno fa in occasione dei celebri crack Parmalat e Cirio e con essi delle collegate società Lazio e Parma calcio, il Wall Street Journal Europe ha rappresentato l’intreccio, anche un pò provinciale, di interessi finanziari, industriali, politici e sportivi, richiamando Lorenzo de’ Medici e facendone un paragone con le complicità che hanno creato i mostri Parmalat e Cirio e ravvisava nello scandalo peculiarità tipicamente italiane con al centro le figure di questa sorta di baroni, adulati spesso senza ritegno indipendentemente dalla effettiva abilità imprenditoriale, e la cui manifestazione più eclatante e provinciale è emblematicamente rappresentata dal possesso della squadra calcistica cittadina[27].
Le società sono state così indotte a indebitarsi oltre misura allo scopo di avere nel breve-medio tempo un ritorno economico tale da risollevare la propria capacità finanziaria e raggiungere un saldo attivo. Un quadro del genere abbinato agli effetti della famigerata sentenza Bosman, anche sul bilancio[28], ha prodotto una situazione spesso preoccupante.
L’assetto è stato caratterizzato per anni da norme organizzative che lasciavano un elevato grado di discrezionalità nelle decisioni di autogoverno. Il metodo, poi, di regolamentare ex post, alla luce di specifiche esperienze non è stato adeguato ai tempi: si pensi al c.d. Lodo Petrucci concepito, male, dopo il caso Fiorentina[29]; oppure al comma 7, dello stesso articolo 52, elaborato dopo il c.d. caso Napoli, od alla inapplicabilità di quest’ultima norma ai fallimenti dichiarati dopo la realizzazione dei calendari di lega (ci riferiamo ai casi successivi di Salernitana, Torino, Perugia, Messina, etc.).
Si tratte di “toppe” che volta per volta hanno mostrato inevitabilmente la tipica debolezza della norma del caso concreto. Piuttosto che agitare all’infinito la ormai datata sentenza Bosman come alibi ad una gestione dilettantistica di un settore così importante della vita, anche economica, oltre che sociale del Paese, tale sentenza avrebbe dovuto rappresentare uno stimolo alla trasformazione “sistemica”. Alla fine dell’era del dilettantismo calcistico avrebbe dovuto seguire rapidamente quello delle relative forme di gestione delle società tenendo conto ormai del contesto, almeno europeo, di riferimento e dei relativi principi di libera circolazione[30].
Delle due l’una: o bisogna considerare queste imprese “di spettacolo” come tali a prescindere dall’oggetto peculiare dell’attività[31] o va riconsiderata l’introduzione dell’obbligo di reinvestire gli utili per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva in modo da rendere anche più tollerabile un atteggiamento di favor normativo e fiscale anche in sede comunitaria. La sostanziale bocciatura all’epoca del c.d. decreto salvacalcio da parte della Commissione europea, in quanto contrario alle norme comunitarie sulla concorrenza appare ineccepibile[32].
Orbene una scelta normativa di fondo tra le due opzioni non può non tener conto del rilievo economico del comparto. Nel 2012 il valore della produzione del calcio professionistico in Italia è stato di 2,660 miliardi di euro con costi complessivi del sistema che hanno superato il fatturato totale, attestandosi a 3,018 miliardi euro. Soltanto 22 club (il 18% del totale) hanno chiuso il bilancio con un utile. La perdita si è tradotta in un notevole incremento dell'indebitamento che a fine anno ha sfiorato i 3,5 miliardi di euro che ha riguardato soprattutto le principali società della massima serie [33].
Per ragioni di questo tipo, il Comitato esecutivo della UEFA, già a settembre 2009, ha emanato il Financial Fair Play Concept, un corpus di regole in vigore a partire dal 2012 che devono essere osservate dalle squadre partecipanti alle competizioni europee. Gli obiettivi dell’Uefa sono quelli di: incentivare i club ad operare sulla base dei propri ricavi; introdurre una maggiore razionalità nei conti; proteggere appunto i creditori delle squadre nella prospettiva di potenziali crisi[34]. A tal fine è stato ideato un modello basato su due principi: il break-even requirement (il conseguimento del pareggio tra ricavi e costi) e il no overdue payables (la verifica tempestiva della regolarità dei pagamenti, una sorta di sistema “ad hoc” di allerta e prevenzione)[35]. Con l’entrata in vigore del fair play finanziario, quindi, da un lato i club dovranno rivedere le proprie linee guida gestionali, dall’altro le federazioni nazionali e quella europea dovranno dedicare maggiori attenzioni al processo di monitoraggio che eseguono sui club, nella logica e con il rigore che guida tutti gli altri comparti economici a tutela del mercato, della concorrenza e degli stakeholders (creditori in testa).
Se questo ormai è il trend, va evitato che sanzioni disciplinari o tecniche incidano sulla partecipazione ai campionati di competenza (come è avvenuto con le retrocessioni a seguito della vicenda c.d. di Calciopoli) con un effetto sulle regole della concorrenza, invece di esporre semplicemente le società responsabili all’azione risarcitoria delle concorrenti danneggiate dalle irregolarità, come accade in qualsiasi altro settore dell’attività economica. Ma come vedremo le ultime modifiche alle Noif cominciano a muoversi in questo senso (cfr. la modifica degli artt. 22 bis, 38, 52, 93, 100, 101, 102 bis, 103, 103 bis, delle Noif del 27 maggio 2014).
Nella stessa logica bisogna rendere sempre più le Federazioni, o almeno quello che gestiscono gli sport professionistici più importanti vere e proprie Autorità indipendenti di regolamentazione del settore, onerarle di obblighi e poteri di indagine ancora più penetranti sulle società[36]. Allo stato, ad esempio, l’attività federale è limitata alla sola possibilità di richiedere, ex art. 2409 c.c. [37], l’intervento dell’autorità giudiziaria[38], mentre prima le Federazioni potevano direttamente promuovere la messa in liquidazione, come capita ad esempio nel settore bancario od assicurativo. Ed infatti al riguardo una certa giurisprudenza in passato aveva rilevato che “il tribunale è tenuto ad accogliere la domanda avanzata dalla Figc di revoca della liquidazione di una società calcistica senza necessità di accertare l’eliminazione delle gravi irregolarità di gestione denunziate, risultando nell'esclusiva disponibilità della federazione la sanzione dello scioglimento della società, tanto nel momento genetico dell'irrogazione della misura punitiva quanto ai fini del suo protrarsi”[39].
D’altra parte l’ordinamento giuridico è ormai indirizzato in questo senso, se ad esempio si pensa al riconoscimento ad opera della sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei conti, con la sentenza 993 del 16 ottobre 2012, della responsabilità erariale di alcuni arbitri ed assistenti di gara per la lesione del diritto all’immagine della P.A. conseguente ai fatti correlati alla vicenda Calciopoli[40].
3. Queste premesse evidenziano che qualsiasi soluzione interpretativa non risolve i problemi di fondo, ma serve solo ad immaginare assetti funzionali al migliore funzionamento delle società sportive e delle relative aziende nel quadro dei rapporti tra ordinamenti. Allo stato quindi possiamo solo analizzare le principali questioni applicative concernenti la compatibilità tra istituti di diritto comune e regolamenti sportivi [41], sulla base di una impostazione sistematica e sistemica.
Tale analisi, deve partire dall’affermazione del primato di norme imperative dettate dal codice civile e dalla legge fallimentare a tutela dei diritti soggettivi in genere [42] su esigenze ed interessi particolari di sub-ordinamenti convenzionali funzionali ai propri tesserati [43]. Questa impostazione ricevette già l’avallo del Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220 (convertito nella l. n. 280 del 2003 – cd. “Decreto Salva Calcio”) [44], col quale Governo prima e le Camere poi, approvarono, qualche anno fa, alcune disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, al fine di porre rimedio alle situazioni di conflitto sorte tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, con particolare riferimento al mondo del calcio[45].
In particolare, il decreto delinea e definisce innanzitutto i Principi Generali della fattispecie (art. 1): il primo è consacrato nel riconoscimento e nel favor da parte della Repubblica dell’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. (art. 1, comma 1). Contemporaneamente, il Legislatore ha avuto cura di graduare lo stesso rispetto a principi dell’Ordinamento ritenuti di maggior rilevanza. Ai sensi del comma 2 del predetto art. 1, infatti, il principio generale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo e della conseguente regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra ordinamento sportivo ed ordinamento della Repubblica viene “compresso” e limitato in tutti i casi in cui si verifichino fattispecie di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica legate a situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. In altri termini, ai sensi dell’art. 1, comma 2 Legge 280/03 intanto è riconosciuta autonomia all’ordinamento sportivo in quanto i rapporti tra questo e l’ordinamento giuridico della Repubblica non si traducano nel verificarsi di casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico medesimo relativi a situazioni soggettive connesse proprio con l’ordinamento sportivo. L’art. 2, - non a caso rubricato autonomia dell’ordinamento sportivo,-sancisce espressamente che in applicazione dei principi di cui all’art. 1 (rectius: salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della repubblica) è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, la disciplina e le sanzioni disciplinari. Le controversie che, invece, esulano da questo ristretto ambito sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo e la competenza a decidere è stata attribuita – tanto per le misure cautelari quanto per le decisioni di merito – al TAR del Lazio. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti [46]. L’art. 3 stabilisce, che esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del comitato olimpico nazionale italiano o delle federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo … La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio ….”[47].
I problemi interpretativi principali che si sono posti, e che in verità continuano a porsi, riguardano la configurazione dell’azienda sportiva, la circolazione dei relativi assets, l’applicazione della disciplina civilistica e fallimentare diretta a garantirne l’unitarietà, il rispetto delle regole della concorrenza, la tutela dei diritti dei soci, dei creditori e più in generale degli stakeholders dell’impresa ed il rapporto tra diritti soggettivi ed interessi anche nella prospettiva del riparto di giurisdizione[48].
Questioni che sono state evidenziate ed esaltate dalle vicende di crisi che hanno riguardato importanti imprese calcistiche negli ultimi anni e che hanno fatto emergere tutte le interrelazioni con il mercato e le relative contraddizioni.
Innanzitutto si è posto il problema della natura giuridica del c.d. titolo sportivo, dell’appartenenza, delle circolazione e della tutela dello stesso. L’art. 52, delle Norme Organizzative della Federazione Giuoco Calcio (c.d. NOIF), lo definisce, anche all’esito della recente modifica del 27 gennaio 2014, come “…il riconoscimento da parte della Figc, delle condizioni tecnico sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campinonato…”.
Tale diritto a vedersi riconosciute le condizioni di partecipazione ad una certa categoria del campionato di calcio è sostanzialmente “un diritto potestativo che si manifesta completamente al termine di ciascun campionato in esito alla verifica” [49] della sussistenza, in capo alla società affiliata, di determinati presupposti [50]. Il problema è analizzare i rapporti con l’azienda calcistica e la società commerciale cui essa appartiene. In particolare occorre chiedersi se questo diritto circola con l’azienda per effetto di negozi traslativi e se tale circolazione può essere inibita, o limitata, da norme federali, cioè da norme interne di un’associazione riconosciuta cui pur è delegata una pubblica funzione.
Orbene, se l’ordinamento giuridico attribuisce alla res azienda una unità funzionale che la rende qualcosa di diverso dalla mera sommatoria dei beni e dei rapporti che la compongono, e se nella fattispecie il titolo sportivo costituisce un valore fondamentale ed irrinunciabile, conseguentemente diviene inammissibile che tale valore venga gestito fuori delle regole di diritto comune o venga acquisito gratuitamente da terzi seppure in una diversa categoria, in pregiudizio agli stakeholders sociali.
La problematica offre lo spunto per una serie di riflessioni rispetto ad una fattispecie che può realizzarsi per imprese sportive in bonis (come accade per tutte le aziende appartenenti ad imprese di altri settori dell’economia) e che può anche rappresentare una soluzione in funzione della salvaguardia dei valori patrimoniali, per imprese in crisi o fallite o in fase preconcorsuale.
Orbene se la legge stabilisce che “i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo” in questo contesto sarebbe ardito affermare che nel nostro ordinamento, al contrario di quanto accade per tutte le aziende (da quelle produttrici di burro a quelle che fabbricano cannoni), quelle sportive possono veder azzerato il principale valore patrimoniale dalla Federazione di appartenenza. La questione non è la proprietà del titolo sportivo o la sua natura, ma è la possibilità che una impresa utilizzi i valori aziendali di un’altra impresa (nome, clientela, storia, avviamento) gratuitamente o comunque a titolo originario, come una sorta di esproprio senza indennizzo[51].
4. L’azienda come complesso di beni e persone organizzato mediante l’attività di coordinamento dell’imprenditore deve comunque essere considerata come una realtà che si estingue solo a causa della disgregazione dei fattori della produzione e non certo per effetto di altri eventi [52]. Anche la procedura fallimentare può consentire la conservazione del complesso produttivo evitando distruzioni di ricchezza, purché ciò sia comunque compatibile col migliore soddisfacimento dei creditori.
In questa ottica, il fallimento, specie a seguito della riforma, tutela l’interesse dei creditori e dell’economia generale, tutelando l’interesse alla sopravvivenza dell’azienda, anche calcistica[53]. Con la dichiarazione di fallimento cessa l’esercizio dell’attività imprenditoriale del debitore insolvente ma l’azienda può sopravvivere sino a quando si mantiene nella sua unità produttiva ed organizzativa e soprattutto finchè conserva la funzionalità all’esercizio dell’attività economica. Da questa prospettiva appare superata la tradizionale concezione basata sulla contrapposizione tra gli interessi relativi alla conservazione dell’azienda e alla tutela del ceto creditorio.
Al fine di evitare la disgregazione del complesso aziendale, la legge fallimentare novellata, prevede accanto all’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito (contemplato anche dall’art 16 delle Noif) [54], che a sua volta riveste funzioni diverse a secondo della fase del procedimento in cui viene disposto [55], l’affitto dell’azienda[56] e la gestione mediante veicoli societari appositamente creati[57].
La continuazione temporanea rientra in una sorta di gestione pubblica processuale in cui viene sostanzialmente dissociato l’esercizio dell’impresa dalla responsabilità e dal rischio, normalmente concentrati nello stesso soggetto. L’affitto dell’azienda invece può essere stipulato in funzione della procedura o nel corso della stessa, specie se utilizzato in relazione alla successiva vendita, nell’ambito di un tipico programma unitario diretto a massimizzare il valore di liquidazione [58].
Infine il conferimento in un veicolo societario previsto dal novellato art. 105, della legge fallimentare, consente una segregazione dell’azienda dai debiti, sul modello realizzato già qualche anno fa nell’ambito dell’amministrazione straordinaria del gruppo Parmalat, per il Parma Calcio, rimasto per lungo tempo nel perimetro della procedura concorsuale per poi essere ceduto[59]. L’art. 20 delle Norme organizzative federali (c.d. NOIF), prevede l’ipotesi della conservazione del titolo sportivo in presenza di vicende circolatorie dell’azienda della società sportiva che ne è titolare, nelle forme della fusione, di scissione o, appunto, del conferimento in conto capitale[60].
5. A questo punto occorre chiedersi se l’ordinamento giuridico può consentire che il valore aziendale del titolo sportivo (ovvero del diritto al riconoscimento delle condizioni tecnico-sportive) possa essere sottratto al patrimonio sociale in virtù di disposizioni regolamentari interne di un sub-ordinamento convenzionale o se viceversa l’unitarietà dell’azienda e dei suoi elementi esenziali vada sempre giuridicamente tutelato.
L’azienda è qualificabile come una pluralità di beni unificati dalla unitaria destinazione produttiva, ed in quanto tale, oggetto di rapporti di diritto pubblico e di diritto privato. La particolarissima unitarietà funzionale all’esercizio dell’attività economica impressa al coacervo di beni dall’imprenditore, mediante un’attività di coordinamento, attribuisce all’azienda una sicura rilevanza giuridica e la rende meritevole in diverse sedi, come individualità oggettiva [61], di una tutela espressa da parte del legislatore [62].
L’attività dell’imprenditore di coordinamento ed organizzazione dei fattori della produzione (capitale, fisso e circolante, e lavoro) nelle dimensioni e nelle proporzioni più idonee ed efficaci per il miglior risultato economico produttivo, è ciò che imprime il soffio vitale al mero complesso di beni isolati rendendolo funzionalmente unitario e perciò azienda.
La tutela di questa unitarietà funzionale è molto evidente nelle norme che regolano proprio l’usufrutto e l’affitto dell’azienda e che impongono all’usufruttuario ed all’affittuario l’obbligo di gestirla “senza modificarne la destinazione ed in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte” (art. 2561, comma 2). Ma anche le norme di cui agli artt. 2557 e 2558, c.c., relative al divieto di concorrenza dell’alienante ed alla successione ex lege dell’acquirente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda e dirette a garantire che il complesso mantenga le sue potenzialità economiche, sono precetti frutto della destinazione imprenditoriale dell’azienda. La stessa ratio ha ispirato le Noif laddove si mira alla conservazione unitaria di tutte le componenti dell’azienda sportiva e la legge fallimentare negli artt. 104, 104 bis, 104 ter , 105, 155 e 156.
Quel che è certo è che l’azienda per divenire, rimanere o ritornare tale, anche nel corso di una procedura concorsuale, ha bisogno dell’attività dell’imprenditore di organizzazione dei beni, ha bisogno cioè di un’impresa di riferimento cui essere funzionale [63]. Insomma l’ordinamento giuridico assegna all’azienda un ruolo strumentale rispetto all’imprenditore e perciò diviene decisiva, per la sua configurazione in senso tecnico, la destinazione ad impresa del complesso secondo il collaudato schema dell’atto di destinazione [64].
L’azienda è presa in considerazione dalla legge proprio in vista della sua circolazione, volontaria o coattiva che sia [65], ecco che la stessa questione del titolo sportive si pone in occasione della sua nuova attribuzione. La cosa azienda non ha una consistenza fisica propria che ne permetta l’identificazione attraverso i sensi ma può essere identificata soltanto quale oggetto di fatti e rapporti da essa scaturenti. Insomma l’etichetta azienda può coinvolgere “diversi fenomeni giuridici: i beni organizzati, le energie, i rapporti costituiti a questo scopo, l’avviamento, la clientela, i servizi, i prodotti, le materie prime, le persone, etc.”. Il problema è perciò stabilire quali caratteristiche siano irrinunciabili affinchè l’insieme di questi elementi eterogenei costituiscano un’azienda nell’ambito della concreta vicenda circolatoria [66].
Sicuramente non occorre che il trasferimento riguardi il complesso originario nella sua interezza, ossia quale si configurava presso l’alienante, visto che il legislatore non esige che l’acquirente sia posto in grado di esercitare la medesima impresa dell’alienante, ma che oggetto dell’atto dispositivo sia un complesso di beni organizzato, funzionalmente idoneo all’esercizio dell’attività economica [67]. Il trasferimento potrà riguardare infatti anche un ramo d’azienda [68], ossia una frazione del complesso aziendale dell’alienante destinata originariamente all’esercizio di un settore della sua attività, che, integrando autonomamente un idoneo, autonomo e compiuto strumento d’impresa dotato di attitudine alla destinazione imprenditoriale, va trattato, nella dinamica giuridica della circolazione, sostanzialmente come un’azienda [69].
Il complesso oggetto della circolazione potrà essere sicuramente costituito da beni materiali, quali ad esempio il denaro, i beni mobili, gli immobili, i macchinari, le merci, le energie; da beni immateriali quali la ditta, l’insegna, i marchi, i brevetti, le invenzioni, i segreti produttivi; e dal lavoro dei collaboratori, dipendenti ed autonomi. Per quanto riguarda gli altri rapporti giuridici, esistono due orientamenti diversi, uno restrittivo [70] secondo cui non fanno parte dell’azienda crediti, debiti e contratti ed una estensiva preferita dalla giurisprudenza [71] anche se, in verità, mancano sentenze riguardanti lo specifico oggetto. L’opzione è importante perchè nel primo caso avremmo cessione di azienda anche se si vendesse solo un complesso organizzato di beni e persone e nel secondo caso avremmo trasferimento anche se ciò che si cedesse fossero soprattutto rapporti [72]. Ed in particolare se si ritenessero imprescindibili i debiti, ivi compresi quelli derivanti da rapporti di lavoro subordinato, dall’azienda e dalla sua circolazione, diverrebbe difficilissimo trovare interessati al suo acquisto nell’ambito di una procedura di vendita fallimentare. Qualora, invece il trasferimento dei rapporti debitorii fosse solo un effetto dell’alienazione, peraltro eliminabile nella liquidazione concorsuale, la commerciabilità del bene azienda sarebbe assicurata.
Riteniamo che alle due soluzioni vada preferita, perciò, una terza, intermedia: sicuramente debiti e crediti non fanno parte dell’azienda in quanto tale [73], ed il loro trasferimento è eventualmente un effetto della circolazione, che nell’ipotesi di affitto e di trasferimento fallimentare è escluso, tuttavia vi sono alcuni rapporti giuridici inscindibili dal contesto aziendale.
Talvolta alcuni rapporti non possono essere esclusi: si pensi all’ipotesi di un albergo che venga ceduto senza il contratto di locazione dell’immobile nel quale è esercitata l’attività economica (tant’è che non si applica il divieto di sublocazione previsto dalle norme di diritto comune), o all’azienda concessionaria di vendita di una famosa marca di auto che venga ceduta senza il contratto di concessione, o infine ad una squadra di calcio senza il titolo sportivo. Ebbene secondo una certa impostazione anche in casi come questo, il trasferimento non avrebbe ad oggetto rapporti giuridici, ma veri e propri beni aziendali di cui l’imprenditore sarebbe titolare in base a relazioni giuridiche diverse da quelle del diritto di proprietà [74].
In verità, ci pare che, in tali casi, debba soccorrere il criterio di funzionalità all’esercizio dell’impresa: bisogna tener conto dei rapporti che costituiscono strumento indispensabile dell’impresa e della loro assoluta complementarietà oltre che dei beni in senso stretto. I beni aziendali, infatti, anche se rimangono giuridicamente distinti l’uno dall’altro sono complementari, per la funzione che svolgono rispetto agli altri beni, e strumentali, per la destinazione economica e per il collegamento funzionale impresso dall’imprenditore.
Sicuramente un complesso di beni e rapporti per rimanere azienda, anche nel corso di una procedura concorsuale, deve essere innanzitutto organizzato o potenzialmente riorganizzabile, e cioè i singoli elementi devono avere quel particolarissimo modo di essere che li renda aggregabili rispetto ad una certa attività e quindi idonei e funzionali all’esercizio di quella impresa. Quanto all’avviamento [75], ossia alla circostanza che l’azienda sia una cosa dinamica, un bene in atto, diverso cioè da un semplice opificio dotato di ogni accessorio ma economicamente fermo come una mera addizione di beni senza vita, va rilevato che l’azienda può essere tale anche se è inattiva [76] purchè l’attività d’impresa sia stata un tempo esercitata ed il complesso di elementi, da cui è formata, abbia tutti i presupposti oggettivi per essere riavviato [77]. D’altra parte l’avviamento non è un bene immateriale separabile dall’azienda [78] e non può costituire oggetto di rapporti giuridici autonomi [79], si tratta di un elemento immanente e risultante dalla coordinazione di una serie di fattori oggettivi e soggettivi che possono persistere anche in caso di inattività [80].
Discorso diverso va fatto per la clientela [81], l’insieme, cioè, delle persone da cui in un certo momento ci si può ragionevolmente attendere la richiesta dei prodotti o dei servizi (nel nostro caso i tifosi). Essa costituisce un sintomo dell’avviamento, una manifestazione o meglio ancora l’effetto più immediato, con la conseguenza che “di avviamento è possibile parlare anche nell’ipotesi di un’attività non ancora iniziata, al contrario come è facilmente intuibile, l’afflusso di richieste di beni o di servizi verso una determinata azienda non può che essere una effettiva e concreta conseguenza della gestione di questa da parte dell’imprenditore”.
Utilizzando, dunque, l’approccio metodologico da noi proposto si arriva alla conclusione che non si può fissare aprioristicamente, in via generale ed astratta, quali e quanti beni e rapporti, costituiscano il nucleo indispensabile a rendere nella fattispecie concreta un coacervo di elementi azienda. Evidentemente, occorre di volta in volta ed a seconda della specifica ipotesi, verificare quali beni e quali rapporti, in quella determinata circostanza siano oggettivamente imprescindibili dalla struttura di un complesso organizzato affinchè rimanga funzionale all’esercizio di quella impresa. Esistono “dei collegamenti di beni, i quali, per la loro destinazione, e soprattutto per la loro organizzazione in vista della destinazione, diventano, in misura e in maniera molto varie, termini indipendenti di rapporti giuridici” [82].
Vi sono casi in cui è possibile qualificare azienda, nell’ambito di una vicenda circolatoria fallimentare, un semplice immobile dotato di licenza o di autorizzazione amministrativa [83], e ciò vale soprattutto per esercizi aperti al pubblico (un bar situato all’interno di una stazione ferroviaria o di un aereoporto, una sala cinematografica attrezzata, uno stabile adibito ad albergo in una esclusiva località climatica, od una farmacia). Oppure ipotesi in cui un semplice brevetto, un segreto industriale od una concessione di vendita possono assumere una funzione centrale se l’azienda era sostanzialmente concentrata nello sfruttamento di quel brevetto, di quel segreto o di quella concessione. O, ancora, ipotesi in cui la cessione di una testata di un giornale o di un canale televisivo possano essere configurati come trasferimenti d’azienda a tutti gli effetti. Oppure vi possono essere dei casi in cui i rapporti di lavoro, specie quelli infungibili [84], abbiano una rilevanza decisiva: si pensi alle compagnie di spettacolo, alle società di revisione, alle società di progettazion, alle società di pubblicità, o alle imprese fallite ai fini dell’applicazione della legislazione speciale di liquidazione.
O, infine, si pensi al caso delle imprese sportive in cui è impossibile parlare di trasferimento dell’azienda se si sottrae alla stessa il diritto al riconoscimento del titolo sportivo [85].
In concreto, il miglior metodo di indagine per l’interprete è quello di valutare l’importanza degli elementi che mancano rispetto a quelli che sono presenti nel complesso aziendale, secondo la relazione logica del binomio essenziale – accessorio [86]. L’accessorietà deve essere innanzitutto di tipo funzionale, nel senso che è accessorio un bene o un rapporto non essenziale rispetto all’esercizio di quella impresa, e poi per valore: si dovrà valutare se il valore complessivo di ciò che manca risulti accessorio rispetto al valore del complesso esistente.
Normalmente i due criteri daranno risultati coincidenti, i beni essenziali per funzione saranno quasi sempre tali anche con riferimento al valore. Tornando al nostro caso del titolo sportivo, se lo stesso è funzionalmente necessario all’esercizio dell’impresa calcistica, il suo valore sarà proporzionalmente decisivo rispetto al valore della restante organizzazione [87] e come tale imprescindibile ed irrinunciabile. Se si trasferisse un’azienda calcistica senza il diritto al riconoscimento delle condizioni di partecipazione al campionato, l’oggetto del trasferimento sarebbe in realtà una mera sommatoria di beni.
6. La natura del titolo sportivo, ovvero del diritto al riconoscimento delle condizioni tecniche e sportive che, laddove ricorrano i requisiti di carattere patrimoniale e finanziarie, permette l’iscrizione al campionato di competenza, è, a nostro avviso, un diritto potestativo assoggettato ad un accertamento dei presupposti assimilabile a ciò che si verifica ad esempio nell’autorizzazione amministrativa all’esercizio farmaceutico cioè alla titolarità di una farmacia, cosa diversa dalla legittimazione[88].
Questo tipo di autorizzazione non ha natura di concessione amministrativa (visto che nel nostro ordinamento il servizio farmaceutico non è riservato all’autorità pubblica in regime di monopolio) ma di autorizzazione costitutiva, ossia crea nel privato una situazione giuridica che non deriva dalla sfera dell’ente pubblico. E nessuno dubita della trasferibilità dell’azienda farmacia comprensiva dell’autorizzazione, come nessuno dubita che il trasferimento della farmacia senza autorizzazione si traduce nella cessione di una mera somma di beni e rapporti [89]. E’ ovvio poi che la P.A. (la Federcalcio in quanto delegata dal CONI) dovrà verificare la sussistenza dei requisiti di farmacista in capo al cessionario, così come è necessario che la Federazione verifichi la sussistenza dei requisiti della società sportiva affiliata cessionaria ai fini dell’iscrizione al campionato.
Tale iscrizione nella categoria conquistata sul campo configura dunque una ipotesi di accertamento costitutivo: ovvero la Federazione deve limitarsi ad accertare l’esistenza delle condizioni tecniche e sportive (organizzazione, rapporti di lavoro con i calciatori, diritto a disputare le partite in un impianto adeguato, diritto a partecipare ad una certa serie) e di quelle patrimoniali-finanziarie, la cui complessiva ricorrenza genera il diritto alla partecipazione al campionato di calcio.
In questo senso il diritto alla partecipazione al campionato in presenza dei requisititi e della legittimazione è una imprescindibile componente aziendale, che circola unitamente alle altre prerogative, attribuendo al cessionario il diritto all’accertamento costitutivo dell’iscrizione al campionato. Il titolo è qualcosa di diverso rispetto all’affiliazione alla Federazione della società che lo possiede e sopravvive anche alla eventuale revoca di questa, dato che, come afferma lo stesso art. 52, delle Noif, “… il titolo di una società a cui venga revocata l’affiliazione può essere attribuito ad altra società con delibera del Presidente della FIGC...” . Ciò dimostra una sopravvivenza del titolo alla revocata affiliazione, nonché una autonomia delle due fattispecie visto che l’affiliazione si disperde in esito al fallimento – ma a seguito di una delibera- laddove il titolo – non l’affiliazione – è attribuito ad “ altra società”. L’affiliazione deve esistere allora, quale premessa per l’acquisto del titolo che, però sopravvive a questa, potendo essere attribuito a terzi dopo la revoca dell’affiliazione della società che lo ha conquistato sul campo.
L’art. 16 delle NOIF prevede, al comma 5, che il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del Tribunale; al comma 6, la revoca della affiliazione in caso di dichiarazione di fallimento (gli effetti della revoca, nel caso in cui il Tribunale disponga la continuazione temporanea dell'esercizio della impresa fallita , decorrono dal termine della stagione sportiva, o da quella di data anteriore in cui il titolo sportivo viene attribuito ad altra società). Infine al comma 7. è prevista la revoca della affiliazione della società in caso di liquidazione della società a norma del codice civile [90].
Accertato che il nostro legislatore in diverse sedi ha evidentemente ritenuto l’azienda, e la conservazione della sua unitarietà funzionale, meritevole di una specifica tutela, resta da verificare se questo interesse giuridicamente rilevante può essere sacrificato da esigenze peculiari di sub-ordinamenti convenzionali e da norme organizzative interne federali che consentono di attribuire ad altre imprese il fondamentale valore aziendale del titolo gratuitamente [91], ovvero garantendo il pagamento dei solo i creditori tesserati iscritti alla Federazione (art. 52, comma 6, delle NOIF c. d. Lodo Petrucci) [92].
Orbene vero è che a norma del comma 2, dell’art. 52 delle NOIF, “in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione”, tuttavia ciò va interpretato, in relazione alla ricostruzione operata, nel senso che il diritto a partecipare ad un campionato (in presenza dei requisiti e delle legittimazioni) non può circolare autonomamente dal complesso dell’azienda calcistica, esattamente come accade per la ditta che a norma dell’art. 2565, c.c., non può essere trasferita separatamente dall’azienda.
Ma a ben guardare non si pone neppure il problema del conflitto tra Noif e disciplina codicistica, in quanto le prime, invero, contemplano la circolazione dell’azienda comprensiva del titolo (e non solo nell’ipotesi di cessione a seguito di esercizio provvisorio dell’impresa della società fallita). L’art. 20 delle Noif, infatti, prevede espressamente la fattispecie non solo in caso di fusione e di scissione ma anche in caso di conferimento a società interamente controllata. La norma parlando di conferimento in conto capitale, implicitamente già comprende l’ipotesi del conferimento in natura del godimento dell’azienda, fattispecie sostanzialmente identica a quella dell’affitto. D’altra parte la stessa Federazione ha talora avallato il trasferimento dell’azienda di società sportive fallite ad opera della procedura a seguito di vendita senza incanto [93], ipotesi di sostanziale circolazione del complesso comprensivo del titolo, tenuto conto che le norme vincolistiche ed in particolare quelle di cui all’art. 2558, c.c., si applicano indifferentemente alla vendita ed all’affitto.
In realtà a monte della impostazione di quanti affermano l’inammissibilità della circolazione dell’azienda sportiva (comprensiva del diritto a partecipare ad un campionato professionistico), ed in particolare dell’affitto, c’è la preoccupazione che questa pratica possa prestarsi ad abusi generalizzati e funzionare da escamotage per lasciare i debiti alla società locatrice e trasferire di fatto il titolo ad altra società appositamente creata seppure in godimento [94]. Tuttavia il potenziale abuso nell’utilizzo di un istituto di carattere generale, quale è l’affitto dell’azienda, abuso ben noto alla prassi fallimentare in settori diversi da quello sportivo, non può certo giustificare la inapplicabilità dello stesso alle società di calcio, od una interpretazione preclusiva alla luce di norme interne di un’associazione di diritto privato pur delegata di una pubblica funzione.
7. Questa ricostruzione è stata di fatto definitivamente riconosciuta, a seguito del c.d. caso Napoli Calcio, anche dalle Norme Organizzative Federali in particolare dall’art. 52 commi 3, 7, 8 e 9, modificate a seguito delle controversie giudiziarie promosse dal Fallimento della Società Sportiva Napoli Calcio[95] e poi successivamente ancora integrate e modificate fino all’ultima novella del 27 maggio 2014.
Il Tribunale fallimentare di Napoli aveva escluso la possibilità di <<immaginare, anche con riferimento ai principi costituzionali di cui agli artt. 41, 42 e 47 Cost., come questo bene (il titolo sportivo) potesse, senza neppure la previsione di un indennizzo, essere sottratto ai creditori dell’impresa fallita, in favore di un’organizzazione che, sorta al servizio dello sport e dei valori sportivi, si è andata da tempo trasformando in una mastodontica impresa dello spettacolo che movimenta affari e business miliardari, addirittura riferibili a società di capitali, alcune delle quali quotate in borsa. … rilevato il preminente interesse dei creditori della stessa, a conservare alla massa attiva il titolo sportivo, e ciò anche in considerazione del dato che appare in contrasto con l’ordinamento statuale .… e ciò in quanto giusta la normativa di cui all’art. 1/2 l. 17.10.2003 n. 280 di conversione con modifica del D.L. 19.08.03 n. 220, sussiste la prevalenza dell’ordinamento statale nei casi (come è sicuramente quello in esame) di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo …. considerato che nel caso del fallimento della S.S.C. Calcio Napoli S.p.A. (società professionistica, organizzata come società di capitali) il titolo sportivo costituisce, se non l’unico, sicuramente il principale bene patrimoniale, e comunque un elemento imprescindibile dell’azienda calcistica di cui la curatela è titolare, dalla cui liquidazione è prevedibile l’acquisizione di un attivo tale da garantire un’ampia possibilità di riparto, finanche per i creditori chirografari, …>>[96].
Così, il testo dell’art. 52, comma 3, Noif, all’esito del c.d. lodo Napoli sanciva che il titolo di una società cui venga revocata l’affiliazione poteva essere attribuito, ad altra società a condizione che la nuova dimostrasse, tra gli altri, di aver acquisito l’intera azienda della società insolvente in uno al titolo, fermo restando il controllo tecnico organizzativo della FIGC per la definitiva attribuzione del titolo stesso[97].
Ma vi è di più nei commi 7, 8 e 9, dell’art. 52 (ora abrogati), si sanciva che anche nelle ipotesi in cui lo stato di insolvenza fosse accertato o dichiarato, era la procedura concorsuale ad individuare la società assegnataria dell’azienda. Le NOIF prevedevano una procedura di assegnazione del titolo alla categoria subito inferiore che implicava la negoziazione dell’azienda in uno al titolo della categoria da parte della procedura fallimentare. Tutto ciò determinava l’acquisibilità all’attivo del fallimento dei valori aziendali trasferiti, a prescindere dalle condizioni patrimoniali che l’acquirente corrispondesse alla Federazione quale “sacrificio di ingresso”, sia esso rappresentato dal pagamento dei debiti sportivi ovvero da un contributo straordinario[98].
Tuttavia nel modificare le NOIF (in particolare gli artt. 16 e 52) per renderle conformi ai principi dell’ordinamento ed al rispetto dei diritti soggettivi, la Federazione ometteva all’epoca di modificare il c.d. lodo Petrucci (comma 6 dell’art. 52), che continuava a consentire l’assegnazione del titolo ad una nuova società della medesima città, nel caso in cui la vecchia fosse stata esclusa dai campionati professionistici, ma non fosse stata ancora dichiarata insolvente al momento dell’elaborazione dei calendari della nuova stagione [99].
Non si comprendeva tuttavia la ragione in base alla quale in caso di tempestivo fallimento della società esclusa, fosse contemplato il necessario l’acquisto dell’azienda della società fallita ai fini dell’attribuzione del titolo, ed invece nel caso di mancato fallimento o di fallimento intempestivo (successivo alla elaborazione dei calendari), fosse legittima l’attribuzione a titolo originario della partecipazione al campionato a terzi soggetti che non avessero avuto causa dalla vecchia società sportiva. Tanto più se si pensa che la “nuova” società si poteva iscrivere alla categoria inferiore sulla base dell’ottenimento sul campo da parte della “vecchia” società della categoria superiore e sulla base del presupposto dell’accertata sussistenza dei requisititi di tradizione sportiva (continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, C1 e C2 negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell’ambito del calcio professionistico). Requisiti evidentemente posseduti dalla vecchia società e non dalla nuova e che viceversa consentivano l’attribuzione della componente patrimoniale del titolo alla seconda in via originaria e non derivativa dalla prima.
In particolare è accaduto che per effetto dell’assegnazione di un titolo sportivo a società “clone” (ad es. Florentia Viola[100], Salernitanta Calcio 1919[101], Perugia Calcio [102], Società Civile Campo Torino[103]), appositamente costituite per svolgere nelle medesime città la medesima attività economica, per rivolgersi alla medesima clientela (tifosi della squadra cittadina) ed al medesimo bacino di utenza, hanno acquisito a titolo originario i valori aziendali intangibili principali appartenenti alla vecchia società (la clientela, l’immagine, l’avviamento, il Know how, i colori sociali, il nome in genere storpiato con minimi cambiamenti[104]). In alcuni casi con l’ulteriore criticità (che ad esempio ha riguardato la squadra di Salerno nel 2005\2006) di avere due squadre sostanzialmente gemmate dal medesimo club in due categorie diverse.
La norma federale era insomma disarmonica rispetto ai principi dell’ordinamento giuridico e dei diritti soggettivi della società esclusa ed era potenzialmente in grado di generare un danno grave e irreparabile, al patrimonio della società esclusa ed ai suoi creditori. E’ evidente, infatti, che la sottrazione improvvisa dei detti valori e l’attribuzione a titolo originario a terzi, determinava un deficit patrimoniale della società calcistica interessata che non potendo più partecipare ai campionati era destinata all’impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, alla liquidazione ed all’insolvenza.
E’ evidente che l’ordinamento giuridico non può consentire che i valori aziendali connessi al titolo sportivo, elemento infungibile ed indispensabile per l’azienda calcistica, possano essere sottratti alla massa dei creditori in virtù di un sub-ordinamento convenzionale in quanto l’unitarietà dell’azienda, o quanto meno dei suoi elementi essenziali, è normativamente tutelata. Untitolo sportivo legato alla città, alla storia, ai trofei, al bacino di utenza dei tifosi, non può essere attribuito a titolo originario e gratuito prescindendo dall’azienda della dante causa, in quanto ciò violerebbe un principio fondamentale addirittura di rango costituzionale, con una sostanziale espropriazione senza indennizzo. Ed infatti su questi elementi è intervenuta la giurisprudenza di merito che in particolare nei casi Salernitana e Torino hanno riconosciuto che il trasferimento di fatto e coatto dell’azienda, sotto forma di trasferimento della legittimazione a partecipare ad un campionato professionistico ledesse i diritti soggettivi del dante causa o comunque dell’avente causa curatela fallimentare[105].
8. Alla luce di queste riflessioni, oggetto anche di ampio dibattito[106], si arriva all’attuale assetto normativo dell’art. 52, sicuramente più armonioso, ove invece di adattare la norma al caso concreto, con la necessità conseguente di doverla aggiornare all’infinito, si individua una regola generale che fissa i principi sistematici.
Pertanto il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, può ora essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza: di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza (laddove questa fosse la fattispecie concreta); di avere ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.; di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta; di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza; di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.
Non vi sono più insomma distoniche differenze nel caso in cui la società fallisca prima o dopo l’assegnazione, o vada in concordato od in mera liquidazione volontaria. L’unica differenza è che se il fallimento interviene nel corso del campionato non v’è dubbio che l’attività debba proseguire, mediante l’esercizio provvisorio, nell’interesse dei creditori, per valorizzare l’asset titoto e consentirne la vendita proficua.
Esiste insomma una norma generale che tendenzialmente rispetta i principi dell’ordinamento giuridico e che evita conseguenze, come la perdita di categoria per l’acquirente, che possano danneggiare il patrimonio e con esso i terzi creditori.
La FIGC, nel sovrintendere gli interessi dell’ordinamento sportivo, attribuisce il titolo all’acquirente dell’azienda dopo avere verificato che quell’aspettativa acquisita, con l’azienda, possa divenire un diritto (il titolo) per avere soddisfatto i requisiti tecnico organizzativi. Come accade ad esempio nel caso delle farmacie[107] che possono essere trasferite solo muniti di legittimazione e requisiti all’esito di una verifica, ed il trasferimento, non è valido se insieme al diritto di esercizio non venga alienata l’azienda commerciale connessa, pena la decadenza. Anche in quel caso non si pone il problema della proprietà del titolo ma il diritto potestativo in caso di circolazione.
Ognuno, allora, dispone di ciò che può: la procedura concorsuale (o comunque il dante causa) dispone della azienda in cui esiste il diritto potestativo incedibile ed “inassegnabile” autonomamente dall’intero complesso aziendale e la FIGC dispone del solo potere di riconoscere i requisiti tecnico-organizzativi in capo all’acquirente quale elemento ulteriore alla partecipazione al campionato.
Considerato che la gestione dell’insolvenza ex post, deve essere accompagnata da una gestione efficiente ex ante, relativa alla società in bonis e fondata sul ruolo dei c.d. gatekeepers, di pari passo al delineato percorso sulla circolazione del titolo e dell’azienda sportiva, v’è stata l’evoluzione della normativa sui controlli, analogamente a quanto abbiamo visto in sede UEFA, diretta a costituire un vero e proprio sistema di allerta e prevenzione.
A partire dal 2006, con la modifica del Titolo VI delle Noif, sono stati fissati per i club appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti obblighi di informazione più penetranti, rispetto ai precedenti, che presuppongono l’utilizzo sistematico di strumenti di controllo di gestione. I clubs sono tenuti infatti a depositare presso la Covisoc entro il 30 giugno: il budget del Conto economico; il budget del Rendiconto finanziario; note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget e i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità; note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa. Entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun semestre le società di Serie A e B devono inoltre depositare presso la Commissione il report consuntivo, indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget[108]. Le modifiche delle Noif hanno riguardato anche il calcolo degli indici economico-patrimoniali. In particolare, il nuovo articolo 85 Noif impone il deposito, con cadenza trimestrale, dell’unico prospetto relativo al rapporto tra Valore della produzione e Debiti finanziari [109]. Il valore minimo che deve assumere tale rapporto è fissato annualmente dal consiglio federale ed il mancato raggiungimento di questo valore determina l’inibizione dalle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che le stesse non trovino integrale copertura nei corrispettivi pattuiti nei contratti di cessione o mediante l’incremento di mezzi propri. L’indicatore rapporta una grandezza positiva di reddito — il Valore della Produzione risultante dal Conto economico — con una posta finanziaria negativa di Stato patrimoniale rappresentata dall’indebitamento finanziario[110].
A giugno 2010 il Consiglio federale della Figc ha provveduto nuovamente a novellare il Titolo VI delle Noif, sempre nella direzione dell’allerta e prevenzione delle crisi. Per quanto concerne le società di Serie A si è intervenuti nelle norme riguardanti il pagamento degli emolumenti e il versamento di ritenute e contributi. In particolare è stato stabilito che le società debbano documentare alla Figc entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati. I pagamenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento della iscrizione al campionato. Riguardo al secondo profilo, sempre entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre le società devono documentare alla Figc l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (in passato versati all’Enpals) e del fondo fine carriera in favore dei tesserati. In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare alla Covisoc la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentarne, altresì, l’avvenuta regolarizzazione. La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, deve certificare alla Covisoc l’avvenuto versamento da parte della società dei contributi al fondo fine carriera dovuti per ciascun trimestre[111].
Il controllo contabile federale sulle società di calcio professionistiche si esplica con l’analisi di indicatori di bilancio, differenziati a seconda della categoria di appartenenza delle società. In particolare: le società di serie A vengono valutate analizzando il rapporto Valore della produzione/Debiti finanziari; per le società di Serie B vengono valutati i rapporti Valore della produzione/Debiti finanziari e Patrimonio netto contabile/Attivo patrimioniale; i club di Lega Pro devono invece essere in regola nel calcolo dei rapporti Ricavi/Indebitamento e Patrimonio netto contabile/Attivo Patrimoniale.
Con la novella, infine, sono stati previsti altri due organismi direttamente impegnati nel sistema delle licenze nazionali affiancati alla Covisoc: la «Commissione criteri infrastrutturali» e la «Commissione criteri sportivi e organizzativi». Si tratta di due nuovi entità che giocano un ruolo di raccordo tra il controllo nazionale e quello europeo, la cui istituzione deriva dal recepimento nella disciplina federale italiana del citato Manuale delle licenze Uefa, che dunque ampliano il novero dei gatekeepers a tutela del peculiare mercato delle imprese sportive professionistiche.
Gli strumenti finalmente ci sono ed occorre solo attivarli per tempo, al fine di evitare interventi tardivi, che a differenza del passato non sono fulmini a ciel sereno, ma storie già scritte e bene prevedibili. Ogni riferimento alla sanzione della mancata partecipazione all’Europa League del Parma F.C. SpA per ritardato pagamento delle imposte, è puramente voluto.
[1] Lo scritto integra valutazioni tecnico-giuridiche, rese nella qualità di Ordinario di Diritto Commerciale, che rivestono il carattere di considerazioni del tutto personali ed in alcun modo riferibili alla funzione di componente della Corte di Giustizia federale di FIGC, né v’è nel testo alcun riferimento a vicende trattate in questa qualità od oggetto di giudizio della V sezione della Corte di cui l’Autore fa da anni parte.
[2] Ci riferiamo ad esempio al Fallimento dell’A.S. Bari Spa (Trib. Bari n. 31 del 10 marzo 2014) fondata nel 1928, la cui azienda dopo l’esercizio provvisorio della curatela è stata venduta alla fine del campionato, oppure alle esclusioni eccellenti per mancanza dei requisiti patrimoniali e finanziari dell’A.C. Siena SpA erede del club nato nel 1904, e del Calcio Padova SpA, che non essendo fallite in corso di campionato, si sono iscritte alla serie D per la stagione 2014\2015.
[3] Istituito con la legge 16 febbraio 1942, n. 426.
[4] Cfr. al riguardo G. Minervini, Il nuovo statuto tipo delle società calcistiche, in Riv. soc., 1967, II, 678.
[5] Gli utili andavano destinati a fini sportivi ed il patrimonio residuo, dopo lo scioglimento delle società, doveva essere devoluto al Fondo di assistenza CONI – FIGC.
[6] D.p.r. 2 agosto 1974, n. 530, modificato per le norme di attuazione dal d.p.r. 22 marzo 1986, n. 157.
[7] La suprema Corte ha avuto modo di rilevare che “nel regime anteriore al d.lg. 23 luglio 1999 n. 242, le federazioni sportive nazionali presentano un duplice aspetto, l’uno di natura pubblicistica, riconducibile all’esercizio in senso lato di funzioni pubbliche proprie del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), e l'altro di natura privatistica, riconnesso alle specifiche attività delle federazioni medesime, attività che, in quanto autonome, sono separate da quelle di natura pubblica e fanno capo soltanto alle dette federazioni” (Cass. 3 dicembre 2010, n. 24646, in Giust. civ., 2011, 7-8, 1753).
[8] Per un’ampia ed esaustiva ricostruzione cfr. F. Mite, Prestazione sportiva ed obblighi contrattuali dell’atleta, Ricerche di law & economics dell’Università telematica Pegaso, n. 8, Milano, 2013.
[9] C. Macrì, Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico, in Riv. dir. civ., 1981, II, p. 483; P. Verrucoli, Le società e le associazioni sportive alla luce della legge di riforma, in Riv. dir. comm., 1982, I, p. 131; C. Fois, Legge 23 marzo 1981, n. 91, sub artt. 10-13, in Nuove leggi civ., 1982, 613.
[10] Anche se si riteneva che la società non potesse attribuire al socio una somma superiore al valore nominale del suo conferimento, in quanto un diverso comportamento avrebbe violato il citato obbligo di destinazione degli utili all’attività sociale. In realtà anche prima, seppure in forme elusive, nella prassi si realizzavano plusvalenze dalle cessioni dei pacchetti di maggioranza delle società.
[11] Relativamente al contenuto, l’atto costitutivo deve prevedere: che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali; che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Relativamente al procedimento di costituzione, è previsto che prima di procedere al deposito dell’atto costitutivo la società deve ottenere l’affiliazione da una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; che gli effetti dell’affiliazione restano sospesi fino a quando, nei trenta giorni dall’iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non venga depositato l’atto costitutivo, presso la Federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate (in effetti l’art. 11 della legge n. 91/1981, come modificata dalla legge n. 586/1996, impone tale obbligo nel termine di trenta giorni dal decreto di omologazione, che deve intendersi sostituito dall’iscrizione nel Registro delle Imprese a seguito dell’abolizione dello stesso procedimento di omologazione) L’affiliazione dovrà considerarsi “una condizione prevista da una legge speciale per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto” (così come richiesto per le imprese bancarie dall’art. 14 del D. lgs. n. 385/1993). Ciò consente di ritenere che il termine di venti giorni per il deposito dell’atto costitutivo di una società sportiva professionistica, non decorrerà dalla data di stipula dell’atto costitutivo ma, ai sensi dell’art. 223 quater disp. att., “dal giorno in cui l’originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione (nel nostro caso di affiliazione) è stato consegnato al notaio”. la revoca dell’affiliazione determina l’inibizione dello svolgimento dell’attività sportiva. In relazione a tale ultima previsione, si deve considerare che la revoca dell’affiliazione può integrare una causa di scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dell’oggetto sociale, in quanto le società sportive costituiscono ipotesi di società ad oggetto esclusivo. In ogni caso è obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale.
[12] La prima a quotarsi è stata la Società Sportiva Lazio 1900 SpA, poi l'Associazione Sportiva Roma Spa e infine la Juventus Football Club Spa. Al riguardo M. Stella Richter jr., Considerazioni sulle società sportive quotate, in Rds, 2008, 361 s., che con una sagace ed epifanica considerazione rilevava sulla base dei dati borsistici che “fino a qualche tempo addietro non era revocabile in dubbio che tra i vari modi di perdere soldi il più rischioso fosse il gioco (dal momento che giocando d’azzardo si può anche vincere), il più piacevole le donne e il più sicuro l’agricoltura. La quotazione in borsa di alcune società sportive ha peraltro messo in crisi questa granitica certezza, dal momento che l’investimento nel capitale di rischio di questo tipo di società, più che non adatto a vedove e orfani come fu detto da un già presidente della Consob e già commissario della F.I.G.C., si appalesa, almeno in Italia, contendere alla attività agricola la palma di tecnica più certa per perdere i propri quattrini”.
[13] Art. 90 della legge n. 289/2002.
[14] Legge di conversione del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72.
[15] Per le attività dilettantistiche, le possibilità di organizzazione - offerte dall’art. 90 della legge n. 289/2002, per come modificata dalla legge n. 128/2004 - sono le seguenti: associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361; società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro e con l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio, in caso di scioglimento delle società o delle associazioni.. Se si utilizza una delle forme organizzative sopra indicate possono essere conseguiti i benefici fiscali, previsti dallo stesso articolo 90 della legge n. 289/2002. In considerazione di ciò, sarà sicuramente legittimo l’utilizzo di una diversa forma organizzativa (es. società per azioni con scopo di lucro), che però impedirà il conseguimento dei benefici fiscali e la possibilità di ottenere il riconoscimento, da parte del CONI, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 186/2004.
[16] In conseguenza di tali modifiche, al fine di evitare l’indebita fruizione delle agevolazioni fiscali anche ad associazioni e società sportive non riconosciute dal CONI, è stato emanato il D.L. n. 136, in data 28 maggio 2004, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186, il cui articolo 7 dispone che “il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”. Pertanto, le agevolazioni fiscali, previste per il settore, presuppongono l’avvenuto riconoscimento, ai fini sportivi, rilasciato dal CONI, “quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale”.
[17] L’esclusione dello scopo lucrativo rende inapplicabili alle società le norme che presuppongono la distribuzione degli utili, quali ad es. la quotazione in mercati regolamentati, l’emissione di azioni privilegiate o correlate. Mentre è ammissibile l’emissione di obbligazioni o titoli di debito, di azioni postergate nelle perdite, di azioni con prestazioni accessorie, la costituzione di patrimoni destinati, ex art. 2447 bis; l’emissione di strumenti finanziari partecipativi.
[18] Le licenze sono dirette a obbligare le società a migliorare il livello di qualità della gestione attraverso la fissazione di una serie di requisiti che devono essere rispettati dalle società calcistiche per essere ammesse a partecipare alle competizioni europee. La finalità perseguita non è quindi imporre restrizioni alle federazioni e alle leghe, oppure rendere più difficile la partecipazione delle società alle competizioni europee, bensì favorire la crescita organizzativa e gestionale dell’intero sistema calcistico europeo. Il Manuale per l’ottenimento delle licenze oltre a funzionare da guida operativa, rappresenta per le società un punto di riferimento per migliorare i propri standard qualitativi e quantitativi nel campo della gestione delle infrastrutture, della promozione dell'attività giovanile, della gestione economico-finanziaria, dell'offerta dei servizi ai tifosi e dell'organizzazione interna. Al fine del conseguimento della licenza, i club devono rispettare una serie di criteri, fissati dalla Uefa, che riguardano i principali ambiti gestionali di una società calcistica. In particolare, tali criteri sono classificati in cinque macro-categorie (sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari) e ordinati al loro interno secondi tre gradi di importanza, ossia dalla necessarietà alle mere best practices.
[19] Le società di calcio professionistiche, oltre ai controlli della Federazione nazionale, sono come noto sottoposte anche ai controlli della Federazione europea (l’Uefa), cioè l'ente che organizza le due principali competizioni per club che coinvolgono squadre europee: la Champions League e l'Europa League. I controlli dell’Uefa si sostanziano da un lato nell'ottenimento da parte del club di una particolare licenza che consente la partecipazione ai tornei internazionali, dall'altro nel rispetto di alcune regole di correttezza finanziaria (c.d. fair play finanziario). Cfr. al riguardo AA.VV., The European Club Licensing Benchmarking Report, Uefa, Nyon, 2013.
[20] Anche in giurisprudenza si è rilevato che “per partecipare al campionato professionistico occorre essere una società professionistica; ne consegue che la società dilettantistica deve mutare per tempo il proprio statuto. Se la società dilettantistica condizionasse l’efficacia della propria domanda ad un fatto futuro ed incerto quale quello della modifica statutaria, dal momento che i tempi di preparazione dei calendari agonistici sono molto ristretti, si subordinerebbero le scelte delle altre società utilmente collocate in graduatoria alle determinazioni non certe della società che ancora non possiede i requisiti introducendo, così, un requisito di incertezza per le altre concorrenti circa le scelte da operare in tema di rafforzamento o meno della squadra. In sostanza, verrebbe ad essere introdotto un profilo di disparità di trattamento e di violazione dei principi della "par condicio" che presiedono alle procedure di natura paraconcorsuale quale quella di specie (Cons. Stato, 7 aprile 2010, n. 1975, inDiritto e Giustizia online 2010).
[21] Sul tema cfr. C. Macrì, La vicenda delle società sportive: dal diritto speciale al diritto comune, in Studium juris, 1997, 3 s.
[22] Già U. Apice, La società sportiva: dentro o fuori al codice civile, in Riv. dir. fall., 1986, 538 s.
[23] Cfr. F. Cossu, L’evoluzione normativa delle società sportive, Riv. not., 2000,I, 1361.
[24] Sul regime precedente, sulla natura della società sportiva e sull’assoggettamento a fallimento, si vedano tra gli altri: U. Apice, op. cit., 539 s.; G. Ragusa maggiore, La società sportiva e la responsabilità dell’interprete, in Dir. fall., 1984, II, 1651, in calce a Trib. Napoli, 6 maggio 1982; S. Landolfi, La nuova società sportiva, in Società, 1985, 15; G. Marasà, Società sportive e società di diritto speciale, in Riv. soc. 1982, 493; R. Rordorf, nota a Trib. L’Aquila 11 maggio 1985, in Società, 1985, 1311; R. Millozza, Il fallimento delle società sportive di calcio, nota a Trib. Venezia 4 giugno 1984, in Fallimento, 1985, 196.
[25] Dalle regole del c.d. fair play finanziario emerge per l’Uefa sia fondamentale l’investimento in strutture di proprietà, poiché ha deciso di escludere i costi derivanti da tale investimento (ammortamento e oneri finanziari) dal calcolo del pareggio di bilancio.
[26] Si è rilevato qualche anno fa come i campionati e le coppe italiane ed europee in cui gareggiano le squadre di quelle società sono sempre concepiti e organizzati in modo da rendere sempre più ricchi i club che vincono e quindi in modo diametralmente opposto a quello richiesto dalle esigenze concorrenziali dello specifico mercato. L’assenza di meccanismi di riequilibrio può rendere le competizioni meno avvincente e il mercato sempre meno concorrenziale (M. Stella Richter jr., op. cit., 362).
[27] Nel 1473 scriveva “è dura la vita a Firenze per l’uomo ricco a meno che non controlli i poteri dello stato. E’ una strategia, quella di utilizzare la visibilità pubblica per ossigenare gli interessi privati, che Lorenzo perseguì nei 23 anni in cui si trovò a gestire la banca di famiglia” (già in F. Fimmanò, I gap di informazione e controllo nei crac Cirio e Parmalat e le prospettive di riforma, in Società, 2004, n. 4).
[28] La giurisprudenza di merito ha evidenziato che in tema di redazione del bilancio di esercizio da parte delle società calcistiche, venuto meno per effetto della L. n. 91/1981 il c.d. ‘‘vincolo sportivo’’, il diritto di una società di calcio di utilizzare le prestazioni di un giocatore trova fondamento in un contratto concluso tra il giocatore e la società. In ordine alla rappresentazione degli effetti contabili relativi a detto contratto trovano applicazione gli ordinari principi di redazione del bilancio di esercizio e le norme speciali applicabili per il settore e quelle definite dalla F.I.G.C. (Trib. Napoli 25 febbraio 2010, in Società, 2011, 772).
[29] Il c.d. ‘‘lodo Petrucci’’ (dal nome del coevo presidente del CONI che propose la norma, Gianni Petrucci) è una particolare procedura che, nel caso dell’esclusione dai campionati professionistici e conseguente revoca dell’affiliazione per motivi legati ai requisiti economici e contabili di una società di calcio, era diretto a non disperdere il patrimonio sportivo cittadino consentendo ad una nuova società che desiderasse rilevarne il titolo sportivo, di partire da una categoria ancora professionistica seppur inferiore rispetto a quella conquistata sul campo (quella immediatamente sottostante nella versione originaria). Il Lodo fu approvato dal Consiglio Federale della FIGC il 14 maggio 2004, poi modificato col caso Napoli, mentre nel corso del Consiglio del 5 maggio 2008 si decise un inasprimento dei requisiti di accesso. All’attuale procedimento previsto dalle Noif è dedicato l’ultimo paragrafo del saggio.
[30] Ormai anche i calciatori professionisti che hanno la cittadinanza di un Paese terzo con il quale però la Comunità europea ha concluso un accordo di associazione, hanno diritto a essere assunti e impiegati nelle partite di calcio alle stesse condizioni dei cittadini comunitari. Le federazioni sportive nazionali non possono limitare l’impiego da parte di una società sportiva comunitaria di giocatori originari di Paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi. Le norme dell'accordo di associazione che affermano il principio di non discriminazione devono essere applicate, se chiare e sufficientemente precise, direttamente dai giudici nazionali (Corte giustizia UE, 25 luglio 2008, n. 152, in Guida al diritto 2008, 34, 108).
[31] Si è efficacemente osservato che la stessa espressione impresa sportiva, che costituisce l’oggetto della attività economica di queste società, è un ossimoro. Sport infatti significa in inglese divertimento, gioco, passatempo, ed è “sinonimo di fun, amusement, diversion, game, pastime; si dice to make sport of come espressione equivalente a to make fun off. La parola sport ha la stessa radice del nostro diporto, ed è qualcosa che sta agli inglesi come gli otia stavano ai romani. È quindi definitivamente accertato che se lo sport diviene oggetto di negotium o di negotia, di attività professionale, economica o di attività di impresa, che dire si voglia, non è più sport e che dunque si ha a che fare, già dal punto di vista letterale, con un vero e proprio controsenso” (M. Stella Richter jr, op. cit., 361).
[32] Del resto, che il decreto distorcesse la concorrenza era evidente fin dal primo momento: in primo luogo tra società di differenti discipline, che concorrono nel medesimo mercato degli spettatori, dei telespettatori, delle sponsorizzazioni, dei diritti televisivi; in secondo luogo tra società calcistiche dei diversi paesi europei che operano nel mercato unico. Discriminatorio era peraltro concedere benefici fiscali ad una sola tipologia di società quotate in Borsa, visto che molte società calcistiche lo sono, distorcendo in questo modo anche il mercato (e da questo punto di vista estremamente opinabile è stata l’applicazione della normativa sulla possibilità di rateizzare i debiti tributari, oggetto delle controversie del “campionato giudiziario” di qualche anno fa che riguardò la Lazio).
[33] Determinante in positivo ed in negativo è soprattutto la Serie A, che con un fatturato complessivo di 1,639 miliardi di euro nel 2012 è al 95mo posto nella classifica dei gruppi industriali più ricchi d'Italia in termini di ricavi. I ricavi totali delle venti società (senza calcolare le plusvalenze derivanti dalla cessione dei contratti dei calciatori) sono stati pari a 1.639,8 milioni di euro, il 55,9% dei quali prodotti dalle prime cinque squadre. In testa alla classifica del fatturato si posiziona il Milan con un giro d'affari annuo di 243,2 milioni, seguito da Inter (205,8 milioni), Juventus (198,6 milioni), Napoli (150,9 milioni) e Roma (118,5). I dati sono tratti dallo studio «Report calcio 2013», elaborato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in collaborazione con Arel e PriceWaterhouseCoopers.
[34] Al riguardo ampiamente: M. Nicoliello, Il monitoraggio di figc e uefa sulle società di calcio italiane: scenario attuale e possibili evoluzioni, in Riv. Dott. Comm., 2014, 35 s.
[35] La verifica riguarda i debiti scaduti verso le società concorrenti, verso i calciatori, verso il Fisco e gli enti previdenziali. I club devono quindi dimostrare di onorare tutte le loro pendenze e di non avere debiti pregressi non pagati. Il sistema del break-even, in vigore da quest’anno, computa invece per ciascun periodo la somma dei risultati del triennio precedente. La norma prevede che le società possano registrare in ciascun periodo al massimo una perdita d’esercizio di 5 milioni di euro, che può essere superato soltanto se la perdita viene ripianata con aumenti di capitale da parte dei soci, oppure con donazioni derivanti da parti correlate: entrambe da effettuare nel medesimo periodo. In questo caso vengono comunque fissati tetti al deficit. Nei periodi 2013/14 (bilanci 2012 e 2013) e 2014/15 (bilanci 2012, 2013 e 2014) la perdita complessiva consentita è di 45 milioni di euro. Nei periodi 2015/16, 2016/17 e 2017/18 è consentito un deficit massimo di 30 milioni di euro. Dal 2018 in poi l’obiettivo è il pareggio di bilancio, fatta salva la possibilità che l’Uefa indichi in futuro una soglia massima di deficit consentito. Nel calcolo “del break-even, tra i ricavi sono compresi proventi da stadio, diritti televisivi, sponsorizzazioni e attività commerciali, plusvalenze nette sui diritti pluriennali. Tra i costi si computano oltre agli acquisti e ai costi operativi, anche gli stipendi dei calciatori e dei tecnici e l'ammortamento dei diritti pluriennali. Non sono invece compresi nei costi: gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (lo stadio di proprietà), le spese per il settore giovanile e quelle destinate ad attività sociali, gli interessi passivi legati alla costruzione dello stadio che non sono capitalizzati nel valore dell'asset. È previsto, infine, che entrambe le categorie siano poi rettificate in base al loro fair value. Il rispetto di queste regole da parte dei club viene monitorato da un panel di esperti, che in caso di violazioni può istruire un procedimento dinanzi alla Commissione disciplinare. L'organo di controllo finanziario dell’Uefa può anche chiedere ai club che il bilancio rispetti alcuni limiti nelle spese per dipendenti e nella misura della posizione finanziaria netta,net debt” (M. Nicoliello, op.cit., 44 s.).
[36] Sulle federazioni cfr. da ultimo L. Di Nella, Le attività economiche delle federazioni sportive: problemi e prospettive, in Rass. dir. econ. sport, 2006, 47 s.
[37] Al riguardo cfr. P. Pollice, Il controllo giudiziario sulle società sportive, in Riv. di diritto dell'impresa, 1999, 49 s.; A. Trillò, Applicabilità del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. alle società sportive (nota a sent. Trib. Genova 22 aprile 1985, PM), in Riv.dir.comm. 1987,519In giurisprudenza cfr.Trib. Ravenna, 9 marzo 1999, FIGC c. Soc. U.S. Ravenna, in Foro it. , 1999, I,2735; Trib. Ravenna, 14 settembre 1994 Soc. Unione sport. Ravenna c. Coni e altro; in Foro it., 1994, I,3532; Trib. Napoli, 10 giugno 1994 P.M. c. Soc. sportiva calcio Napoli, in Riv. dir. sport., 1994, 690, in Foro it., 1995, I,3328; Trib. Catania, 18 maggio 1991, in Vita not., 1993, 354, in Foro it., 1992, I, 2515; Trib. Udine, 14 luglio 1990, P.M. c. Società Udinese calcio, in Foro it., 1991, I,1945., in Foro amm., 1991, fasc. 7-8., in Riv. dir. comm., 1991, II,347.
[38] In particolare secondo una giurisprudenza di merito ante riforma: “Il potere di denuncia ex art. 2409 c.c non sarebbe inerente all'azione, ma alla quota di partecipazione al capitale sociale, cioè ad un interesse sostanziale che può anche derivare dal possesso azionario risultante dalla girata, anziché dall’intestazione dell’azione conseguente all’iscrizione del giratario nel libro soci (Trib. Venezia, 25 marzo 1986 in Società, 1986, 889, con nota di Salafia).
[39] Tribunale Catania, 20 luglio 1992 Massimino e altro, in Foro it., 1993, I, 597.
[40] I fatti di «Calciopoli» hanno dato origine sia a procedimenti davanti agli organi di Giustizia Sportiva (CAF e Corte Federale e Camera di Conciliazione presso la FIGC e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), sia dinanzi al Tribunale penale di Napoli. Contemporaneamente la Procura regionale della corte dei conti del Lazio ha convenuto in giudizio alcuni dei soggetti coinvolti, contestando le conseguenze negative per l’immagine dello sport. In particolare, la condotta dei convenuti avrebbe determinato una grave lesione della dignità, del decoro e del pregiudizio dell’ordinamento sportivo che si è tradotta in un danno all'immagine di rilevante entità, avendo una vasta eco e provocando una perdita di fiducia degli organismi internazionali e dell'opinione pubblica nei confronti del calcio italiano. La Corte, ricorrendo a una valutazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c., ha condannato i due designatori arbitrali; il Vice Presidente della FIGC, ogni arbitro è stato condannato in proporzione alle responsabilità accertate, mentre le condanne più lievi sono state inflitte agli assistenti di gara. La Sezione regionale, ancora prima, con due sentenze non definitive, nn. 872 e 873 dell’11 maggio 2009, aveva dichiarato la propria giurisdizione con riguardo al CONI, alle Federazioni sportive, all'Associazione Italiana Arbitri (declinandola, invece, nei confronti dei giornalisti RAI) all’esito di un percorso basato sull’assetto normativo dell'Ordinamento sportivo, istituzionalizzato nel CONI, ente sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, definito dal d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, quale autorità di disciplina, di regolazione e di gestione delle attività sportive. Al contempo, la Corte richiama i propri precedenti, relativi all’erogazione di contributi pubblici da parte del CONI ad associazioni sportive private, nei quali è stata attribuita natura pubblica all'interesse sportivo, definito bene inviolabile a livello individuale. La FIGC che nell’ambito delle funzioni del CONI rappresenta l’ente di promozione del calcio costituisce il soggetto passivo dell’azione illecita. La Corte si è soffermata sui rapporti tra il CONI e la Federazione, richiamando l’art. 15 del d.lgs. n. 242/1999 (c.d. decreto Melandri) ed evidenziando come il legislatore abbia sottolineato il carattere pubblico di specifici aspetti dell’attività svolta dalle Federazioni che sono esplicitati nella norma contenuta nell'articolo 23 dello Statuto del CONI (d.m. 23 giugno 2004) che annovera anche « il controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici e l'utilizzazione di contribuzioni pubbliche». In particolare, l’art.15, pur qualificando le Federazioni quali associazioni di diritto privato, nella sua originaria formulazione, precisava che detti enti svolgessero l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del CONI « anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività». Nello specifico, la Corte evidenzia che « l’arbitro, come iscritto all’AIA, è tenuto al rispetto delle norme federali che hanno specifica rilevanza nell’ordinamento sportivo, ma al tempo stesso partecipa all'esercizio della funzione di interesse pubblico prima ricordata demandata alla FIGC, la quale riceve dal CONI le apposite contribuzioni pubbliche». Conseguentemente, a prescindere dalla natura giuridica delle Federazioni e dell'Associazione Italiana Arbitri (che sono e rimangono associazioni di diritto privato), dalla qualificazione soggettiva assunta dall'arbitro nell'ordinamento giuridico generale, dalla natura privatistica del rapporto giuridico in base al quale l'arbitro svolge le sue prestazioni, l’elemento che àncora la condotta dell'arbitro al sindacato della Corte dei conti è l'inserimento del direttore di gara nel complesso procedimento di rilevanza pubblicistica, retto dall'utilizzo di risorse pubbliche erogate dal CONI, istituzionalmente finalizzato alla promozione del gioco del calcio, inteso come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell’educazione e della cultura nazionale e, quindi, come interesse collettivo normativamente tutelato (ma al riguardo si veda ampiamente e bene: A. Stalteri, La corte dei conti e il danno all’immagine dell’ordinamento sportivo provocato dagli arbitri di «calciopoli», in Resp. civ. e prev., fasc.1, 2013, 267). La sentenza ripercorre poi i principali orientamenti giurisprudenziali in tema di risarcibilità del danno all'immagine a favore della Pubblica Amministrazione, alla stregua di quanto fatto anche in materia di società pubbliche (al riguardo F. Fimmanò, La società in house tra giurisdizione, responsabilità ed insolvenza, in Gazz. For., 2014, 1, 12 s.; Id., La giurisdizione sulle “società pubbliche”, in Società, 2013, 974 s.).
[41] Ci riferiamo in particolare alla salvaguardia dei valori aziendali nelle società in crisi, o assoggettate a procedure concorsuali, ed all’analisi dei rapporti tra l’istituto dell’affitto dell’azienda calcistica e l’ordinamento sportivo specie in relazione a casi di insolvenza La problematica trova chiaramente spunto dalla vicenda del fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli SpA e dai relativi provvedimenti del Tribunale di Napoli (Trib. Napoli 16 Luglio 2004 ord., in Fallimento on line; e Trib. Napoli 2 agosto 2004, con nota di C. Esposito, in Riv. dir. fall., ).
[42] Già nel 1968 la suprema Corte aveva sancito la illegittimità di una delibera del Consiglio direttivo della Figc, del 16 settembre 1966, con la quale si imponeva alle 38 associazioni professionistiche all’epoca partecipanti ai campionati di calcio di serie A e B di costituirsi in forma di Spa in quanto ledeva “posizioni di diritto soggettivo delle associazioni affiliate” (Cass, sez. un., 19 giugno 1968, n. 2028, in Foro amm., 1969, I, 1, p. 16 e in Riv. dir. sport., 1968, p. 290, richiamata in U. Apice, La società sportiva: dentro o fuori al codice civile cit., p. 540). Pare leggere, come vedremo, un estratto dell’art. 1 del d.l. 220 del 2003.
[43] Di grande interesse è al riguardo la ricostruzione di P. Grossi, Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, in Dir. amm., fasc.1-2, 2012, 3, che richiama Suprema Corte di Cassazione (Sez. Un. Civ. 18052 del 2010), in una pronuncia che riprende la sentenza delle Sez. Un. Civ. 5775/2004, la quale — a sua volta — si rifaceva a sentenze del 1989 e, quindi, ben precedenti alla normativa del 2003, pur dichiarando inammissibile il ricorso perché veniva ad investire il merito, accoglie il principio informatore del Decreto Legge del 2003. Riguardo alle regole tecniche interne all'ordinamento sportivo, dopo aver precisato che “la generale irrilevanza per l’ordinamento statale di tali norme e delle loro violazioni conduce all'assenza di una tutela giurisdizionale statale”, aggiunge che “la suddetta disciplina non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato”. La Suprema Corte, che si arresta alla soglia liminale della inammissibilità, individua però il problema centrale, che “è quello di stabilire se tale controversia, originata... dalla decisione di una federazione sportiva nazionale di ridimensionare il numero degli arbitri effettivi, sia riservata, o meno, all'autonomia dell'ordinamento sportivo e, in quanto tale, sottratta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria”. Il Consiglio di Stato affronta il merito in una sentenza del 2008 (5782), che viene ripresa nella 2333 del 2009: la norma del 2003 “ha inteso tracciare una linea di confine netta fra i territori rispettivamente riservati all'ordinamento sportivo e ai suoi organi di giustizia e quelli nei quali è possibile l'intervento della giurisdizione statale”. Dunque, “la giustizia statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi e interessi legittimi”. Il supremo giudice amministrativo, che non manca di esprimere alcune perplessità proprio sulle controversie c. d. disciplinari che più fanno emergere un conflitto tra valori rilevanti, è sicuro nella scelta “di decidere sulla domanda risarcitoria”; poiché “la domanda risarcitoria non è proponibile innanzi agli organi della giustizia sportiva (ai quali si può chiedere solo l'annullamento della sanzione)”, e si sarebbe venuto a creare “un vero e proprio vuoto di tutela”. La conclusione del Consiglio di Stato, che applica la previsione dell'art. 3 della normativa del 2003, è anche quella fatta propria dalla Corte Costituzionale nella sentenza 49 del 2011 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio, riconoscendo però al giudice amministrativo la cognizione sulle sanzioni disciplinari al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione.
[44] Decreto convertito in Legge in data 17 ottobre 2003 (cfr. al riguardo G. Arieta, Prime considerazioni sulla l. n. 280 del 2003, in Rass. dir. econ. sport, 2006, 5 s.
[45] La legislazione fu emanata a seguito del c.d. caso Catania. Alla fine della stagione 2002\2003, il calcio Catania 1946 Spa retrocede in Serie C1, ma poi viene riammesso in seguito ad una serie di vicissitudini giudiziarie concluse con il provvedimento legislativo in oggetto.
[46] In altri termini, sempre nella logica della tutela del principio di autonomia, e sempre compatibilmente con i limiti posti in sede di principi generali dal predetto art. 1, comma 2, la legge 280/03, si è preoccupata di definire i parametri afferenti alla giurisdizione ed alla competenza di tutte le controversie che non si sostanzino in situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento della Repubblica e nel contempo non ricadano nell’alveo della competenza dell’ordinamento sportivo.
[47] Esiste al riguardo ormai un’ampia casistica. La giurisprudenza ha ad esempio rilevato che “è inammissibile la diretta impugnazione in sede giurisdizionale dell’atto di formazione dei campionati di calcio, senza osservare il vincolo della cd. pregiudiziale sportiva di cui all’art. 3 comma 1 d.l. n. 220 del 2003, conv. in l. n. 280 del 2003, per non essere stati previamente percorsi i gradi della giustizia sportiva” (Cons. Stato sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002, in Resp. civ. e prev., 2013, 5, 1579). E ancora che: “l’azione risarcitoria proposta dalla curatela di una società calcistica fallita nei confronti della FIGC e della Lega Nazionale Professionisti, per omessa vigilanza sulla regolarità contabile della società assoggettata a fallimento, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del g.a. , così come previsto dall'art. 3 d.l. 19 agosto 2003 n. 220 (convertito nella l. 17 ottobre 2003 n. 280), anche dopo l'entrata in vigore del d.lg. 2 luglio 2010 n. 104 (codice del processo amministrativo) che, all'art. 4 dell'allegato 4, ha abrogato il cit. art. 3 e all'art. 133, comma 1, lett. z, ha confermato il criterio di attribuzione della giurisdizione preesistente; l'azione risarcitoria che venga proposta nei confronti di soggetti privati nella specie, ex amministratori ed ex sindaci è, invece, assoggettata alla giurisdizione del g.o.” (Cass., sez. un., 19 ottobre 2011, n. 21577, in Giust. civ. Mass., 2011, 10, 1475, in Foro amm. CDS, 2011, 12, 3628). Ed infine: ”Rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia promossa nei confronti della FIGC e della commissione di vigilanza delle società calcistiche, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’asserita illegittima ammissione di una squadra al campionato di serie A, che aveva impedito il ripescaggio di altra squadra, retrocessa in serie B alla fine della precedente stagione sportiva (Cass., sez. un., 22 novembre 2010, n. 23598, in Foro it. 2011, 10, I, 2602).
[48] La giurisprudenza amministrativa nel caso dei ripescaggi del 2005 ha affermato che “deve escludersi l’esperibilità del rimedio ex art. 2900 c.c. da parte del Fallimento mancando in capo al N.S. s.p.a. il requisito dell’essere titolare di un diritto o azione di natura patrimoniale. La posizione a tutela della quale il Fallimento agisce, in proprio e in surroga, è di interesse legittimo e si sostanzia nella mancata ammissione (per ripescaggio) del Napoli al Campionato di calcio di Serie B. Non si tratta, dunque, di un interesse di natura prettamente patrimoniale quanto, piuttosto, agonistico, anche se è indubbio che dalla partecipazione al Campionato superiore sarebbero derivati per la società indotti di carattere economico. Si tratta però di effetti solo riflessi e non strettamente ed immediatamente connessi alla situazione giuridica soggettiva che fa capo alla Napoli Soccer e che il Fallimento ritiene essere stata illegittimamente lesa dalla FIGC. L’art. 2900 c.c. richiede, perché si possa agire in surroga, non solo la qualità di creditore del soggetto agente ma anche la titolarità in capo al debitore di un diritto o azione di natura patrimoniale verso un terzo” (Tar Lazio Roma 7 giugno 2013 n. 5744, in Foro amm. TAR, 2013, 6). Analogamente la Cassazione ha statuito che “La domanda di risarcimento del danno, proposta avverso la Figc e la Commissione di vigilanza delle società calcistiche (Covisoc) per l'illegittima ammissione, da parte della Federazione, pur in mancanza dei requisiti prescritti, di altra società calcistica al campionato di calcio di Serie A, dalla quale sia derivato il mancato ‘ripescaggio’ della società attrice, retrocessa in Serie B, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi dell’art. 3 d.l. 19 agosto 2003 n. 220 (convertito nella l. 17 ottobre 2003 n. 280). Costituisce, al contrario, una controversia fra soggetti privati, devoluta al g.o., quella avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno, avanzata contro i singoli componenti della federazione sportiva e della Covisoc, nonché contro la società calcistica concorrente ed i suoi amministratori, per i comportamenti illeciti loro ascritti, che quell'illegittima iscrizione avrebbero indotto” (Cass., sez. un. 22 novembre 2010, n. 23598, in Foro it., 2011, 10, I, 2602).
[49] Così correttamente C. Esposito, op. ult. cit., secondo cui prima dell’accertamento , tale diritto è solo una “aspettativa” in quanto - prima del riconoscimento in esito all’analisi dei requisiti tecnico sportivi - essa si presenta come una posizione di attesa - fondata però sulla conquista sul campo di un determinato risultato sportivo - di un effetto acquisitivo incerto, costituito dal diritto soggettivo (diritto potestativo-titolo sportivo) rispetto al quale ne costituisce uno stadio anteriore quale posizione meramente strumentale rispetto ad una situazione finale incerta.
[50] G.Niccolò, Istituzioni di diritto privato, Milano 1969, 45.
[51] Si è affermato che prima di dubitare della legittimità costituzionale di quelle norme, che comporterebbero una sorta di “espropriazione senza indennizzo”, bisognerebbe accertarsi che il titolo sportivo appartenga alla società (er una critica alla soluzione positiva data dal diritto sportivo F. Lubrano, Ammissione ai campionati di calcio e titolo sportivo: un sistema da rivedere?”, in A.G.E., 2/2005, 449 s.). In realtà come si è visto il problema non è la proprietà del titolo, pur volendo ritenere che non è un diritto potestativo il quadro nella circolazione dell’azienda non cambia.
[52] Cfr. Cass. 9 giugno 1981, n. 3723, in Giust. civ., 1981, I, p. 2492, secondo la quale “Poichè l’azienda è un complesso di beni e di servizi, capitale, fisso e circolante, e lavoro unificati dalla unitaria destinazione produttiva, in funzione della quale sono organizzati e coordinati dall’imprenditore, essa cessa di esistere quando i vari elementi siano stati dispersi, assumendo i singoli beni destinazioni diverse”. Al riguardo cfr. pure G. Ragusa Maggiore, La cessazione dell’impresa commerciale e il fallimento (art. 10 L.F.), in Riv. dir. civ., 1977, I, 172 .
[53] Al riguardo mi permetto di rinviare a F. Fimmanò, Contratti d’impresa in corso di esecuzione e concordato preventivo in continuità, in Dir. Fall., 2014, I, 216 s.; Id., Sub Art. 104, in Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. Jorio, Vol. II, Torino, 2007, 1582 s.
[54] Mi permetto di rinviare a F. Fimmanò, Prove tecniche di esercizio provvisorio riformato, in Giur. comm., 2007, I,759 s.; Id.,L’impresa in crisi come oggetto “proprio” della tutela cautelare, in Diritto delle Imprese in crisi e tutela cautelare, a cura di F. Fimmanò, Ricerche di law & economics dell’Università telematica Pegaso, n. 8, Milano, 2012, 1 s.
[55] Al riguardo cfr. G. Schiavon, Profili dell’insolvenza delle società sportive ( anche alla luce del cosiddetto Lodo Petrucci), in Dir. Fall. 2004, 295 s.. L’ipotesi prospettata dall’art.16 delle NOIF ha avuto concreta attuazione nell’ambito del fallimento del Monza calcio spa, ove il tribunale fallimentare ha dapprima disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa fino al termine del campionato di calcio in corso e poi successivamente con ordinanza del 27 maggio 2004, www.fallimento.ipsoa.it. ha disposto la vendita dell’azienda motivando tale decisione con la necessità di garantire “…il miglior risultato sul piano prettamente economico dei valori realizzabili e quindi rispondente all’interesse della massa dei creditori, assicurando nel contempo la continuità dell’attività già oggetto dell’impresa fallita …e la tutela dell’interesse dei dipendenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro nonché con riferimento all’aspettativa diffusa ( certamente non qualificata sul piano giuridico ma non per questo non meritevole di considerazione sia pure nel limite della compatibilità con le finalità prevalenti di una procedura concorsuale ) alla conservazione della squadra di calcio ….”.
[56] Sul tema F. Fimmanò, L’affitto endofallimentare dell’azienda, in Dir. fall., 2007, I, 437 s.
[57] Cui è dedicato l’ultima parte di F. Fimmanò, La vendita fallimentare dell’azienda, in Contratto e Impresa, 2007,
[58] In passato, la mancata previsione normativa di tale rimedio (frutto della meritoria opera della prassi fallimentare) ha suscitato dubbi sull’ammissibilità e sulla disciplina eventualmente applicabile. Poi la legge n. 49, del 27 febbraio 1985, e la legge n. 223, del 23 luglio 1991 (F. Fimmanò, Fallimento e circolazione dell’azienda socialmente rilevante, Milano, 2000). seppure in modo incidentale e per taluni versi speciale, e poi la riforma del diritto fallimentare hanno dato inquadramento normativo alla fattispecie e si è usciti da quello stato di agnosticismo legislativo che aveva caratterizzato il tema. Il legislatore, ha sancito espressamente l’ammissibilità dell’affitto e della vendita unitaria del complesso aziendale nel fallimento, ed ha legato funzionalmente i due istituti utilizzando come giuntura l’eventuale diritto di prelazione a favore dell’affittuario in funzione della successiva alienazione. Questo sistema di liquidazione dell’azienda, in sede concorsuale, diviene così uno strumento ordinario di soluzione dell’insolvenza e, laddove possibile, una scelta privilegiata fra quelle a disposizione degli organi della procedura.
[59] Si veda, per quanto attiene al caso del Parma Calcio, G. Schiavon, Il caso del Parma calcio: distonia applicativa dei principi di diritto concorsuale in sede di giustizia sportiva ?, Dir. fall. 2004, 1123.
[60] Il comma 8, dell’art. 105, l.fall., prevede infatti che “il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell’azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell’alienante ai sensi dell’art. 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente Sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali”. Orbene a parte il fatto che il termine liquidazione comprende molto probabilmente anche la fase propedeutica alla stessa (e quindi gli strumenti di gestione conservativa come dimostra l’aver contemplato nel programma di liquidazione affitto ed esercizio provvisorio e l’aver collocato questi istituti nel Capo VI della legge) non vi sarebbe comunque nessuna controindicazione ad utilizzare un modello funzionale alla successiva vendita per finalità gestorie preparatorie e propedeutiche alla più proficua realizzazione della stessa. Chiaramente questa scelta dovrebbe seguire il medesimo procedimento richiesto per le modalità gestorie tipiche e quindi lo specifico consenso espresso del comitato dei creditori. In buona sostanza il curatore dopo averlo eventualmente previsto nel programma di liquidazione e col parere favorevole del comitato dei creditori potrebbe essere autorizzato a conferire l’azienda sportiva, o rami della stessa in una società, che potrebbe rimanere statica in prospettiva della vendita, o laddove appaia opportuno, divenire almeno fino alla cessione un veicolo dinamico anche per l’esercizio concreto dell’attività economica con amministratori che rappresentino una diretta promanazione della procedura. D’altra parte come normalmente accade quando nel patrimonio fallimentare siano comprese partecipazioni maggioritarie o qualificate di società in bonis, rispetto alle quali la procedura esercita i diritti di socio, a cominciare dalla nomina in assemblea degli amministratori, fino al momento della vendita a terzi. Le ragioni di una scelta di questo tipo possono risiedere nelle normali controindicazioni all’esercizio provvisorio ed all’affitto. La segregazione attuata con la costituzione di un apposito veicolo societario evita le potenziali conseguenze negative derivanti dall’assunzione di debiti in prededuzione che potrebbero, nel caso in cui l’attività economica gestita dal curatore andasse male, pregiudicare in modo irreversibile la massa. Dall’altro lato l’affitto può presentare l’oggettivo svantaggio che l’affittuario (in linea di principio) non ha in genere particolare interesse a valorizzare l’azienda, anzi ha un potenziale interesse a deprimerne il valore, in modo da evitare che il prezzo di vendita lieviti troppo in relazione ad una procedura competitiva alla quale comunque è rimessa la liquidazione anche nel caso in cui gli venga riconosciuto il diritto di prelazione in via convenzionale (prelazione che comunque rimane un mero diritto ad essere preferito a parità di condizioni). Inoltre la gestione mediante una società direttamente controllata consente quegli interventi per così dire “autoritativi”, fino ad arrivare all’interruzione nei casi in cui la prosecuzione si presenti dannosa per i creditori o per la vendita, che in caso di affitto non è possibile obbligando gli organi a ricorrere all’autorità giudiziaria in sede contenziosa (per una più ampia disamina al riguardo mi permetto il rinvio a F.Fimmanò, L’allocazione efficiente dell’impresa in crisi mediante la trasformazione dei creditori in soci, in Riv. soc., 2010, 150 s.).
[61] Cass., sez. unite, 1 ottobre 1993, n. 9802, Cons. bonif. piana Catania c. Soc. S. Nicola, in Mass., 1993.
[62] Cfr. gli artt. 2112, 2555, 2562, 2565, 2573, 2610 del cod. civ. e l’art. 670, n. 1, c.p.c.,. Si è evidenziato che l’interesse di chi organizza un’azienda è quello di trarre un possibile guadagno dall’esercizio di un’attività che si avvalga, strumentalmente, del complesso organizzato e non certo quello di trarre dai singoli beni le occasioni di godimento diretto (tipiche dello schema della proprietà). E’ possibile, in questo modo, scorgere nella posizione dell’imprenditore rispetto alla sua azienda una situazione soggettiva assoluta ed esclusiva che ha come punto di riferimento oggettivo non il mero aggregato di beni, ma l’azienda nel suo aspetto dinamico, ossia in quanto entità suscettibile di essere goduta mediante lo svolgimento di un’attività economica. (O.T. Scozzafava, I beni e le forme giuridiche di appartenenza, Milano, 1982, p. 497 s.).
[63] L’impresa, quale attività economica organizzata 'per la gestione di un’azienda, è inseparabile dall’imprenditore, di cui costituisce un modo di operare, sicchè pur non confondendosi con costui, ha carattere eminentemente soggettivo ed è, perciò, estranea al contenuto obiettivo dell’azienda, che da sola può essere oggetto di rapporti giuridici' (Cass. 22 gennaio 1983, n. 623, in Giust. Civ., 1983, I, 3014).
[64] In tal senso M. Casanova, voce Azienda, cit., p. 7; P. Forchielli, Il minimum del concetto di azienda e la distinzione tra affitto d’azienda (libero) e locazione d’immobile non abitativo (vincolata), in Riv. dir. civ., 1980, I, 522, il quale con suggestiva similitudine rileva che l’azienda è, per così dire, figlia dell’imprenditore; e ciò in senso non molto diverso da come si può dire che la pertinenza, attraverso l’atto di destinazione, è figlia del proprietario (art. 817 c.c.) o che la servitù, attraverso sempre la 'destinazione' è figlia del 'padre di famiglia' (art. 1062 c.c.). V’è poi chi ha affermato (Rossi G., Persona giuridica, proprietà e rischio d’impresa, Milano, 1967. p. 14), che il bene è posto a servizio dell’impresa mediante un atto di destinazione che prescinde dalla proprietà o da altri rapporti giuridici, sicché un titolo può sussistere come può anche non sussistere. Dal punto di vista dell’impresa, il bene ha quindi risalto solo come una cosa posseduta (in senso lato).
[65] Anche l’avviamento che è una delle componenti aziendali più tipiche ed originali acquista rilevanza giuridica solo in caso di circolazione dell’azienda (art. 2427, c.c.).
[66] Vedi sul punto G. C. Rivolta, Il trasferimento volontario d’azienda nell’ultimo libro di Domenico Pettiti, in Riv. dir. civ., 1973, I, 15; G. E. Colombo, Il trasferimento dell’azienda ed il passaggio dei crediti e dei debiti, Padova, 1972. Si è opportunamente osservato che “non esistono beni aventi una funzione costantemente identificatrice dell’azienda. Nemmeno la ditta o il marchio che pur assumono una importanza tutta particolare nell’economia dell’organizzazione dell’imprenditore, possono valere come indici....” (così D. Pettiti, Il Trasferimento volontario d’azienda, Napoli, 1970, 185).
[67] Al riguardo si è rilevato che esiste un ordinario collegamento fra trasferimento d’azienda e successione nell’impresa e nel caso di trasferimento la successione rappresenta solo un’eventualità, visto che ad esempio l’azienda potrebbe essere acquisita al solo fine di smantellarla ed utilizzarne i singoli elementi (A. Graziani, L’impresa e l’imprenditore, Napoli, 1959, p. 85 s.).
[68] Sull’argomento esaustivamente M.S. Spolidoro, Conferimento di ramo d’azienda (considerazioni su fattispecie e disciplina applicabile), in Giur. comm., 1993, p. 692 s., ed S. Delogu, Cessione di quota d’azienda, in Contr. impr., 1994, 505 s..
[69] E’ evidente che, per quanto rilevato, il ramo acquisisce rilevanza autonoma solo al momento del perfezionamento dell’atto dispositivo e fino a quel momento il suo rilievo è meramente concettuale In tal senso P. Masi, Articolazioni dell’iniziativa economica, Napoli, 1985, 157. In giurisprudenza tra le altre Cass. 11 agosto 1990, n. 8219, in Giur. it., I, 1, c. 584 s. con nota di Sanzo.
[70] R. Bracco, L’impresa nel sistema del diritto commerciale, Padova, 1960, 474 s.; D. Pettiti, Il Trasferimento volontario d’azienda, cit.,130 s.; M. Grandi, Le modificazioni del rapporto di lavoro, Milano 1972, 299 s., G. E. Colombo, L’azienda, cit., 19 s. (il quale parte da una rigorosa lettura della nozione di beni ex art. 2555, c.c.) ritengono che l’azienda comprenda i soli beni in senso stretto.
[71] Cass. 21 novembre 1968, n. 3780, in Foro it., 1969, I, 1243 s.; Cass. 23 luglio 1983, n. 5112, in Rep. Foro it., 1983, voce Azienda, c. 282 n. 3.
[72] Per altri il complesso aziendale comprenderebbe accanto ai beni i soli rapporti di lavoro con esclusione degli altri rapporti giuridici (cfr. G. Romano Pavoni, La disciplina dell’azienda e la successione ex art. 2558 c.c. nel contratto di locazione, in Riv. dir. ind., 1952,II, 155; G. Ferrari, Azienda, cit., 683 ).
[73] Cfr. Trib. Reggio Emilia 23 marzo 1988, in Giur. merito, 1998, I, p. 900 s. con nota di G. Scardillo, In tema di trasferimento d’azienda in crisi e disciplina ex art. 2112, c.c.,.
[74] In pratica questi rapporti giuridici costituirebbero la relazione attraverso cui i beni del complesso aziendale si collegano all’organizzazione ed il cui trasferimento andrebbe imputato direttamente all’art. 2555, c.c., e non alla previsione di cui all’art. 2558 c.c.
[75] Giuridicamente rilevante ex artt. 230 bis, 2424 n. 5, 2426 n. 6, del codice civile ed ex art. 34, legge 392 del 1978.
[76] Per G. Auletta, Avviamento commerciale, in Enc. giur. IV, 5, “l’avviamento è la qualità costitutiva dell’azienda, cioè la qualità per cui la stessa soddisfa un nuovo interesse e quindi costituisce un bene ed acquista un valore”. Secondo la Cassazione (26 luglio 1978, n. 3754, cit. p. 880) l’azienda non viene meno se manca l’avviamento per cui è perfettamente ipotizzabile la cessione di un’azienda inattiva (nello stesso senso R. Nobili, voce Avviamento d’impresa, in Noviss. Digesto it., I, Torino, 1958, 1568).
[77] T. Ravà, Diritto industriale, I, Torino, 1973, p. 273; G. Azzariti, Cessione di esattoria comunale e avviamento commerciale, in Giur. it., 1980, IV, 77 s.; Cass 5 luglio 1968, n. 2558, in Riv. dir. ind., 1970, II, 39. Per i quali un’azienda senza avviamento può esistere solo se è stata appena costituita e non è ancora entrata in attività, oppure quando si trovi nella fase di liquidazione che ne precede la scomparsa.
[78] B. Biondi, I Beni, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, IV, Torino, 1953, p. 42; Cass. 26 gennaio 1971, n. 174, in Foro it., 1971, I, 346.
[79] G. Santini, I diritti della personalità cit., 105; D. Messinetti, La tutela dell’avviamento nei suoi aspetti civilistici, in Riv. dir. comm., 1967, I, 140.
[80] L’azienda potrà rimanere provvisoriamente ferma, ma non solo per questo perderà la qualità tecnica di azienda, almeno sino a quando manterrà in sé quel minimo di coesione e di potenzialità che lascino prevedere una ripresa della sua tipica attività (in questo senso anche Cass. 7 ottobre 1975, n. 3178, in Giur. it., 1976, I, 1, 1184).
[81] G. Auletta, voce “Clientela”, in Enc. Dir., VII, Milano 1960, 202 s.
[82] F. Santoro Passarelli, L’impresa nel sistema del diritto civile, in Riv. dir. comm., 1939, I, 403.
[83] Ipotesi diversa è invece quella di azienda dotata di concessione amministrativa che può cioè svolgere quelle attività riservate per legge all’autorità pubblica in regime di monopolio. Evidentemente la concessione amministrativa è quasi sempre elemento costitutivo dell’azienda, tuttavia la cessione dell’attività che abbia come elemento essenziale tale concessione non configura in sè trasferimento d’azienda in quanto presuppone l’emanazione o la revoca di un atto amministrativo (al riguardo Cass. 3 luglio 1987, n. 5286, in Foro it., 1988 844; Cass. 17 dicembre 1994, n. 10828, in Riv. it. dir. lav., 1995, II, 886 ed in Giur. it., 1995, I,1, c. 1876 s. con nota di S. Marazza, Cessione di autolinee e trasferimento d’azienda). Il nuovo concessionario che subentra al precedente in virtù di un provvedimento amministrativo acquista in sostanza la qualità a titolo originario e non derivativo (Cass. 24 febbraio 1992 n. 2885, in Riv. it. dir. lav., 1993, II, 203 con nota di Nogler, Continuità della prestazione lavorativa e trasferimento d’azienda). Pertanto, nell’ambito di una procedura fallimentare non è ipotizzabile un trasferimento di azienda concessionaria, contrariamente a quanto accade per aziende munite di licenza, la quale è autorizzazione costitutiva, ossia crea nel privato una situazione giuridica che non deriva dalla sfera dell’ente pubblico. Tutto ciò a meno che l’organizzazione aziendale predisposta dal concessionario fallito, esclusa la concessione, sia tale da poter essere in sè considerata un complesso unitariamente funzionale all’esercizio dell’attività economica, la qual cosa è in verità assai improbabile.
[84] Sulla fungibilità degli elementi: Cass. 15 gennaio 1990, n. 123, in Giur. comm., 1991, II, 231 (con nota di A. Munari, Trasferimento e affitto dell’azienda in relazione all’evoluzione della giurisprudenza della Cassazione), secondo la quale nel trasferimento d’azienda può rimanere escluso anche un elemento essenziale dell’azienda stessa, purchè surrogabile nel quadro del perseguimento della medesima attività obiettiva.
[85] Pret. Foggia 11 febbraio 1995, in Dir. fall., 1985, II, 625, ha ritenuto che si configurasse trasferimento d’azienda con conseguente applicazione del 2112, c.c., nel caso di trasferimento dei soli calciatori e del titolo sportivo; Corte d’Appello di Torino, 28 ottobre 2008 – Pres. rel. Peyron. - B.P.M. c. Torino F.C. S.p.a., con nota di Fimmanò, L’assegnazione del titolo sportivo come trasferimento coattivo e senza indennizzo dell’azienda calcistica, in Società, 2009, 299.
[86] La stessa Cassazione ha individuato nel carattere accessorio delle attrezzature mancanti, rispetto a quelle presenti nel complesso aziendale oggetto del contratto, il limite della compatibilità di un’azienda incompleta (Cass. 28 ottobre 1976, n. 3966, in Rep. giur. it., 1976, voce Azienda, n. 9; Cass. 17 giugno 1974, n. 1726, ivi, 1974, voce cit., n. 4). Cass. 29 gennaio 1991, n. 889, cit., 201.
[87] Sui rapporti tra criteri qualitativi e quantitativi e sul concetto di normalità cfr. P. Forchielli. La rilevanza giuridica del concetto di 'normalità' e l’indagine statistica, in Riv. dir. civ., 1980, II, 151 s.
[88] Secondo una certa giurisprudenza il titolo sportivo, pur facendo capo, in modo personalissimo ed esclusivo, soltanto alla società che l’ha conquistato sul campo, non si sostanzierebbe in una situazione giuridica di vantaggio alla società attribuita dall’ordinamento generale, ma in una qualità inerente allo status della società all’interno dell’ordinamento settoriale sportivo. Per l’effetto non potrebbe essere qualificato come bene ai sensi dell’art. 810 c.c., nè come diritto potestativo. Esso identificherebbe il merito sportivo, ossia la posizione acquistata dalla società sportiva sul campo, nel corso del campionato, appunto per merito sportivo, oggetto del riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato (Trib. Napoli 25 febbraio 2010, in Società, 2011, 769 s., con nota di C. Sottoriva, La qualificazione del c.d. “titolo sportivo” nel trasferimento d'azienda nell’ambito di procedure concorsuali.
[89] Cass. Sez. unite, 3 febbraio 1993 n. 1315, in Foro it., 1993, I, 1721; Cass. Sez. unite, nn. 5470 e 5471 del 1985, in Foro it., 1986, I, 982. Il Consiglio di Stato (20 ottobre 1987, n. 635, in Giust. civ. 1988, I, 1076) ha ritenuto che, se la possibilità di trasferire l’autorizzazione è riconosciuta dalla legge al titolare dell’esercizio, non v’è nessuna ragione ostativa a che tale vendita venga realizzata in forma coattiva dagli organi della procedura fallimentare (al riguardo D. Talarico, La sorte della 'azienda farmacia' nella procedura concorsuale: aspetti connessi alla vendita ed all’affitto, in Dir. fall., 1995, I, 145 s.). A ciò bisogna aggiungere che l’uso ad opera del legislatore, nella legge n. 475 del 1968, dell’espressione trasferimento, indica che il bene può circolare anche sulla base di schemi negoziali diversi dalla vendita, ivi compreso l’affitto, tenendo conto che peraltro già l’art. 129 della legge n. 1265 del 1934, prevede la possibilità per il curatore, nominato a seguito della dichiarazione di fallimento del titolare, di essere autorizzato all’esercizio provvisorio della farmacia (sull’ammissibilità dell’affitto endofallimentare della farmacia si veda da ultimo Trib. Roma 10 agosto 1995, in Dir. fall., 1996, II, 390 s.).
[90] Per una certa giurisprudenza “In caso di messa in liquidazione di una società calcistica per gravi irregolarità di gestione, i liquidatori possono essere autorizzati dal tribunale a continuare l'esercizio dell'attività dell'impresa calcistica al fine di far completare alla squadra il campionato intrapreso, non ricadendo tale attività nel divieto di nuove operazioni di cui all'art. 2279 c.c. richiamato dall'art. 2452 c.c., e potendo altresì configurarsi la ricorrenza di un danno grave e irreparabile per la società nell'interruzione dell'attività” (Tribunale Catania, 21 maggio 1992, Soc. Catania calcio, in Vita not., 1993, 355).
[91] Peraltro senza pagare i creditori in violazione dell’art. 2560, c.c., - come è accaduto nel caso della Fiorentina Calcio in virtù di un provvedimento ad hoc in deroga alle stesse Noif di affiliazione della società Florentia Viola. A norma dell’art. 52 comma 7 'Le società non ammesse ai Campionati di Serie A, B o C1 potranno iscriversi al Campionato di Terza Categoria – L.N.D.'.
[92] In modo da ottenere l’iscrizione alla categoria subito inferiore. Il tutto depauperando in caso di fallimento la massa dal valore attivo più consistente. <<In caso di non ammissione al campionato di serie A, B o C1, per mancato rispetto dei criteri economico – finanziari, di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, C1 e C2 negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell’ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire il titolo sportivo inferiore di una categoria rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale. Al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, nè possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi…”.
[93] Si pensi al caso del Monza Calcio Spa o allo stesso caso Napoli. Il Tribunale di Monza con decreto del 17 giugno 2004, ha trasferito a seguito di vendita senza incanto dal fallimento “Calcio Monza SpA” all’”Associazione Calcio Monza Brianza 1912 SpA, il complesso aziendale della società calcistica, ivi compresi calciatori e diritto all’utilizzo dello stadio. Correlativamente la F.I.G.C. con delibera del 30 giugno 2004 ha affiliato la cessionaria, mantenendo in capo alla stessa i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della società fallita ed ha autorizzato il trasferimento dell’azienda con particolare riferimento a titolo sportivo e parco tesserati (cfr. gli atti in www.fallimento.ipsoa.it)
[94] Non a caso nella citata ordinanza del 16 luglio 2004, il Tribunale di Napoli, ha precisato che “che soluzioni come quella prospettata dell’affitto di azienda non potranno mai essere utilizzate come strumento per lasciare alla società locatrice la gran parte della debitoria esonerando la società sportiva Calcio Napoli Spa dalla necessaria dimostrazione che la crisi economica in cui attualmente versa sia effettivamente transitoria e non irreversibile”. Se, come affermano i giudici napoletani, scopo della procedura concorsuale è quello di tutelare le ragioni dei creditori, secondo criteri ispirati dal principio della parità di trattamento, una linea diversa si risolverebbe “in un risultato di segno affatto opposto, paradossalmente favorendo, per una sorta di eterogenesi dei fini non trasparenti operazioni e speculazioni finanziarie in pregiudizio dei medesimi”.
[95] Per una analisi delle varie insolvenza che hanno caratterizzato le società sportive P. BELLAMIO, La stagione delle insolvenze nel calcio. Occasione per un cambiamento, Dir. fall., 2005, 719.
[96] Trib. Napoli 2 agosto, 2004, cit.
[97] Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza: 1) di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza; 2) di avere ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.; 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta; 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza; 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti (art. 52 comma 3).
[98] Come accadeva rispettivamente per le ipotesi di cui ai commi 3 ovvero 7, 8 e 9 dell’art. 52. L’abrogato comma 7 sanciva che 'La mancata assegnazione, ai sensi del comma 3, del titolo sportivo di Serie A, B o C1 o lo stato di insolvenza per le società di serie A, B o C1 accertato o dichiarato nel periodo intercorrente fra il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo e la scadenza ultima fissata per la conclusione del procedimento di cui al comma 6, legittimano la Procedura concorsuale ad individuare essa stessa, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrente da tale ultima scadenza, altra società avente sede nella stessa città di quella in stato di insolvenza cui la Federazione potrà assegnare, soddisfatte le condizioni indicate al comma successivo ed eventuali altre che la F.I.G.C. ritenesse di individuare, il titolo sportivo inferiore di una categoria'. Il comma 8 aggiungeva che 'Le condizioni, salve integrazioni di cui al precedente comma, cui la Federazione subordina la possibilità di assegnazione del titolo sportivo ai sensi del comma 7 in capo alla società individuata dalla Procedura concorsuale sono le seguenti: 1) presentazione della richiesta di attribuzione del titolo sportivo di una categoria inferiore rispetto a quello della società in stato di insolvenza; 2) conseguimento della affiliazione alla F.I.G.C.; 3) presentazione della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale; 4) presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l’iscrizione al campionato; 5) deposito della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l’impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni, relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti'. Infine, a norma del comma 9 ora abrogato: 'Le condizioni di cui al comma 8 devono essere soddisfatte nel termine perentorio di 5 giorni dal provvedimento con cui la procedura concorsuale ha individuato la nuova società aspirante al titolo. Sulla domanda di attribuzione del titolo sportivo e di ammissione al relativo campionato, delibera il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d’intesa con i Vicepresidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, previo parere favorevole della Co.Vi.So.C. Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione. In caso di non ammissione al campionato di serie C2, la società potrà essere ammessa ad un Campionato Regionale della L.N.D., tenuto conto delle disponibilità di organico dei vari Comitati Regionali e purchè adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato'.
[99] Il comma 6, dell’art. 52 (ora abrogato), in particolare, sanciva che 'In caso di non ammissione al campionato di serie A, B o C1 di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, C1 e C2 negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell’ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire, a fronte di un contributo straordinario in favore del Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, il titolo sportivo inferiore di una categoria rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale. Al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, nè possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi. L’inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non accoglimento della stessa o, se accertata dopo l’accoglimento della domanda, comporta, su deferimento della Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le società aspiranti al suddetto titolo, entro il termine perentorio di 3 giorni, esclusi i festivi, dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al campionato di Serie A, B, o C1 della società esclusa, dovranno manifestare il proprio interesse, presentando alla FIGC una dichiarazione in tal senso….'.
[100] Dopo la retrocessione in serie B, il 1° agosto del 2002 la FIGC, escluse dal campionato la AC Fiorentina Spa e il tribunale civile di Firenze ne decretò il fallimento. La nuova società Fiorentina 1926 Florentia, poi denominata Florentia Viola, nella stagione 2002-2003, venne iscritta al campionato italiano di calcio di serie C2, Successivamente a seguito dell’acquisto dalla procedura fallimentare del logotipo della vecchia Fiorentina e del nome, venne richiamata “ACF Fiorentina” il 19 maggio del 2003.
[101] Al termine del campionato 2004/05, la Salernitana Sport 1919, non venne ammessa, per ragioni finanziarie, al campionato di Serie B. Subito dopo, attraverso il Lodo Petrucci, il titolo venne assegnato ad una nuova società, la Salernitana Calcio 1919, che venne ammessa al campionato di serie C1 2005/2006. La Salernitana Sport ripartì dalla 3a categoria, attraverso una selezione di giovani calciatori, ma il 19 luglio 2006 cessò definitivamente ogni attività sportiva in seguito alla dichiarazione di fallimento ad opera del Tribunale fallimentare di Salerno.
[102] A seguito del fallimento della società Associazione Calcio Perugia S.p.A., militante in Serie B, venne costituita una nuova società, il Perugia Calcio S.r.l. (in seguito Perugia Calcio S.p.A.), che aderì al Lodo Petrucci venendo ammessa al Campionato di Serie C1.
[103] La società fondata come FC Torino il 3 dicembre1906, poi ridenominata AC Torino (e, in seguito, Torino Calcio), è stata dichiarata fallita il 17 novembre2005 dopo l’esclusione dal campionato di serie A. La nuova società, fondata il 17 luglio2005, veniva iscritta al campionato di B 2005\2206, con il nome provvisorio di Società Civile Campo Torino, poi portato a Torino FC per effetto dell'appropriazione dei diritti sportivi tramite il Lodo Petrucci e della denominazione societaria acquisita dal tribunale fallimentare.
[104] Sul rapporto tra nome e bacino cfr. P. Zagnoli, Il nome della società sportiva: identità territoriale, immagine e valorizzazione del marchio, in Riv. dir. econ. sport, 2006, 158 s.
[105] App. Torino, 28 ottobre 2008 – Pres. rel. Peyron. - B.P.M. c. Torino F.C. S.p.a., in Società, 2009, 299; Tribunale di Napoli del 18 aprile 2011 n. 6559, Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, Giudice rel.Petruzziello, inedita. C’è da dire che nel caso del Torino Calcio, la sentenza della Corte di Appello è stata riformata in quanto la Cassazione ha ritenuto che agli specifici fini la voristici, e quindi solo a quei fini e della disciplina di cui all’art. 2112 c.c., “non integri la fattispecie trasferimento di azienda, l’assegnazione da parte della F.I.G.C. ad una diversa società, nel caso di esclusionedi una società calcistica professionista dal campionato di serie A o B o C1, deltitolo sportivo necessario per partecipare ad un campionato di serie immediatamente inferiore (inteso come riconoscimento delle condizioni tecnico-sportive che consentono la partecipazione ad esso), ma è necessario il trasferimento dall’una all’altra società dell’organizzazione di mezzi e servizi necessari per lo svolgimento dell’attività sportiva” (Cass., sez. lavoro, n. 15094 del 2011, Pres. De luca – Rel Ianniello, in Riv. Dir. Econ. Sport, VII, fasc. 2, 2011).
[106] F. Fimmanò, L’assegnazione del titolo sportivo come trasferimento coattivo e senza indennizzo dell’azienda calcistica, in Società, 2009, 299.
[107] Quanto al problema specifico della farmacia, va detto che l’art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (e successive modificazioni), innovando le precedenti disposizioni in materia, ha sancito la possibilità di trasferimento della titolarità dell’azienda farmaceutica decorsi tre anni dalla conseguita titolarità, tra soggetti muniti di titolo di legittimazione, ossia tra soggetti legittimati all’esercizio della professione di farmacista. Ed il trasferimento, che va riconosciuto con decreto del medico provinciale, non è valido se insieme al diritto di esercizio non venga alienata l’azienda commerciale connessa, pena la decadenza.
[108] Si tratta di un rafforzamento dell’informativa obbligatoria per le società: E stato introdotto anche il rendiconto finanziario tra i documenti oggetto di deposito, in considerazione della sua capacità informativa e della crescente importanza che assume nel quadro dell'informativa di bilancio, anche alla luce di quanto dispongono i principi contabili internazionali.
[109] Il valore della produzione di cui tener conto nel calcolo del numeratore del rapporto è composto dalle seguenti poste: ricavi delle vendite e prestazioni, variazione delle rimanenze, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, altri ricavi e proventi. Si tratta quindi del valore risultante dal piano dei conti approvato dalla Figc, ossia dalla classe di valore contraddistinta dalla lettera «A» del Conto economico civilistico. I Debiti finanziari da considerare nel calcolo del rapporto sono invece costituiti dalle seguenti poste: obbligazioni ordinarie e convertibili, soci c/anticipazioni temporanee, soci c/finanziamenti fruttiferi, debiti verso banche, debiti verso altri finanziatori, debiti finanziari verso imprese controllate, collegate e controllanti. Il valore risultante dalla suddetta sommatoria deve essere rettificato per l'importo iscritto nell'attivo patrimoniale tra le disponibilità liquide.
[110] La scelta di porre a confronto ricavi e debiti è diretta a indurre le società a contenere l'indebitamento verso i terzi, ponendo le premesse per una loro maggiore capitalizzazione e un rafforzamento della struttura finanziaria.
Il nuovo indicatore ha aiutato le società a raggiungere gli obiettivi soglia; infatti, da un lato “il Valore della produzione è una categoria più ampia rispetto ai ricavi (variazione rimanenze, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, altri ricavi e proventi), dall'altro i Debiti finanziari considerano solo alcune categorie di debiti che fanno riferimento prettamente a categorie finanziarie (obbligazioni, finanziamenti infruttiferi, debiti verso banche, debiti verso altri finanziatori). La scelta di passare da un sistema di controllo basato sull'analisi di tre indicatori a un sistema incentrato esclusivamente sul rapporto Valore della Produzione/Debiti finanziari ha riguardato esclusivamente le società di Serie A e B. Per quanto concerne invece le società di Lega Pro (l'ex Serie C), dopo le modifiche apportate alle Noif tali club sono tenuti a presentare alla Covisoc i prospetti da cui risultino due rapporti: Ricavi/Indebitamento e Patrimonio netto contabile/Attivo Patrimoniale” M. Nicoliello, Il monitoraggio di figc e uefa sulle società di calcio italiane: scenario attuale e possibili evoluzioni, cit., 43 s.
[111] Per quanto concerne le società di Serie B, oltre alle novità in materia di ritenute e contributi, è stato introdotto nuovamente il prospetto P/A con l’indicazione del rapporto tra Patrimonio netto contabile e Attivo patrimoniale, calcolato seguendo gli stessi criteri in vigore fino al 2006/07.
Scarica Articolo PDF