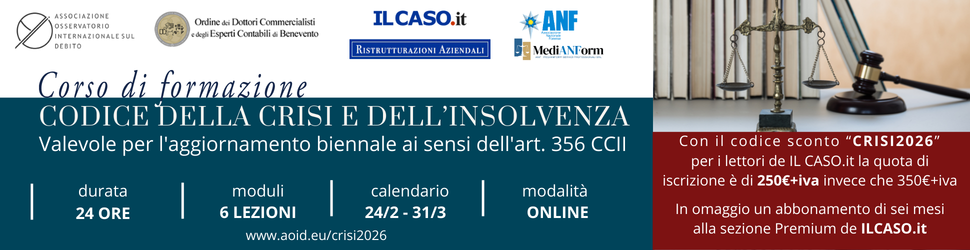PenaleImpresa
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 04/02/2015 Scarica PDF
Liberazione anticipata speciale e cumulo comprensivo di pene per reati ex art. 4-bis O.P.: note critiche alla prima giurisprudenza di legittimità
Giuseppe Vignera, Magistrato1. - Ai sensi dell’art. 4, 1° comma, d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni nella l. 21 febbraio 2014 n. 10 la maggiore detrazione di pena spettante a titolo di liberazione anticipata speciale opera “ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni”.
La Corte di cassazione ha recentemente affrontato il tema riguardante la possibilità di concedere o meno codesto beneficio ai soggetti destinatari di cumuli di pene comprensivi pure di quelle irrogate per taluno dei delitti “ostativi” previsti dall’art. 4-bis O.P.: tema che divide la giurisprudenza di merito ([1]).
Con
due “speculari” pronunce di pari data ([2])
Tale giurisprudenza, nondimeno, non convince perchè basa la superiore conclusione (sulla scindibilità del cumulo agli effetti della concessione della liberazione anticipata speciale) su premesse non corrette, rappresentate:
1) dalla (implicita) affermazione di un (supposto) principio generale della scindibilità del cumulo ai fini della valutazione dell’ammissibilità della domanda di concessione di un qualsivoglia beneficio penitenziario, il quale (principio) è stato desunto da quella giurisprudenza della Suprema Corte che [in coerenza con Corte cost., sentenza 27 luglio 1994 n. 361 ([3])] postula la possibilità di scioglimento del cumulo ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione;
2) dalla circostanza che “la diversa tesi della inscindibilità del cumulo ... determinerebbe una inaccettabile diversità di trattamento a seconda della eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente al cumulo, ovvero di distinte esecuzioni dipendenti dai titoli che scaturiscono dalle singole condanne”;
3) dal fatto che l’inscindibilità del cumulo “si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, di uguaglianza e della funzione risocializzante della pena e non troverebbe una giustificazione plausibile e razionale nel principio della pena unica, sancito dall’art. 76, 1° comma, c.p. (cfr. in tal senso Sez. Un. 30 giugno 1999 n. 14; Sez. I, 26 marzo 1999 n. 2529; Sez. I, 12 aprile 2006 n. 14563; cfr. anche Corte cost. sent. n. 386 del 1989)”.
Va detto subito e preliminarmente che le predette sentenze 53781/2014 e 53798/2014 presentano un “vizio d’origine”: quello di avere pedissequamente ricopiato i passaggi argomentativi della motivazione di una precedente pronuncia della Suprema Corte ([4]), la quale ha affermato la scindibilità del cumulo ai fini della concessione di un beneficio ben diverso dalla liberazione anticipata speciale, costituito dalla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale per finalità terapeutiche ex art. 94 DPR 309/1990. Di guisa che la supina trasposizione di quegli stessi passaggi argomentativi alla liberazione anticipata speciale (fatta da Cass. 53781/2014 e da Cass. 53798/2014) va stigmatizzata perché posta in essere prescindendo dalla doverosa considerazione delle specificità di codesto beneficio, il quale (come si vedrà) non costituisce nè una misura alternativa alla detenzione nè (a differenza della liberazione anticipata “ordinaria” ex art. 54 O.P.) un beneficio premiale strumentale al reinserimento sociale del condannato e/o alla sua rieducazione.
Proprio tenendo in considerazione codeste specificità, invece, si rivelano inconferenti tutte le suindicate premesse, su cui è stata basata la possibilità di scioglimento del cumulo anche ai fini della liberazione anticipata speciale: come si passa a dimostrare.
2. - Quanto alla premessa sub 1) (la supposta esistenza di un principio generale della scindibilità del cumulo ai fini della concessione di un qualsivoglia beneficio), Cass. 53781/2014 e Cass. 53798/2014 obliterano del tutto quella cospicua giurisprudenza della Corte di cassazione, che invece nega la possibilità di sciogliere il cumulo per finalità diverse dalla concessione di misure alternative alla detenzione ed in particolare ai fini:
- della sospensione delle regole del trattamento ai sensi dell’art. 41-bis O.P. ([5]);
- della concessione della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena ex art. 1 l. 1° agosto 2003 n. 207 (c.d. indultino) ([6]);
- della concessione
dell’esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non superiore ai
diciotto mesi ex art.
- dell’espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione ex art. 16, 5° comma, d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ([8]).
Orbene!
Dall’esame complessivo di codesta giurisprudenza è possibile enucleare le seguenti conclusioni:
A) non esiste un principio generale della scindibilità del cumulo ogniqualvolta dallo scissione possa derivare un qualsivoglia effetto favorevole per il condannato;
B) il principio della scindibilità del cumulo (quale deroga implicita al principio della ‘pena unica’ ex art. 76, 1° comma, c.p. imposta dall’osservanza dei canoni costituzionali dell’eguaglianza ex art. 3 Cost. e/o della funzione risocializzante della pena ex art. 27 Cost.) deve considerarsi sempre (e solo) operante rispetto ai benefici penitenziari finalizzati al reinserimento sociale del condannato (assegnazione del lavoro all’esterno, permessi-premio e misure alternative alla detenzione) ([9]);
C) opera, viceversa, il principio dell’inscindibilità del cumulo rispetto ad istituti o benefici svincolati dalla considerazione del percorso rieducativo del condannato e, in particolare, rispetto a quelli aventi come finalità (principale od esclusiva) la riduzione della popolazione carceraria ([10]).
Ebbene!
Proprio quest’ultima finalità deve assegnarsi alla liberazione anticipata speciale prevista dall’art. 4 d.l. 146/2013 convertito, con modificazioni, dalla l. 10/2014 (e risolventesi, per un periodo di due anni, nell’ulteriore detrazione di pena di 30 giorni in aggiunta a quella di 45 giorni prevista in via ordinaria dall’art. 54 O.P.), come è reso evidente:
- dal preambolo del d.l. 146/2013 ([11]);
- dall’art. 4, 5° comma, d.l./146/2013 nel testo risultante dalla sua conversione operata dalla l. 10/2014 ([12]): rispetto ai condannati ivi considerati (che espiano la pena in regime esterno al carcere), infatti, la liberazione anticipata si applica solo nella misura ordinaria (di 45 giorni) e non in quella speciale (di 75 giorni) proprio perché rispetto a costoro non si pone l’esigenza di riduzione del sovraffollamento carcerario.
Conseguentemente, le sentenze della Corte di cassazione qui censurate (n. 53781 e n. 53798 del 2014), nel postulare l’operatività del principio della scindibilità del cumulo anche agli effetti della liberazione anticipata speciale, hanno:
a) impropriamente richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità divisante la scindibilità del cumulo ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione, non avendo la prima (la liberazione anticipata speciale) quella finalità rieducativa della pena propria delle seconde;
b) inspiegabilmente
ignorato quella cospicua giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il
principio dell’inscindibilità del cumulo rispetto ad istituti, cui si deve
riconoscere prevalentemente (sospensione condizionata dell’esecuzione della
pena ex art. 1 l. 1° agosto 2003 n.
207 ed esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non superiore ai
diciotto mesi ex art.
Mette conto, infine, rimarcare che lo stesso d.l. 146/2013 ha implicitamente postulato l’operatività del principio dell’inscindibilità del cumulo agli effetti della liberazione anticipata speciale contenuta nel suo art. 4.
Invero:
- l’art. 6, 1° comma, lettera b), d.l. 146/2013 ha modificato l’art. 16, 5° comma, d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, stabilendo espressamente la possibilità di sciogliere il cumulo ai fini dell’espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione ([13]);
- codesto intervento normativo sarebbe stato totalmente superfluo in presenza di quel principio generale della scindibilità del cumulo, erroneamente predicato dalle sentenze qui censurate (Cass. 53781/2014 e 53798/2014);
- quel medesimo intervento normativo, invece, è assolutamente coerente con la regola della “pena unica” dipendente dal concorso di pene della stessa specie (cui consegue il principio quello della inscindibilità del cumulo) ex art. 76, 1° comma, c.p., derogando all’operatività generale di quella regola in ossequio alla riserva di legge ivi stabilita ([14]);
- poiché la liberazione anticipata speciale e l’espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione hanno la stessa finalità di riduzione della popolazione carceraria, il silenzio serbato dal legislatore sulla possibilità di sciogliere il cumulo anche in funzione della prima è … eloquente e corrisponde ad una precisa voluntas legis: quella di mantenere l’operatività della regola della “pena unica” ex art. 76, 1° comma, c.p. e del consequenziale principio dell’inscindibilità del cumulo agli effetti della liberazione anticipata speciale.
3. - Passiamo adesso ad esaminare e confutare la seconda delle suindicate premesse di Cass. 53781/2014 e di Cass. 53798/2014: quella secondo cui “la diversa tesi della inscindibilità del cumulo ... determinerebbe una inaccettabile diversità di trattamento a seconda della eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente al cumulo, ovvero di distinte esecuzioni dipendenti dai titoli che scaturiscono dalle singole condanne”.
Tale premessa si risolve in un’argomentazione inaccettabile perché surrettizia.
Si osserva, invero, che in presenza di una pluralità di titoli esecutivi l’ordinamento (v. artt. 76 e 80 c.p. e 671 c.p.p.) prevede la loro obbligatoria unificazione in un solo titolo inglobante ed unificante le singole pene (c.d. principio di unicità dell’esecuzione della pena e/o del rapporto esecutivo) ([15]).
Pertanto, la “eventualità casuale” come sopra prospettata da Cass. 53781/2014 e da Cass. 53798/2014 rappresenta una vera aberrazione giuridica e, risolvendosi in un mero dato ipotetico ed “asistematico”, in una sorta di elemento accidentale rispetto allo schema normativo tipico del rapporto esecutivo penale, non può costituire l’ubi consistam di un’interpretazione (logico-sistematica) finalizzata all’individuazione di una soluzione giuridicamente corretta e condivisibile perchè coerente con il sistema normativo.
4. - Per completezza, infine, va esaminato l’ultimo dei passaggi argomentativi, su cui si fondano le pronunce qui censurate: quello secondo cui “la diversa tesi della inscindibilità del cumulo ... si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, di uguaglianza e della funzione risocializzante della pena e non troverebbe una giustificazione plausibile e razionale nel principio della pena unica, sancito dall’art. 76, 1° comma, c.p. (cfr. in tal senso Sez. Un. 30 giugno 1999 n. 14; Sez. I, 26 marzo 1999 n. 2529; Sez. I, 12 aprile 2006 n. 14563; cfr. anche Corte cost. sent. n. 386 del 1989)”.
Si sottolinea, anzitutto, che pure codesta argomentazione rappresenta il portato della ... “sbandata” iniziale delle sentenze in questione: consistente nel richiamo di princìpi giuridici e di precedenti giurisprudenziali, i quali sono stati, rispettivamente, affermati e pronunciati rispetto ad istituti aventi finalità (il reinserimento sociale del condannato) assolutamente diversa da quella (deflattiva della popolazione carceraria) propria della liberazione anticipata speciale.
Ed invero, basta leggere le motivazioni delle pronunce come sopra richiamate da Cass. 53781/2014 e da Cass. 53798/2014 per rendersi conto che:
- Cass. pen., Sez. Un., sentenza 30 giugno 1999 n. 14, Ronga ([16]), è intervenuta in una fattispecie relativa ad un permesso-premio ex art. 30-ter O.P. (mutuando a sua volta da Cass. 2525/1999, di cui appresso, quella stessa argomentazione surrettizia sopra confutata al paragrafo 3: quella, più esattamente, incentrata sull’asserita “inaccettabile diversità di trattamento a seconda della eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente al cumulo, ovvero di distinte esecuzioni dipendenti dai titoli che scaturiscono dalle singole condanne”);
- Cass. pen., Sez. I, sentenza 26 marzo 1999 n. 2529, Parisi ([17]), è stata scritta in materia di misure alternative alla detenzione.
Il richiamo di Cass. pen., Sez. I, sentenza 12 aprile 2006 n. 14563, Hamdy ([18]), poi, è del tutto fuori luogo perchè il suo thema decidendum era non quello della scindibilità del cumulo (questione incontroversa ed estranea al ricorso), ma quello ben diverso della imputazione o meno al delitto “ostativo” della pena già espiata.
Quanto
a Corte cost., sentenza 11 luglio 1989 n. 386 ([19]),
infine, si rileva che nella fattispecie
- ha confezionato le proprie argomentazioni rispetto alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà: ergo, ad istituti con finalità (“rieducativa”) ben diversa da quella (“svuotacarceri”) propria della liberazione anticipata speciale;
- ha, in particolare, considerato “infondata la critica del principio della ‘pena unica’ dipendente dal concorso di pene della stessa specie”, osservando che quel “principio non è inderogabile, sia per l’espressa riserva di legge contenuta nella disposizione, sia per l’implicita osservanza che ovviamente va data, comunque, ai principi costituzionali” di eguaglianza e della funzione risocializzante della pena; e precisando che “ciò comporta che ... eventuali violazioni del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), o di quello concernente la funzione risocializzante della pena (art. 27, secondo comma, della Costituzione), vanno riferite caso per caso, per ogni singola situazione applicativa, all’eventuale omissione di particolari disposizioni che, in coerenza al sistema, avrebbero potuto evitarle”.
Orbene!
Alla stregua di queste ultime precisazioni si può addirittura affermare che Cass. 53781/2014 e Cass. 53798/2014, richiamando la surricordata sentenza della Corte costituzionale n. 386/1989, hanno paradossalmente … “fatto autogol”.
Invero, le (esatte) puntualizzazioni esternate in quell’occasione dalla Corte costituzionale si prestano a confermare indirettamente l’operatività del principio della “pena unica” ex art. 76 c.p. e di quello consequenziale dell’inscindibilità del cumulo rispetto alla liberazione anticipata speciale, atteso che:
- a quest’ultima (posta la sua esclusiva funzione deflattiva della popolazione carceraria) rimane estranea la funzione risocializzante della pena ex art. 27 Cost.;
- la sua esclusione per i soggetti che abbiano già scontato la pena imputabile al delitto “ostativo” non appare irragionevole (e non integra, quindi, violazione del canone ex art. 3 Cost.) perchè i reati elencati nell’art. 4-bis O.P. assumono rilievo non in quanto le pene relative debbano essere in concreto espiate, ma solo in quanto sintomatici di una maggiore pericolosità sociale del condannato alla stregua del sentire comune e dell’id quod plerumque accidit ([20]): e tutti sanno che in base alla giurisprudenza costituzionale il principio di eguaglianza non può dirsi affatto vulnerato in presenza di una disparità di trattamento normativo fondata su “presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino l’adozione” ([21]).
([1]) In senso favorevole alla scindibilità del cumulo agli effetti de quibus v. esemplificativamente Mag. sorveglianza Vercelli, ordinanza 27 maggio 2014, A.D., in www.penalecontemporaneo.it, 16 giugno 2014.
In senso contrario, invece, v. per esempio Trib. sorveglianza Milano, ordinanza 30 maggio 2014, A.G., in www.penalecontemporaneo.it, 17 luglio 2014.
([2]) Cass. pen., Sez. I, sentenza 22 dicembre 2014 n. 53781, Ciriello; e Cass. pen., Sez. I, sentenza 22 dicembre 2014 n. 53798, Moi.
([3]) In Giust. Pen., 1994, I, 321.
([4]) Trattasi di Cass. pen., Sez. I, sentenza 3 dicembre 2013 n. 2285, Di Palo.
([5]) V. tra le più recenti Cass. pen., Sez. I, sentenza 9 gennaio 2009 n. 10410, Saponaro.
([6]) V. ex multis Cass. pen., Sez. I, sentenza 16 aprile 2013 n. 20507, Delli.
([7]) V. Cass. pen., Sez. I, sentenza 13 gennaio 2012 n. 25046, Zarra.
([8]) V. ultimamente Cass. pen., Sez. I, sentenza 20 giugno 2013 n. 35620, P.G. in proc. Duraj.
([9]) V. amplius Trib. sorveglianza Milano, ordinanza 30 maggio 2014, cit.: “Si vuole, in altri termini sostenere che allorquando determinati benefici penitenziari siano legati concettualmente e strutturalmente al percorso rieducativo seguito ed al trattamento rieducativo perseguito anche con le misure alternative alla pena, appare evidente che il trattamento debba essere modulato in riferimento alla porzione di pena ancora da scontare, con specifico riguardo alla natura dei reati per i quali la porzione di pena risulta da eseguire, così che, pervenendosi allo scioglimento del cumulo (c.d. scorporo), si riesca a modulare il trattamento rieducativo alla tipologia di reato realizzato, e, quindi, alla personalità del detenuto in vista del suo trattamento rieducativo; conseguentemente, in casi di tal fatta, per il detenuto che abbia già scontato la pena relativa ad un delitto ricompreso nella elencazione di cui all’art. 4-bis O.P., per la rimanente porzione di pena affidata ad altre tipologie di rieducazione eventualmente alternative alla esecuzione carceraria, appare conforme alle finalità di rieducazione della pena pervenire allo scioglimento del cumulo per meglio individualizzare il complessivo trattamento”.
([10]) V. amplius Trib. sorveglianza Milano, ordinanza 30 maggio 2014, cit.: “Ma, allorquando l’istituto da applicare non è direttamente dipendente dalla considerazione della tipologia di pena da adattare al percorso di rieducazione del detenuto, ma è fissato, … unicamente avuto riguardo a dichiarate finalità di decongestionamento degli Istituti penitenziari, nessuna individualizzazione del percorso del detenuto può operarsi con riguardo alla porzione di pena già scontata (se attribuibile o meno a delitto c.d. ostativo), venendo solo in rilievo le caratteristiche di pericolosità sociale descritte da taluno dei reati in relazione al quale è instaurato il rapporto esecutivo, ritenute, nel sentire comune, direttamente recepito dal legislatore …, di particolare allarme sociale”.
([11]) In tale preambolo, infatti, sta scritto: “Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, in particolare, sul versante della legislazione penale in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari, di reati concernenti le sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione, della misura sostitutiva dell’espulsione del condannato cittadino extracomunitario, di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi; Ritenuta, altresì, la necessità di introdurre misure straordinarie e temporanee, complementari ai predetti interventi, in materia di liberazione anticipata”.
([12]) L’art. 4, 5° comma, d.l./146/2013 nel testo risultante dalla conversione operata dalla l. 10/2014 stabilisce: “Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative, nè ai condannati che siano stati ammessi all’esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale”.
([13]) Tale norma, infatti, ha aggiunto il seguente al secondo periodo del predetto art. 16, 5° comma: “In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l’espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono”.
([14]) L’art. 76, 1° comma, c.p. così recita:“Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell’art. 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico”.
([15]) Sulla obbligatorietà del cumulo in presenza di pene concorrenti v. specificamente la motivazione di Cass. pen., Sez. I, sentenza 11 luglio 2006 n. 29087, Proietti Bartolucci, in Arch. Nuova Proc. Pen., 2007, 5, 645.
([16]) In Dir. Pen. e Processo, 1999, 11, 1388.
([17]) In Riv. Pen., 1999, 669.
([18]) In Arch. Nuova Proc. Pen., 2007, 2, 262.
([19]) In Foro It., 1989, I, 3340.
([20]) V. esemplificativamente Cass. pen., Sez. I, sentenza 7 ottobre 2009 n. 41322, Francavilla; nonchè Trib. sorveglianza Milano, ordinanza 30 maggio 2014, cit.
([21]) Così ha
sempre insegnato
Sul tema ci permettiamo rinviare alle considerazioni da noi svolte in ANDOLINA-VIGNERA, I fondamenti costituzionali della giustizia civile, Giappichelli, Torino, 1997, 131 ss.
Scarica Articolo PDF