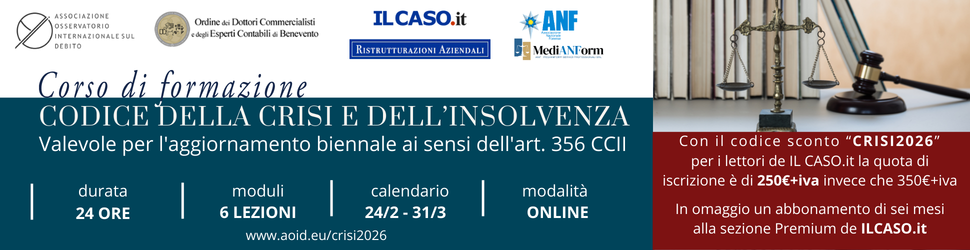Tributario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 25/03/2015 Scarica PDF
Il ricorso tributario proposto dal fallito rispetto all'inerzia del curatore
Gennaro Di Gennaro, Dottorando di ricercaSommario: 1. Premessa. - 2. L’iniziativa processuale del fallito. - 3. La doppia notifica del provvedimento impositivo: al curatore e al fallito. - 4. La sorte degli atti notificati ante fallimento. - 5. Considerazioni conclusive.
1. Premessa
Il tema oggetto dell’odierno contributo, concerne la capacità processuale del fallito avverso i provvedimenti impositivi notificati in pendenza di fallimento, ma relativi a presupporti realizzati, dal medesimo contribuente (poi) fallito, prima del deposito della sentenza dichiarativa della procedura concorsuale (in argomento, sia consentito rinviare a G. DI GENNARO, La legittimazione processuale del fallito avverso gli atti d’imposizione tributaria, in il fisco n. 36/2014, pag. 3560).
Orbene, la dichiarazione di fallimento genera, come noto, una serie di effetti giuridicamente rilevanti che interessano e caratterizzano la posizione giuridico-soggettiva del contribuente dichiarato fallito; trattasi, invero, di effetti di carattere personale, patrimoniale e processuale.
In merito a questi ultimi, ovvero alle conseguenze processuali, giova sin d’ora osservare che il fallito, in forza dell’art. 43 della L.F., perde la capacità processuale attiva e passiva riguardante le controversie aventi ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale, comprese nella procedura in esame.
L’eccezione al principio normativo innanzi citato, è da ricondurre a tutte quelle azioni a contenuto non patrimoniale e, quindi, dal profilo squisitamente personale (si consideri, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’esercizio dell’azione di disconoscimento della paternità di cui agli artt. 244 e segg. c.c.), per le quali resta ferma la (piena) legittimazione processuale del fallito.
In materia tributaria, pertanto, rileva verificare, ai fini che qui interessano, se, e quali strumenti di tutela, il fallito può legittimamente invocare qualora il curatore, al quale compete la gestione del patrimonio fallimentare e la monetizzazione dell’attivo nell’interesse della massa dei creditori (legittimamente insinuatisi), tenga, a seguito della notifica di un provvedimento impositivo, un comportamento inerte, inopportuno ed irragionevole.
Appare utile stabilire, pertanto, col conforto della giurisprudenza tributaria formatasi sul punto, se il fallito, constatata l’inerzia del curatore, possa considerarsi eccezionalmente ed attivamente legittimato a ricorrere (motu proprio) alla Magistratura tributaria, innanzi alla quale prospettare ogni utile censura preordinata alla rimozione dell’atto e/o alla rimodulazione della pretesa in esso contenuta.
2. L’iniziativa processuale del fallito
Nel corso della procedura concorsuale, ben potrebbe verificarsi la circostanza, non affatto impraticabile, in cui il curatore, al quale sia stato notificato l’atto tributario, mostri assoluto disinteresse ovvero ometta di rilevare alcuni profili invalidanti del medesimo provvedimento, utilmente sostenibili in sede contenziosa.
La cennata condotta, ben potrebbe rivelarsi pregiudizievole sia per il fallito che, per ragioni agevolmente immaginabili, per la massa dei creditori insinuatisi al passivo.
Circa la posizione del fallito, questi, tornato in bonis (e fatta salva l’ipotesi della esdebitazione, ricorrendone le condizioni), resterebbe direttamente esposto alla pretesa creditoria in tutto o in parte non soddisfatta in sede di riparto (parziale e/o finale).
In ordine alla massa dei creditori, invece, appare evidente che un credito tributario (totalmente o parzialmente) infondato o contenuto in un atto formalmente invalido, per invalidità propria o derivata, limiterebbe la possibilità di soddisfazione degli altri creditori; e soprattutto se, come normalmente accade, il credito tributario é assistito da privilegio mentre buona parte degli altri creditori sono chirografari.
Il fallito, pertanto, constatata l’irragionevole ed inopportuna inerzia del curatore, potrebbe valutare l’opportunità di un’iniziativa processuale volta ad impugnare l’atto impositivo.
In tema, la giurisprudenza tributaria, in virtù di un indirizzo interpretativo che appare ormai consolidato, e, forse, difficilmente scardinabile, ha più volte affermato il principio secondo cui il difetto di legitimatio ad processum, che consegue alla dichiarazione di fallimento, ha carattere relativo e non assoluto, nel senso che, constatata l’inerzia del curatore, il fallito può, in via straordinaria, impugnare il provvedimento onde evitare che la definitività dello stesso possa pregiudicare, come sopra esposto, non solo l’interesse della massa dei creditori ma anche quello dello stesso fallito (in tema, v. Cass., ordinanza n. 21385/2007; per l’orientamento opposto, peraltro minoritario, v. Comm. trib. prov. di Genova n.23/2012; Comm. trib. cent. n. 1763/1991).
L’opzione ermeneutica appena evidenziata, rappresenta, peraltro, l’orientamento prevalente anche in seno alle Corti di merito se si considera che, a tal proposito, è stato più volte affermato che l’ex legale rappresentante della società fallita può impugnare la decisione pronunciata dal Giudice di primo grado, qualora il curatore abbia omesso di valutare l’opportunità del gravame avverso i capi della sentenza ritenuti censurabili innanzi al Giudice di appello (in tal senso, ex multis, v. Comm. trib. reg. Umbria, sez. I, Perugia, n. 92/2004).
In altre circostanze, degne di nota, è persino prevalsa la soluzione interpretativa secondo cui il fallito conserva il diritto di impugnare l’atto tributario al fine di far giudizialmente dichiarare l’errata determinazione della base imponibile (al riguardo, v. Comm. trib. reg. Emilia Romagna, n. 88/2013).
A tal punto, appare utile chiedersi in quale misura l’inerzia consentirebbe al fallito la proposizione del ricorso tributario; ad avviso di chi scrive, sulla base delle notazioni sin qui esposte, l’iniziativa processuale del fallito ben può fondarsi, alternativamente, sulla inerzia assoluta o su quella relativa.
In merito alla prima, nulla quaestio: il curatore omette il pur minimo riscontro dell’atto tributario, mostrando, così, un disinteresse chiaro ed evidente.
Circa, invece, l’inerzia relativa, essa presuppone che il curatore, seppure abbia valutato gli aspetti invalidanti dell’atto impositivo, o, comunque, l’opportunità dell’iniziativa giudiziaria, non abbia considerato alcuni profili, che, ove prospettati in sede contenziosa, ben potrebbero, ad avviso del fallito, condurre alla rimozione del provvedimento o alla rideterminazione, in melius, della pretesa creditoria.
In tema di inerzia, giova comunque osservare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte statuito che essa non sussiste ogniqualvolta il curatore abbia correttamente esposto, dopo aver valutato l’opportunità della tutela giurisdizionale nonché i margini di tutela ottenibili in sede contenziosa, le ragioni ostative alla proposizione del ricorso; pertanto, la diligente e corretta valutazione dei margini di insuccesso connesse all’impugnazione giudiziale osta alla configurazione di alcuna condotta inerte (in tal senso, si rinvia a Cass., n. 21459/2013).
Ferme restando le considerazioni si qui svolte, rileva evidenziare un interessante filone interpretativo, formatosi soprattutto in seno alla giurisprudenza di merito, secondo cui, a prescindere dalla condotta inerte del curatore, al fallito va sempre riconosciuta una legittimazione processuale concorrente (sul punto, v. Comm. trib. reg. Puglia, n. 108/2011).
Sul versante processuale, infine, occorre rammentare che, frequentemente, nella pratica professionale, si pone il problema della individuazione dei soggetti legittimati a sollevare l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dal fallito (in difetto di legitimatio ad processum), chiedendosi, inoltre, se, alla luce del quadro normativo vigente, il Giudice adìto possa ex officio rilevarne l’incapacità processuale.
Orbene, l’elaborazione pretoria formatasi sul punto, sin dai primi anni del 2000, tuttora maggioritaria, ha condotto alla formulazione del principio secondo cui il difetto di legittimazione processuale non può essere rilevato d’ufficio dal Magistrato tributario, né l’Amministrazione resistente (Ente creditore o Agente della Riscossione) può sollevare in sede contenziosa la cennata incapacità; compete, pertanto, al solo curatore, intervenuto nel processo tributario o chiamato in causa, prospettare il difetto di legitimatio ad processum, e, conseguentemente, l’inammissibilità del ricorso dal medesimo (fallito) proposto (in tema, v. Cass., n. 5671/2006).
3. La doppia notifica del provvedimento impositivo: al curatore e al fallito
Circa i soggetti nei cui riguardi devono essere notificati gli atti impositivi riguardanti fatti e circostanze posti in essere prima della dichiarazione di fallimento, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato, con una soluzione interpretativa che, oggi, appare maggioritaria, che il procedimento notificatorio deve interessare sia il curatore che il fallito (Cass., n. 6937/2002; più recentemente, Id., n. 29642/2008; sul tema, per utili riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, v. L. DEL FEDERICO, I crediti tributari nell’accertamento del passivo fallimentare, in Rass. Trib. n. 1/2015, pag. 22, nota 29).
L’opzione interpretativa cui ha aderito la giurisprudenza tributaria, sia di legittimità che di merito, si fonda sulla circostanza che il fallito, anche dopo la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale, rimane pur sempre il soggetto passivo del rapporto obbligatorio d’imposta rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, che potrebbero conseguire dalla definitività dell’atto impositivo.
Detta interpretazione, invero, era stata fornita, seppure in merito alla notifica degli atti istruttori (in specie, del p.v.c.) dalla Amministrazione finanziaria, attraverso puntuali e circostanziati documenti di prassi (in argomento, v. la R.M. n. 16/8189/A, del 1984; sul tema, per utili e puntuali approfondimenti, v. F. TUNDO, Quali rimedi per il contribuente fallito di fronte all’inerzia del curatore nella impugnazione degli atti?, in Corr. Trib. n. 10/2013, pag. 785).
Rileva inoltre rammentare un ulteriore indirizzo giurisprudenziale, sviluppatosi già negli anni ’90, secondo cui il curatore, pur quando risulti che alcun atto tributario sia stato notificato al soggetto fallito, è tenuto a comunicargli tutti i provvedimenti notificati in modo da consentirgli di avere integrale conoscenza dell’atto e della pretesa in esso contenuta (in tal senso, v. Cass., n. 7561/1995; Id., n. 3094/1995).
Il percorso argomentativo ed ermeneutico secondo cui il procedimento notificatorio deve interessare, quale destinatario del provvedimento, anche il fallito, risponde all’esigenza di garantirgli l’integrale conoscenza della pretesa creditoria in misura tale da permettergli di:
- valutare e ponderare l’opportunità di esperire l’azione di annullamento;
- confutare, in caso di positiva verificazione dei margini di successo connessi all’impugnazione giudiziale, sia l’an che il quantum debeatur.
Un tema che ha suscitato, in seno alla giurisprudenza tributaria, un vivace dibattito, riguarda l’allegazione, o meno, all’avviso di accertamento notificato al curatore, del Processo Verbale di Constatazione redatto e notificato al contribuente “in bonis”, prima della dichiarazione di fallimento.
Secondo un primo indirizzo interpretativo, “è legittimo l’avviso di rettifica motivato “per relationem”, mediante rinvio ad un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e notificato al contribuente, non assumendo alcun rilievo la circostanza che quest’ultimo sia stato successivamente dichiarato fallito, ben potendo il curatore del fallimento avere conoscenza del verbale, in quanto facente parte della documentazione amministrativa dell’impresa, o chiedere all’Amministrazione finanziaria di prenderne visione ed estrarne copia, qualora esso non sia reperibile fra gli atti da lui presi in consegna al momento della sua immissione nella carica” (Cass., n. 2806/2010).
In forza di un filone giurisprudenziale di segno contrario a quello innanzi citato, è stato affermato che “in materia tributaria, è viziato da carente motivazione l’avviso di accertamento notificato al curatore fallimentare e motivato mediante il rinvio ai contenuti di un processo verbale di constatazione reso noto all’imprenditore quando era “in bonis”, ma non al curatore medesimo” (Cass., n. 8778/2008).
4. La sorte degli atti notificati ante fallimento
Altro aspetto che merita, seppur rapidamente, di essere affrontato, riguarda la notifica del provvedimento impositivo al contribuente e da questi impugnato (con conseguente costituzione in giudizio) prima del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento.
Sul punto, appare utile puntualizzare che la dichiarazione di fallimento comporta l’interruzione del processo tributario, con la conseguenza che compete al curatore svolgere ogni utile attività volta alla riattivazione del giudizio.
A tal proposito, la giurisprudenza tributaria ha più volte affermato il principio secondo cui ove la notifica del provvedimento impositivo sia avvenuta prima della dichiarazione di fallimento, l’Amministrazione creditrice non è giuridicamente tenuta a reiterare la notifica dell’atto (Comm. trib. reg. Roma, n. 289/2009).
5. Considerazioni conclusive
L’elaborazione pretoria che considera il fallito eccezionalmente abilitato alla proposizione dell’impugnazione giudiziale, appare, ad avviso di chi scrive, ampiamente condivisibile; detta considerazione, si fonda, invero, sul fatto che il disinteresse (irragionevole, inopportuno ed illegittimo), assoluto o relativo, mostrato dal curatore, ben potrebbe, in tal modo, essere paralizzato dalla tempestiva “reazione” processuale o amministrativa del fallito.
L’impostazione interpretativa, pertanto, appare in linea con un’interpretazione sistematica del combinato disposto di cui agli artt. 43 L.F. e 24 Cost..
Del resto, lo stato della giurisprudenza formatasi sul tema, favorevole, sub condicione, all’iniziativa processuale, impone di ritenere che al fallito debba parimenti riconoscersi il diritto di attivare ogni utile strumento amministrativo (si pensi, a titolo d’esempio, all’autotutela tributaria) idoneo a promuovere il riesame dell’an e del quantum debeatur.
[1] Il contributo riproduce, con integrazioni e adattamenti, il testo della relazione tenuta dall’Autore il 21 marzo 2015, in qualità di Docente, al “CORSO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN DIRITTO TRIBUTARIO” organizzato in Bari, presso la Legione Allievi della Guardia di Finanza, da Riccardo Pio Campana, Docente di Diritto Pubblico presso la Scuola Allievi Finanzieri della Guardia di Finanza di Bari ; il corso è stato accreditato dall’ Ordine degli Avvocati di Bari.
Scarica Articolo PDF