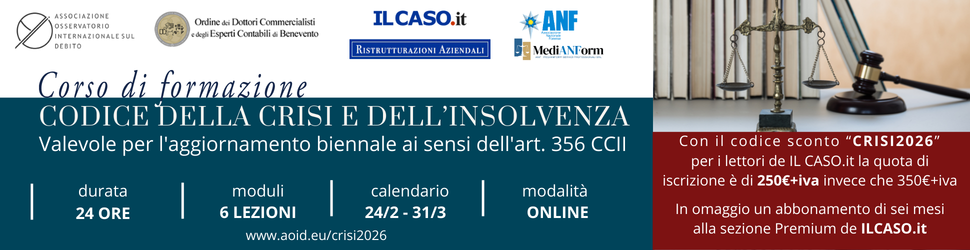PenaleImpresa
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 24/10/2013 Scarica PDF
Confisca penale ed ipoteca nel recente orientamento delle sezioni unite
Luca Ruggeri, ProfessoreSommario: 1. La fattispecie. - 2. I principali profili della sentenza. - 3. Gli aspetti di diritto intertemporale. - 4. La natura dell’acquisto da parte dello Stato. - 5. La tutela del terzo in buona fede. - 6. Il Giudice competente.
1. La fattispecie
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono recentemente pronunciate, con la sentenza del 7 maggio 2013, n. 10534, circa numerosi profili di interesse relativi, in particolar modo, al rapporto tra confisca in sede penale ed ipoteca iscritta da terzi in buona fede anteriormente al venire in essere delle misure di prevenzione patrimoniali.
Si tratta di aspetti che sono stati oggetto di un ampio dibattito dottrinale e di una giurisprudenza assai conflittuale.
La sentenza in oggetto ci consente quindi di affrontare il tema nel tentativo di comprendere quali siano gli approdi attuali della dottrina e della giurisprudenza.
Nel 1991 una banca erogava un mutuo iscrivendo, a garanzia, ipoteca su un bene di proprietà del mutuatario. Successivamente il Tribunale di Napoli sottoponeva il bene ipotecato a sequestro ai sensi della legge n. 575 del 1965 e quindi, nel 1995, ne ordinava la confisca.
Nel 1996 la banca creditrice provvedeva quindi a pignorare, avanti il Tribunale di Roma, l’immobile a garanzia del mutuo.
Nel 2000 L’Agenzia del Demanio disponeva il mantenimento dell’immobile al patrimonio indisponibile dello Stato e si opponeva all’esecuzione immobiliare affermando l’impignorabilità del bene.
L’opposizione veniva rigettata prima dal Tribunale e quindi dalla Corte d’Appello.
L’Agenzia ricorreva in Cassazione e la terza sezione rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite, dopo una articolata disamina della normativa, accoglievano il ricorso con rinvio alla Corte d’Appello, affermando che la controversia non poteva essere risolta sulla base del solo dato temporale, l’anteriorità o meno dell’iscrizione dell’ipoteca rispetto alle misure di prevenzione, bensì alla luce della normativa sopravvenuta, segnatamente della legge n. 228 del 2012.
2. I principali profili della sentenza
Nella sentenza in oggetto, le Sezioni Unite, lungi dal limitarsi ad una stringata motivazione legata al caso di specie, operano una attenta analisi dell'istituto della confisca penale ed in particolar modo del rapporto tra questa ultima e l'ipoteca iscritta in data anteriore alle misure di prevenzione ove vi è la necessità di individuare il corretto equilibrio tra due opposti interessi.
Va infatti assicurata l'efficacia dell'azione repressiva dello Stato nei confronti di organizzazioni criminali caratterizzate da una notevole pericolosità sociale. In tale contesto il criterio temporale, che regge il nostro sistema di pubblicità immobiliare, non appare sufficiente data la facilità, più volte adombrata in giurisprudenza, con la quale i malavitosi potrebbero costituire garanzie reali a favore di prestanome.
A fronte di quanto sopra si pone l’esigenza di tutelare i terzi, ricordiamo muniti di ipoteca iscritta prima delle misure in oggetto, estranei ai fatti che hanno dato luogo al sequestro ed alla confisca.
La Suprema Corte, dopo aver ripercorso l'evoluzione della legislazione nazionale e del quadro internazionale, prende con decisione posizione sugli aspetti maggiormente controversi della tematica [1], come peraltro autorevolmente auspicato dalla dottrina [2].
Nella sentenza si effettua una ricognizione della disciplina dettata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)“ [3], da applicarsi alle misure di prevenzione poste in essere prima della data di entrata in vigore (13.10.11) del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) [4], chiarendo quindi gli aspetti di diritto intertemporale.
La tematica del conflitto tra confisca ed ipoteca ha alimentato un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa vari aspetti, in particolar modo sulla natura dell'acquisto del bene da parte dello Stato, circa le modalità di tutela del terzo titolare di ipoteca iscritta in data anteriore, in ordine alla individuazione della parte alla quale spetta l'onere della prova della buona fede del terzo ed infine circa il giudice competente in materia.
3. Gli aspetti di diritto intertemporale
La materia relativa alle disposizioni relative alla lotta alla criminalità organizzata è stata oggetto di una estesa sistematizzazione con il D. Lgs. n. 159 del 2011, entrato in vigore il 13 ottobre 2011.
In particolar modo i rapporti tra ipoteca e confisca penale sono stati regolamentati da una organica disciplina racchiusa nel Titolo V “La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali” del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte risulta essere molto anteriore all’entrata in vigore del sopra citata decreto legislativo e non è quindi regolato da tale normativa, bensì da un successivo intervenuto in materia, precisamente dall'art. 1, commi da 189 a 205, della legge n. 228 del 2012.
Questa ultima novella legislativa trova infatti applicazione da parte delle Sezioni Unite per risolvere il caso di specie.
Il comma 194 della legge n. 228 del 2012 prevede che "a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive".
La novella regolamenta le diverse casistiche utilizzando quale spartiacque la data del 01.01.2013; in dettaglio distinguendo se entro tale data la confisca sia già avvenuta o meno e differenziando quindi la disciplina qualora sia verificata o meno l'aggiudicazione.
Nel caso in cui, al 01.01.2013, vi sia già stata la confisca, ma non l'aggiudicazione anche in via provvisoria, le legge prevede che nessuna azione esecutiva possa essere iniziata o proseguita mentre, aspetto di rilievo per quanto ci riguarda, i pesi e gli oneri iscritti o trascritti prima della confisca si estinguono.
La tutela dei terzi (siano essi creditori ipotecari, pignoranti od intervenuti nell'esecuzione, purché l'iscrizione dell'ipoteca, la trascrizione del pignoramento o l'intervento nel processo esecutivo siano avvenuti prima della trascrizione del sequestro di prevenzione), si avrà nei confronti della “Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.
Il terzo, per ottenere il pagamento dei propri crediti, dovrà quindi presentare una istanza entro il termine di decadenza del 30 giugno 2013 al "giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca", il quale provvede su di essa con provvedimento impugnabile ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
Nell’ambito di un procedimento sostanzialmente concorsuale l'Agenzia formerà quindi un piano di pagamento dei creditori ammessi e procederà al soddisfacimento di questi ultimi in misura che non potrà complessivamente eccedere la minor somma tra il ricavato della vendita ed il 70% del valore del bene.
Nella diversa ipotesi che, al 01.01.2013, il trasferimento o l'aggiudicazione nell'ambito di una esecuzione forzata siano già avvenuti, ovvero se il bene da confiscare consiste in una quota di proprietà indivisa già pignorata, permangono gli effetti dell'esecuzione o dell'aggiudicazione.
Nell’ulteriore ipotesi che, al 01.01.2013, i beni ipotecati o sottoposti ad esecuzione forzata non siano ancora stati confiscati, la disciplina è la medesima da applicarsi per i beni confiscati e non trasferiti o aggiudicati, ma in tal caso i creditori debbono presentare la domanda di ammissione del credito entro 180 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento che dispone la confisca.
Il caso portato all'attenzione della Suprema Corte viene quindi risolto assai agevolmente dalle Sezioni Unite sulla base della disciplina dettata dalla Legge di Stabilità. In forza del principio tempus regit actum, la sentenza impugnata è stata cassata in considerazione del fatto che quest’ultima aveva posto alla base del proprio ragionamento il solo dato temporale, costituito dall’anteriorità dell’iscrizione ipotecaria.
4. La natura dell'acquisto del bene da parte dello Stato
Uno degli aspetti maggiormente dibattuti circa la confisca penale è dato dalla natura dell'acquisto da parte dello Stato del bene confiscato, diatriba che non si è sopita con l'emanazione del Codice Antimafia [5].
Si possono individuare, in dottrina, almeno tre diverse posizioni circa il tema in oggetto ed anche la giurisprudenza appare assai controversa.
Una linea interpretativa afferma che la confisca è espressione di un potere sovrano dello Stato volta alla soppressione e prevenzione del crimine, valorizzando il precedente costituito dalla legislazione contro i gerarchi fascisti. Da questa impostazione si fa discendere la natura originaria dell'acquisto da parte dello Stato [6] e talvolta l'estinzione del diritto reale a favore del terzo [7].
Un diverso orientamento reputa che l'acquisto avvenga a titolo derivativo [8]. Lo Stato, attraverso l'istituto della confisca, mirerebbe a sottrarre alla malavita i beni illecitamente acquisiti e quindi subentrerebbe nella medesima posizione giuridica del soggetto che subisce la confisca. Coerentemente con tale prospettiva si afferma che lo Stato stesso non può disporre di una sfera giuridica più ampia del soggetto nei confronti del quale viene esercita la misura di prevenzione patrimoniale.
Rispetto alla precedente tesi questa ultima ricostruzione ha trovato una accoglienza più favorevole in giurisprudenza, principalmente in quanto reputata maggiormente attenta alla posizione del terzo in buona fede [9].
Va inoltre registrata una interpretazione intermedia secondo la quale l'acquisto della proprietà a mezzo della confisca deve essere concepito come una ipotesi di tertium genus tra acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo [10].
Il Codice Antimafia è intervenuto in materia statuendo, all'art. 45, che “a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi”; rispetto al previgente art. 2 nonies della legge n. 675 del 1975 si è quindi aggiunta l'espressione “libera da oneri e pesi”.
Allo stesso modo l'art. 45, comma 4, recita come segue: “la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi”.
Questi elementi testuali hanno contribuito a valorizzare la tesi dell'acquisto a titolo originario ma non sono apparsi ai commentatori così solidi da risultare risolutivi.
Va infatti considerato che il Codice Antimafia precisa (art. 52, comma 1) che la confisca non pregiudica i diritti del terzo risultanti da atto con data certa, così come i diritti reali di garanzia, purché anteriori al sequestro. Alla stessa stregua, al comma 4 del medesimo art. 52, viene riconosciuto il diritto ad un equo risarcimento a favore dei terzi che subiscono l'estinzione dei diritti di credito e dei diritti reali di godimento.
Entrambe queste ultime previsioni sono state portate a sostegno della tesi dell'acquisto a titolo derivativo.
Le Sezioni Unite, nella recente sentenza, affrontano il tema alla luce delle disposizioni della Legge di Stabilità; in particolar modo richiamando i commi 194 e 197, i quali, per le procedure che al 01.01.2013 abbiano già posto in essere la confisca ma non l'aggiudicazione, pongono il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive nonché, per quanto di interesse in questa sede, l'estinzione degli oneri ed i pesi iscritti o trascritti.
Le disposizioni di cui sopra, ad avviso della Suprema Corte, risolvono il conflitto tra confisca ed ipoteca stabilendo la prevalenza della prima sulla seconda, aldilà dell'aspetto temporale. La motivazione afferma infatti che “alla stregua di tale normativa, dunque, la confisca prevarrà sull'ipoteca” in una ottica di preminenza dell'interesse pubblico alla lotta al crimine.
Viene quindi chiarito, per quanto il dato normativo fosse, a parere di chi scrive, inequivoco, che il criterio temporale non può costituire, nel conflitto tra confisca ed ipoteca, il criterio per risolvere il conflitto stesso.
Le Sezioni Unite prendono quindi il destro dal caso di specie per assumere con decisione posizione circa il tema della natura dell'acquisto, da parte dello Stato, del bene a seguito della confisca.
La motivazione della sentenza rigetta infatti esplicitamente “la condivisa opinione della giurisprudenza civile e penale sulla natura derivativa del titolo di acquisto del bene immobile da parte dello Stato a seguito della confisca“. Viene quindi completamente rifiutata la nota decisione delle stesse Sezioni Unite, la sentenza del 28.09.94, n. 9, Bacheroti ed altri [11], secondo la quale, richiamando un altro precedente (CASS., 3 luglio 1997, n. 5988), l’acquisto a favore dello Stato “altrimenti definibile che come derivativo proprio in quanto esso non prescinde dal rapporto già esistente fra quel bene e il precedente titolare, ma anzi un tale rapporto presuppone”.
La decisione delle Sezioni Unite trova fondamento nel dato normativo costituito dal comma 197 della legge n. 228 del 2012 secondo il quale “gli oneri e pesi iscritti o trascritti (sui beni di cui al comma 194) anteriormente alla confisca sono estinti di diritto“.
Tale previsione, secondo la sentenza che qui si commenta, consente quindi di individuare nella confisca una delle causa di estinzione dell'ipoteca in forza dell'art. 2878 c.c.
Nella prospettazione offerta dalle Sezioni Unite appare consequenziale affermare la natura originaria dell'acquisto da parte dello Stato in quanto l'estinzione dei diritti e dei pesi anteriori alla misura di prevenzione è, sempre secondo la sentenza in oggetto, incompatibile con l'acquisto a titolo derivativo del bene.
La soluzione offerta dalle Sezioni Unite appare maggiormente coerente rispetto alla nuova normativa di quanto possa esserlo l'opzione della natura derivativa dell'acquisto del bene ed i timori relativi alla tutela del terzo, spesso sottesi a questa ultima teoria, trovano sollievo nella procedura stabilita dal Codice Antimafia, precedentemente sinteticamente descritta.
5. La tutela del terzo in buona fede
La recisa presa di posizione del legislatore, accolta favorevolmente dalla Cassazione, pone con forza il tema della tutela del terzo che, in buona fede, abbia iscritto ipoteca sul bene successivamente oggetto di misure di prevenzione.
La problematica è stata vivacemente dibattuta per anni a causa dell'assenza di previsioni in merito alla tutela dei terzi creditori nella legge n. 575 del 31 maggio 1965 [12].
Si tratta di un aspetto rilevante nella pratica [13] come dimostrato dal fatto che parti nelle controversie sono pressoché esclusivamente banche che temono il venir meno delle garanzie acquisite a tutela del loro credito.
Le Sezioni Unite avallano pienamente il sistema dettato dal Codice Antimafia ed integrato dalla Legge di Stabilità anche alla luce, come vedremo, della normativa comunitaria.
Il conflitto tra confisca e diritti dei terzi viene risolto dal Titolo IV del Codice Antimafia attribuendo al terzo il diritto ad un equo indennizzo (art. 52, comma 5) commisurato alla durata residua del contratto o del diritto reale. L'art. 53 precisa peraltro che tale indennizzo non può superare il 70% del minore “del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi”.
Disposizioni riprese, come rilevato dalle Sezioni Unite, dalla Legge di Stabilità ai commi 203 e 206.
I presupposti per il riconoscimento del credito del terzo sono previsti dal Codice Antimafia. In dettaglio l’art. 52 richiede che l'escussione del restante patrimonio, in ossequio all'art. 2740 c.c., sia risultata insufficiente ma, soprattutto, (art. 52, comma 1, punto b) condiziona il riconoscimento del credito alla non strumentalità del credito stesso all'attività illecita o al costituirne il frutto o il reimpiego “a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità”.
La valutazione della buona fede ha posto due diversi ordini di problemi. In primo luogo ci si è chiesti quali potessero essere i criteri per determinare la buona fede o meno del terzo.
In secondo luogo si è dibattuto in ordine a chi sia gravato dell'onere della prova della buona fede [14].
Circa il primo profilo, il legislatore si è limitato a statuire nel Codice Antimafia (art. 52, comma 3) che si debba tener conto dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, dell'attività svolta dal creditore ed degli obblighi di diligenza in fase precontrattuale.
Le Sezioni Unite colgono l'occasione per precisare che questi criteri sono obbligatori ma non sono né esclusivi né vincolanti inoltre, disattendendo le richieste di parte della dottrina, non indicano ulteriori criteri ma ricostruiscono l'istituto, correttamente ad avviso di chi scrive, come una norma che impone al giudice “un parziale protocollo logico nel ragionamento probatorio”.
In altri termini, secondo la Suprema Corte, il giudice può disattendere i criteri di cui all'art. 52, valorizzando altri e diversi elementi purché nell'ambito di un razionale iter logico.
Si è discusso in dottrina circa quale sia la parte gravata dall'onere della prova della buona fede; in giurisprudenza questo aspetto è meno dibattuto a favore di una soluzione che attribuisce tale onere al terzo.
Il dato normativo non soccorre ai fini di una soluzione in quanto, come rilevato anche dalle Sezioni Unite, né il Codice Antimafia né la Legge di Stabilità contengono previsioni in merito.
Le Sezioni Unite, anche circa tale aspetto, prendono nettamente posizione addossando l'onere della prova della buona fede al terzo, soluzione che viene sostenuta con due diversi ordini di considerazioni.
In primo luogo la veste sostanzialmente attorea attribuita al terzo nel procedimento giurisdizionale per l'ammissione del credito del terzo stesso.
In realtà nell’iter logico della motivazione appare predominante la seconda considerazione legata al riconoscimento da parte del legislatore dell'elaborazione giurisprudenziale, soprattutto in materia penale, maturata in questi anni. Le Sezioni Unite affermano infatti esplicitamente che, sul presupposto che il legislatore conosca il diritto vivente, “se il legislatore nel disciplinare una materia non innova le soluzioni che costituiscono l'approdo interpretativo della giurisprudenza, vuol dire che le recepisce: cioè le fa normativamente proprie”.
E' evidente la delicatezza del tema che potrebbe configurare una questione costituzionalmente rilevante ancorché la Corte Costituzionale, nei casi nei quali la questione è stata portata alla sua attenzione, ne abbia dichiarato nell'inammissibilità.
In questo senso va letto, ad avviso di chi scrive, l'ampio excursus dedicato, nell'ambito della motivazione, al diritto comunitario ed ai principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). L' excursus in oggetto si conclude affermando che il diritto comunitario e la CEDU impongono l'adozione di misure di prevenzione patrimoniale, purché le medesime non ledano i diritti dei terzi in buona fede, ma, soprattutto, utilizzando le parole della sentenza che qui si commenta, “consentono, in materia di misure di prevenzione patrimoniale, di addossare al terzo l'onere della prova della buona fede”.
In altri termini le Sezioni Unite si sono preoccupate di trovare un saldo ancoraggio comunitario ad una soluzione giurisprudenziale che ad una prima analisi, in particolar modo per un civilista secondo il quale la buona fede si presume, poteva apparire contraddistinta da profili di criticità.
6. Il Giudice competente
Un ulteriore tema sollevato dalle ordinanze di remissione alle Sezioni Unite era costituito dalla determinazione del giudice competente per conoscere la materia in oggetto [15].
In materia vi erano infatti due diverse opinioni.
Secondo la tesi prevalente nella giurisprudenza penale la competenza andava attribuita al giudice penale nell'ambito di un incidente di esecuzione. La principale motivazione addotta a sostegno di tale tesi veniva individuata nei maggiori poteri in capo al giudice penale stesso, rispetto al giudice civile, per indagare sul tema [16].
Nell'ambito della giurisprudenza civile si contestava la competenza penale reputando improprio il ricorso ad un autonomo incidente penale e si considerava sede naturale il giudice civile; ciò anche in forza degli articoli 676 e 263 cod. proc. pen., secondo i quali la risoluzione delle controversie sulla proprietà delle cose sequestrate è rimessa al giudice civile [17].
In realtà il Codice Antimafia, in particolar modo all'art. 59, sembra aver accolto la tesi dominante in sede penale, attribuendo al giudice penale la competenza per accertare la buona fede del terzo.
Le Sezioni Unite, anche in questo caso, si esprimono sul problema valorizzando il dato normativo costituito dal comma 199 della Legge di Stabilità che, per l'ammissione della domanda del terzo, indicata come competente il “giudice dell'esecuzione presso il Tribunale che ha disposto la confisca”. La Suprema Corte, pur reputando poco corretto il riferimento al giudice dell'esecuzione, interpreta la norma come un chiaro riferimento al giudice penale, in dettaglio al tribunale – misure di prevenzione. La conclusione è inoltre sostenuta dal testo del comma 203 dell’art. 1- legge n. 228 del 2012 che fa riferimento “al tribunale del luogo che ha disposto la confisca”.
(*) Lo scritto è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
[1] Circa le tre ordinanze di remissione, CASS., 17.02.2012, n. 2338 - 2339 e 2340, che hanno condotto alla sentenza in oggetto, si vedano Giur. it., 2013, 335 e Nuova Giurisp. Civ. Comm., 2012, I, 878 con nota di FARACE.
[2] Si veda FORTE, Il Codice delle leggi antimafia e la crisi dell’impresa sottoposta a misure di prevenzione patrimoniali: analisi della nuova disciplina dei rapporti tra gli strumenti di intervento ablativo statuale e le procedure concorsuali, in questa rivista, II, 345/2013, ove vengono presentati anche gli aspetti analizzati nel presente scritto.
[3] Circa la legge di stabilità 2013, per le prime osservazioni DI LEGAMI – CHINNICI, Legge di stabilità e misure di prevenzione antimafia: prime osservazioni, in www.diritto24.ilsole24ore.com ove, pur criticando aspramente l’utilizzo di una legge-contenitore per innovare in una materia assai delicata, si considerano condivisibili alcune innovazioni evidenziando peraltro delle perplessità circa la disciplina della tutela dei diritti dei terzi creditori.
[4] In ordine all'attuale legislazione antimafia: BALSAMO - MALTESE, Il Codice antimafia, Giuffrè, 2011 e VERGINE, Il contrasto all’illegalità economica. Confisca e sequestro per equivalente, Cedam, 2012.
Senza pretese di esaustività vista la mole della pubblicistica, con riferimento alla previgente normativa: AMODIO, Le misure di prevenzione patrimoniale nella legge antimafia, in Giust. pen., 1985, III, 632;CENNICOLA, Le misure patrimoniali antimafia nell’esperienza applicativa, in Giur. merito, 1985, 1252;FIANDACA, La prevenzione antimafia tra difesa sociale e garanzie di legalità, in Foro it., 1987, II, 364; GALLO, voce «Misure di prevenzione», in Enc. giur. Treccani, XX, Ed. Enc. it., 1996;CASSANO, La tutela dei diritti dei terzi nella legislazione antimafia, in a cura diMAUGERI, Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione, Giuffrè, 2008.
[5] Circa le modalità di acquisto della proprietà, con particolare riferimento alla confisca, si vedano RUBINO, L’ipoteca immobiliare e mobiliare, nel Trattato Cicu - Messineo, XIX, Giuffrè, 1956 ed inoltre PUGLIATTI, voce «Acquisto: 1. Acquisto del diritto a) Teoria generale», in Enc. del dir., I, Giuffrè, 1958.
Con specifico riguardo all'estinzione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2878 c.c. GORLA, Del pegno. Delle ipoteche, sub artt. 2784-2899, in Comm. Scialoja - Branca, Zanichelli, 1968 evidenzia la natura non tassativa dell'elencazione di cui all'art. 2878 c.c. come peraltro confermato dal caso della usucapione di cosa ipotecata e della prescrizione acquisitiva di servitù sul fondo ipotecato, così TAMBURRINO, Della tutela dei diritti. Delle ipoteche, in Comm. cod. civ., VI, UTET, 1976.
[6] In dottrina si esprimono a favore della modalità di acquisto a titolo originario MAISANO, Misure patrimoniali antimafia e tutela dei creditori, in Giur. comm., 1986, I, 889 e, in modo particolarmente incisivo, MONTELEONE, Effetti «ultra partes» delle misure patrimoniali antimafia. Profili di diritto processuale civile e fallimentare, in Riv. trim. dir. e proc. Civ., 1988.
Nell'ambito della giurisprudenza si segnalano: TRIB. PALERMO, 18.04.1989 in Dir. Fall., 1990, II, 613 con nota difforme di AGUGLIA che sostiene la tesi derivativa; CASS. PEN., sez. un., 28.1.1998, n. 2 in Foro it., 1998, II, 462; CASS. PEN., 23.3.1998 in Rep. Foro it., 1998, Voce Misure di prevenzione n. 88; CASS. PEN., 22.4.1998, n. 1947, in Arch. nuova proc. pen., 1998, 171 e in Giur. it., 1999, 1275 con nota di INZERILLO; CASS. PEN., 4.12.1998, n. 7211 in Foro it., 1998, II, 462; TRIB. BARI, 16.10.2000, in Foro it., 2002, I, 291 con nota contraria di AJELLO e CASS. PEN., 04.6.2003, n. 38294 in Cass. pen., 2005, 2071 con nota di MOLINARI.
[7] MONTELEONE, op.cit.
[8] Per la tesi dell’acquisto a titolo derivativo: AIELLO, Le questioni civilistiche: quadro di riferimento generale, in MAZZARESE - AIELLO, Le misure patrimoniali antimafia. Interdisciplinarietà e questioni di diritto penale, civile e amministrativo, Giuffrè, 2010; POFI, Le incertezze della Suprema Corte in materia di confisca. Quale tutela per i creditori, in Giust. civ., 2010, I, 2059; EPIDENDIO, La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti, Cedam, 2011
[9] Si veda CASS., Sez. Un., 28.04.1999, n. 9 in Foro it., 1999, II, 571 che richiama l'articolata motivazione della decisione CASS., 3 luglio 1997, n. 5988 in Rep. Foro it., 1997, voce Misure di prevenzione, n. 105.
Si posizionano inoltre nell'ambito della medesima linea interpretativa: CASS. n. 6661, 30.03.2005, in Giust. civ., 2005, I, 2327; CASS., 16.1.2007, n. 845, in Dir. fall., 2008, II, 493 con nota aderente di FARINA, assai attenta agli aspetti processuali, ed inoltre CASS., 5.10.2010, n. 20664, inedita.
[10] GORGONI, Confisca antimafia e terzi creditori e titolari di diritti reali parziari, in questa rivista, II, 276/2011.
[11] Cit.
[12] In linea con l'orientamento giurisprudenziale dominante, circa il quale vedasi di seguito, sostengono che la confisca non faccia venire meno l'ipoteca MORICI - NICASTRO, Opponibilità allo Stato dell’ipoteca gravante su beni sequestrati e confiscati ai sensi della legge antimafia, in Riv. dir. civ., 1996, II, 667 secondo i quali l'opposta ipotesi costituisce un inutile sacrificio della posizione del terzo ed una violazione dei principi costituzionali. Aderisce alla medesima linea interpretativa CHIARAVIGLIO, Sequestro preventivo,confisca e diritti dei terzi, in Riv. dott. comm., 2004, 1395.
A favore dell'estinzione dell'ipoteca in caso di confisca: MONTELEONE, op. cit., pag. 581 e RAVAZZONI, Le ipoteche, nel Trattato Cicu - Messineo, LIII, Giuffrè, 2006.
Con specifico riguardo alla tutela dei terzi nel conflitto tra confisca e procedure concorsuali, nell’ambito dell’ampia pubblicistica si ricordano tra gli altri: GAITO, Fallimento, sequestro in funzione di confisca e tutela dei terzi nella repressione del fenomeno mafioso, in Giur. it. , 1985, II, 397; FABIANI, Misure di prevenzione patrimoniali e interferenze con le procedure concorsuali, in Fallimento., 1988, 329; TORRE, Confisca ex legge Rognoni-La Torre e tutela dei diritti dei terzi, in Dir. fall., 1989, I, 404; MOLINARI, Rapporti ed interferenze tra misure di prevenzione patrimoniali e fallimento - Un caso analogo di conflitto?, in Cass. pen., 2000, 749; PANZANI, Confisca di prevenzione e diritti dei terzi (C.S.M., Incontro di studio del sul tema: «La gestione giudiziale dell’impresa», Roma, 14 – 16 maggio 2001); AJELLO, Amministrazione e gestione delle imprese confiscate alla mafia, in Contr. e impr., 2004, 743; MALTESE, La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali, in BALSAMO -MALTESE, op. cit.
[13] La giurisprudenza è assolutamente costante nell’affermare la necessità di evitare di ledere la posizione del terzo purché il credito non sia strumentale all’attività illecita, o ne costituisca il frutto o il reimpiego, fatto salvo che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità. Per tutti si richiama CASS. PEN., sez. un., 28.4.1999, n. 9, cit., secondo la quale la “giurisprudenza di legittimità, sia penale che civile, è consolidata nel senso che nessuna forma di confisca può determinare l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in puntuale sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all’illecito”; conseguentemente la sentenza fa salvo il diritto di pegno su dei certificati di deposito.
Con particolare riguardo all’ipoteca si veda CASS. PEN., 11.2.2005, n. 12317, in Guida al diritto, 2008, 32, 111.
CASS., 29.10.2003, n. 16627 in Dir. fall., 2004, II, 1 con nota di RUSSO, afferma che l'ipoteca si estingue solo per le cause indicate dall'art. 2878, cause tra le quali non si include la confisca.
Va segnalata CASS., 26.1.2006, n. 1693, che, con riferimento alla normativa urbanistica, legge 28.1.1985, n. 47, sostiene, sulla base della natura originaria dell’acquisto operato dal Comune a seguito del provvedimento ablativo, la caducazione dei pesi e dei vincoli aldilà dell'anteriorità dei medesimi. La sentenza in Giur. it., 2007, 858 con nota di STRONA il quale reputa invece che il perimento dell’ipoteca è da imputarsi al fatto che l’acquisizione sia finalizzata alla demolizione, ovvero, alla conservazione, qualora si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblicistici.
Isolata CASS. PEN., 25.5.2006, n. 30783, che risulta allo scrivente inedita, secondo la quale l’ipoteca entrerebbe in uno stato di quiescenza.
[14] La giurisprudenza appare univoca nell’attribuire al terzo l’onere probatorio circa la propria buona fede; in CASS. PEN., sez. un., 28.4.1999, n. 9, cit. al terzo si fa carico l’onere della prova, oltre che della titolarietà del diritto, della mancanza di collegamento con la condotta delittuosa o dell'affidamento “incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza”.
Stante il quadro giurisprudenziale sopra rappresentato sorgono inevitabilmente delle perplessità circa i potenziali aspetti di rilievo costituzionale. In detta materia la Corte Costituzionale ha deciso per l’inammissibilità per indeterminatezza dell’oggetto con sentenza 14 aprile 1988 n. 455, in Giur. cost., 1988, I, 2083, in seguito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Palermo con ordinanza 19 aprile 1986, in Fallimento, 1986, 1134, con nota di BONGIORNO; si veda anche FIANDACA in Foro it., 1987, 1920.
Le successive decisioni della Corte Costituzionale hanno confermato la linea dell’inammissibilità; si vedano CORTE COST., 19.05.1994, n. 190, in Dir. fall., 1994, II, 869, con nota di RAGUSA MAGGIORE e CORTE COST., 8.10.1996, n. 335, in Foro it. , 1997, I, 21.
[15] Nell'ambito della dottrina si esprime a favore della competenza del giudice civile, con un articolato intervento, BONGIORNO, La giustizia civile tra nuovissime riforme e diritto vivente - Gli attuali contrasti giurisprudenziali in materia di vendite forzate dei beni confiscati, in Giur. it., 2009, 6 ed inoltre FARINA, Sulla tutela dei creditori ipotecari e dell’aggiudicatario nell’espropriazione dei beni confiscati, op. cit. nonché PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche, IV, Il processo di esecuzione, Giappichelli, 2010.
Per l'opposto orientamento, favorevole alla giurisdizione penale, tra gli altri: SIRACUSANO, Commento all’art. 14, in Leg. Pen., 1983, 307.
Si ricorda inoltre DALL'ANNO, È davvero ipotizzabile una ipotesi di conflitto di competenza tra giudice penale e giudice civile?, in Cass. pen., 2000, 90.
[16] In tale senso oltre alla più volte citata CASS. PEN., sez. un., 28.4.1999, n. 9, cit., anche Trib. Palermo,23.6.2001, in Fallimento, 2002, 659, con nota di CASSANO; Trib. Palermo, 16.5.2003, in Dir. fall., 2004, II, 1 ss., con nota di RUSSO che sostiene, riportando la massima di CASS., 29.10.2003, n. 16227, la tesi opposta; CASS. PEN., 5.12.2007, n. 45572 inedita; Trib. Palermo,14.7.2009, in Giust. civ., 2010, I, 2059, con nota di POFI.
[17] A favore dell'orientamento che attribuisce la competenza al giudice civile si vedano in particolare CASS., 29.10.2003, n. 16227, cit., e CASS., 16.1.2007, n. 845 che reputa surrettizio, rispetto al giudice dell'opposizione all'esecuzione forzata civile, l'istituto dell'incidente di esecuzione penale, che verrebbe quindi utilizzato al di fuori dei propri limiti. Questa ultima decisione in Esecuzione forzata, 2008, 2-3 con nota di RUSSO che ripercorre l’iter della giurisprudenza in materia sollecitando un intervento delle Sezioni Unite.
Va inoltre ricordata, ancorché isolata e non adeguatamente motivata, CASS. PEN., 5.10.2010, n. 20664, cit., la quale brevemente afferma che non “possa farsi distinzione in punto di competenza del giudice adito, tra il giudice civile e penale”
Scarica Articolo PDF