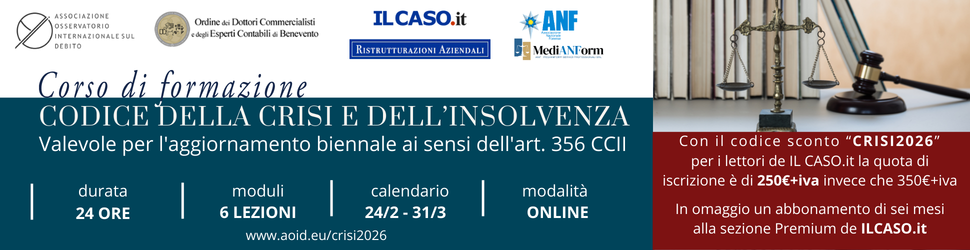Bancario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 20/06/2024 Scarica PDF
Discorso di Mario Draghi per il Premio europeo Carlo V consegnatogli il 14 giugno 2024 da Re Felipe VI di Spagna
Mario Draghi, già Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Presidente della Banca centrale europea, Governatore della Banca d'Italia, Direttore generale del Ministero del tesoroSua Maestà.
Presidente del governo regionale dell'Estremadura.
Presidente dell'assemblea dell'Estremadura.
Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione accademia europea e Iberoamericana di Yuste.
Ministro degli Affari esteri, dell'Unione europea e della Cooperazione.
Ministro dell'Economia, del Commercio e delle Imprese.
Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea.
Ambasciatori.
Vicepresidente della Banca centrale europea.
Vescovo di Plasencia e frati della comunità monastica.
Accademici.
Autorità.
Ospiti d'onore e amici.
Vorrei iniziare ringraziando Sua maestà Re Felipe VI per le sue parole eccezionalmente gentili. E’ un grande onore per me ricevere il Premio europeo Carlo V – e in un contesto così storico.
Questo monastero, in quanto ultima dimora di Carlo V, ricorda la lunga e ricca storia dell'Europa e il processo secolare di costruzione dell'unità europea. Nel corso degli anni, il nostro continente è diventato più vecchio, più ricco e più vicino, con un mercato unico di 445 milioni di consumatori. Ma oggi ci troviamo di fronte a questioni fondamentali per il nostro futuro. Con l'invecchiamento delle nostre società, aumentano le esigenze del nostro modello sociale. Allo stesso tempo, per gli europei mantenere alti livelli di protezione sociale e di ridistribuzione non è negoziabile. Dobbiamo anche far fronte a nuove esigenze: adeguarci ai rapidi cambiamenti tecnologici, aumentare la capacità di difesa e realizzare la transizione verde. E nel frattempo, il precedente paradigma che sosteneva i nostri obiettivi comuni sta scomparendo. L'era del gas importato dalla Russia e del commercio mondiale aperto sta svanendo.
Quindi, per far fronte a tutti questi cambiamenti, dovremo crescere più velocemente e meglio. E il modo principale per ottenere una crescita più rapida è aumentare la nostra produttività.
La crescita della produttività europea sta rallentando da tempo. Dall'inizio degli anni 2000, il pil pro capite a Ppa (cioè aggiustato per i prezzi interni) è stato inferiore di circa un terzo rispetto a quello degli Stati Uniti, e circa il 70 per cento di questo divario è spiegato dalla minore produttività. La differenza di crescita della produttività tra le due economie è dovuta principalmente al settore tecnologico e alla digitalizzazione in generale. Se escludessimo il settore tecnologico, la crescita della produttività dell'Ue negli ultimi vent'anni sarebbe pari a quella degli Stati Uniti.
Ma il divario potrebbe aumentare ulteriormente con il rapido sviluppo e la diffusione dell'intelligenza artificiale. Circa il 70 per cento dei modelli fondamentali di intelligenza artificiale viene sviluppato negli Stati Uniti e solo tre aziende statunitensi rappresentano il 65 per cento del mercato globale del cloud computing. Per iniziare a colmare questo divario è necessaria una serie di azioni politiche.
Innanzitutto, dobbiamo ridurre il prezzo dell'energia. Gli utenti industriali dell'energia in Europa si trovano attualmente in una situazione di grande svantaggio competitivo rispetto ai loro colleghi statunitensi, con prezzi 2-3 volte superiori per l'elettricità. Questo differenziale di prezzo è dovuto principalmente al nostro ritardo nell'installazione di nuove capacità energetiche pulite e alla mancanza di risorse naturali, oltre che al nostro limitato potere contrattuale collettivo, nonostante siamo il più grande acquirente di gas naturale al mondo. Ma è anche causato da problemi fondamentali del nostro mercato interno dell'energia.
Soffriamo di investimenti infrastrutturali lenti e non ottimali, sia per le energie rinnovabili che per le reti. Le reti poco sviluppate ci impediscono di soddisfare la domanda di energia anche in presenza di eccedenze in alcune parti dell'Ue. Abbiamo regole di mercato che non disaccoppiano completamente il prezzo dell'energia rinnovabile e nucleare dai prezzi più alti e più volatili dei combustibili fossili, impedendo alle industrie e alle famiglie di cogliere appieno i benefici dell'energia pulita nelle loro bollette. Inoltre, nel tempo la tassazione dell'energia è diventata un'importante fonte di entrate di bilancio, contribuendo all'aumento dei prezzi al dettaglio.
Questi prezzi elevati stanno portando a una riduzione degli investimenti in Europa: l'anno scorso, circa il 60 per cento delle aziende europee ha dichiarato che i prezzi dell'energia erano un ostacolo importante agli investimenti – oltre 20 punti percentuali in più rispetto alla risposta delle aziende statunitensi. Inoltre, i prezzi impediscono di rendere la produzione più digitale, poiché l'intelligenza artificiale è ad alta intensità energetica. L'Agenzia internazionale dell'energia prevede che l'elettricità consumata dai data center raddoppierà a livello globale entro il 2026, un aumento pari all'intera domanda di elettricità della Germania. Una maggiore produttività dipende quindi dalla costruzione di un vero mercato europeo dell'energia.
Occorre poi ripensare l'ambiente dell'innovazione in Europa. In percentuale del pil, le imprese europee spendono circa la metà di quelle statunitensi per la ricerca e l'innovazione (R&I), con un divario di investimenti di circa 270 miliardi di euro all'anno. Anche il passaggio dalla ricerca fondamentale alla commercializzazione delle idee è molto più debole.
Non ci sono cluster di innovazione europei tra i primi 10 a livello globale e le nostre università faticano a trattenere i migliori talenti.
L'Ue deve quindi definire la R&I come una priorità collettiva. Un'agenda comune potrebbe includere un maggiore sostegno alla ricerca fondamentale, incentrato sull'eccellenza accademica, una maggiore attenzione all'innovazione dirompente e una maggiore capacità di sostenere le start-up e aiutarle a crescere.
Dobbiamo inoltre creare le condizioni affinché l'innovazione si diffonda più rapidamente nell'economia. I fattori chiave sono: consentire alle imprese europee di raggiungere una scala ottimale, in modo da avere la capacità di investire in nuove tecnologie, e riqualificare i lavoratori europei, in modo che possano padroneggiare queste tecnologie.
Per raggiungere la scala è necessario eliminare le barriere che ancora si frappongono alle attività transfrontaliere all'interno del mercato unico, in particolare quelle che ostacolano la diffusione del digitale. Ad esempio, il cloud computing nella pubblica amministrazione deve essere disciplinato da un unico insieme di norme. E la politica della concorrenza deve facilitare la scalabilità, ponderando i criteri di innovazione e resilienza in base all'evoluzione del mercato e dei contesti geopolitici, evitando al contempo un'eccessiva concentrazione di mercato che fa aumentare i prezzi al consumo e diminuisce la qualità del servizio.
Allo stesso tempo, per riqualificare la nostra forza lavoro sarà necessario rafforzare i sistemi di istruzione e formazione, incoraggiare l'apprendimento degli adulti e facilitare l'ingresso di lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi.
L'esempio della Svezia – che ha un settore tecnologico più che doppio rispetto alla media dell'Ue – dimostra che un modello sociale forte e il progresso tecnologico non solo sono compatibili, ma si auto-rinforzano quando si concentrano sulla riqualificazione e sulle competenze.
Il finanziamento di queste diverse esigenze di investimento sarà una sfida significativa e richiederà un ripensamento del modo in cui impieghiamo il capitale pubblico e privato. Rispetto agli Stati Uniti, l'assenza di un bilancio federale ci pone in una posizione di svantaggio. Ad esempio, la R&I finanziata con fondi pubblici rappresenta una percentuale simile del pil in entrambe le regioni, intorno allo 0,7-0,8 per cento, ma negli Stati Uniti la maggior parte della spesa avviene a livello federale, garantendo che i fondi pubblici fluiscano in modo efficiente verso le priorità nazionali.
In Europa, invece, gli strumenti di finanziamento sono divisi tra il livello europeo e quello nazionale – solo un decimo della spesa per la R&I è europea -– con una scarsa definizione delle priorità o un basso coordinamento. Inoltre, il processo decisionale sui progetti comuni richiede in genere un lungo processo legislativo con molteplici veti lungo il percorso.
Allo stesso tempo, i vari livelli di regolamentazione hanno creato un onere per gli investimenti a lungo termine, come ha riferito il 61 per cento delle imprese dell'Ue lo scorso anno.
Esistono quindi ampi margini di miglioramento semplicemente definendo priorità più chiare, razionalizzando la normativa e coordinando meglio i diversi strumenti di finanziamento. Detto questo, anche rendere più efficace la spesa pubblica non sarà sufficiente. Il fabbisogno di finanziamenti per la transizione verde e digitale è enorme e, dato lo spazio fiscale limitato in Europa sia a livello nazionale che, almeno finora, a livello europeo, dovrà essere fornito principalmente dal settore privato.
Pertanto, dovremo anche mobilitare il risparmio privato su una scala senza precedenti, ben al di là di quanto può fornire il settore bancario. Il modo principale per raccogliere i fondi necessari sarà l'approfondimento dei mercati del capitale di rischio, delle azioni e delle obbligazioni.
Inoltre, nei settori in cui gli investimenti pubblici hanno grandi moltiplicatori, come la spesa per le reti o la R&I, è probabile che l'emissione di più debito pubblico si autofinanzi. Semplificare i progetti europei di interesse comune e ampliarne la portata li renderebbe uno strumento efficace per aumentare gli investimenti in aree critiche. Il paradigma che ci ha portato alla prosperità in passato era stato concepito per un mondo di stabilità geopolitica, il che significava che le considerazioni sulla sicurezza nazionale avevano un ruolo limitato nelle decisioni economiche. Ma le relazioni geopolitiche si stanno ora deteriorando.
Questo cambiamento richiede che l'Europa adotti un approccio fondamentalmente diverso alla sua capacità industriale in settori strategici come la difesa, lo spazio, i minerali critici e parti di prodotti farmaceutici. E richiede anche di ridurre la nostra dipendenza da paesi di cui non possiamo più fidarci.
La prima cosa di cui abbiamo bisogno, quindi, è una valutazione comune dei rischi geopolitici che dobbiamo affrontare, condivisa dagli Stati membri e in grado di guidare la nostra risposta.
Poi, dovremo sviluppare una vera e propria "politica economica estera" – la cosiddetta statecraft – che coordini gli accordi commerciali preferenziali e gli investimenti diretti con i paesi ricchi di risorse, la costituzione di scorte in aree critiche selezionate e la creazione di partenariati industriali per garantire la catena di approvvigionamento delle tecnologie chiave.
Per i settori strategici, le stesse misure che ho già descritto relative all'innovazione, alla scala e alle competenze saranno particolarmente utili. Tuttavia, poiché alcuni di questi settori partono da anni di sottoinvestimento, richiederanno anche un approccio coordinato alla domanda.
Affinché le imprese incrementino gli investimenti e la capacità produttiva, l'Europa dovrà non solo aumentare il livello della domanda attraverso una spesa più elevata, ma anche garantire che questa si concentri all'interno dei nostri confini e che venga aggregata a livello europeo.
Il modo più efficiente per generare questa domanda sarebbe quello di aumentare la spesa comune europea. Ma in assenza di un tale approccio centralizzato, possiamo ottenere molto coordinando più strettamente le politiche di approvvigionamento pubblico e applicando requisiti più espliciti di contenuto locale per i prodotti e i componenti prodotti nell'Ue.
Questa concentrazione e aggregazione della domanda aumenterà anche l'efficacia della spesa pubblica, riducendo le duplicazioni e aumentando l'interoperabilità, soprattutto per le attrezzature militari. E corrisponderà alle politiche applicate dai nostri rivali geopolitici.
Il paradigma che ci ha portato alla prosperità in passato era anche quello in cui il commercio mondiale era governato da regole multilaterali. Ma ora queste regole sono sempre meno vincolanti e le economie più grandi operano sempre più unilateralmente. Non vogliamo diventare protezionisti in Europa, ma non possiamo rimanere passivi se le azioni degli altri minacciano la nostra prosperità. Anche le recenti decisioni degli Stati Uniti di imporre tariffe alla Cina hanno implicazioni per la nostra economia attraverso il riorientamento delle esportazioni. La sfida che dobbiamo affrontare è che, rispetto agli Stati Uniti, siamo più vulnerabili sia all'inazione sul commercio che alle ritorsioni. Il settore manifatturiero europeo impiega un numero di persone due volte e mezzo superiore a quello degli Stati Uniti. Inoltre, più di un terzo del nostro pil manifatturiero viene assorbito al di fuori dell'Ue, rispetto a circa un quinto degli Stati Uniti.
Tuttavia, ora ci troviamo di fronte a un'ondata di importazioni cinesi più economiche e talvolta tecnologicamente più avanzate. Al più tardi entro il 2030, si prevede che la capacità produttiva annuale della Cina per il solare fotovoltaico sarà il doppio del livello della domanda globale e per le celle a batteria sarà almeno pari al livello della domanda globale. Nella misura in cui questa notevole crescita dell'offerta è il risultato di autentici miglioramenti della produttività e dell'innovazione, è un bene per l'Europa. Ma è anche ampiamente dimostrato che una parte dei progressi della Cina è dovuta a consistenti sussidi ai costi, alla protezione commerciale e alla soppressione della domanda, e questa parte porterà a una riduzione dell'occupazione per la nostra economia.
Secondo una stima prudente, nel 2019 la Cina ha speso per la politica industriale circa il triplo della Germania o della Francia in percentuale del pil e, in termini di dollari a Ppa, circa dieci volte più di entrambi i paesi messi insieme.
Nell'ambito di questa strategia industriale generale, la crescita dei salari cinesi non ha tenuto il passo con l'aumento della produttività nel tempo, mentre i tassi di risparmio rimangono elevati, lasciando i consumi delle famiglie ad appena il 44 per cento del pil.
La prima risposta europea al cambiamento delle regole del commercio mondiale dovrebbe essere quella di cercare di riparare il più possibile i danni all'ordine commerciale multilaterale, incoraggiando tutti i partner disposti a impegnarsi nuovamente per un commercio basato sulle regole. La seconda risposta dovrebbe essere quella di incoraggiare gli investimenti esteri diretti, in modo che i posti di lavoro nel settore manifatturiero rimangano in Europa. La terza risposta dovrebbe essere l'utilizzo di sussidi e tariffe per compensare gli ingiusti vantaggi creati dalle politiche industriali e dalle svalutazioni dei tassi di cambio reali all'estero. Ma se intraprendiamo questa strada, deve essere nell'ambito di un approccio generale pragmatico, cauto e coerente.
L'uso di tariffe e sussidi deve essere basato su principi e coerente con la massimizzazione della nostra crescita di produttività. Ciò significa distinguere l'innovazione genuina e i miglioramenti della produttività all'estero dalla concorrenza sleale e dalla soppressione della domanda. Dovrebbe evitare di creare incentivi perversi che minano l'industria europea. Le tariffe devono quindi essere valutate in modo coerente in tutte le fasi della produzione ed essere compatibili con gli incentivi, soprattutto per non indurre la de-localizzazione delle nostre industrie.
E le tariffe devono essere bilanciate dagli interessi dei consumatori. In alcuni settori i produttori nazionali hanno già accumulato un ritardo eccessivo e quindi rendere le importazioni più costose imporrebbe solo costi morti all'economia.
La relazione al presidente della Commissione europea delineerà una politica industriale europea in grado di raggiungere gli obiettivi fondamentali dei cittadini europei. Questa politica industriale mirerà soprattutto ad aumentare la produttività, a preservare la competitività delle nostre industrie nel mondo e la concorrenza all'interno dell'Europa. Essa mirerà a proseguire la decarbonizzazione della nostra economia, in modo da ridurre i prezzi dell'energia e garantire una maggiore sicurezza energetica.
Si tratterà di riorientare la nostra economia in un mondo meno stabile, in particolare sviluppando una capacità industriale di difesa e una politica commerciale in grado di soddisfare le nostre esigenze geopolitiche, riducendo al contempo le dipendenze geopolitiche da Paesi su cui non possiamo più contare. All'inizio del mio intervento ho detto che il mantenimento di alti livelli di protezione sociale e di ridistribuzione non è negoziabile. In conclusione, vorrei ribadire che la lotta all'esclusione sociale sarà fondamentale non solo per preservare i valori di equità sociale della nostra Unione, ma anche per far sì che il nostro viaggio verso una società più tecnologica abbia successo. La fonte più significativa della disuguaglianza di reddito è la disoccupazione. Storicamente, le politiche macroeconomiche, se ben concepite, sono state la risposta. In questo momento, e più in generale, sono altrettanto essenziali le politiche del mercato del lavoro e una risposta corretta alla concorrenza sleale proveniente dall'estero. E questa politica industriale completerà anche il nostro sistema di sicurezza sociale come base per l'inclusione sociale in tempi di profondi cambiamenti tecnologici. Le decisioni che queste politiche richiederanno saranno urgenti perché il ritmo del cambiamento tecnologico e climatico sta accelerando e siamo sempre più esposti al peggioramento delle relazioni internazionali.
Queste decisioni saranno anche importanti dal punto di vista politico e finanziario. E potrebbero anche richiedere un grado ancora inedito di cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri dell'Unione europea. Oggi questo passo appare scoraggiante. Tuttavia, sono fiducioso che abbiamo la determinazione, la responsabilità e la solidarietà per affrontarlo – per difendere la nostra occupazione, il nostro clima, i nostri valori di equità e inclusione sociale e la nostra indipendenza.
14 giugno 2024
Scarica Articolo PDF