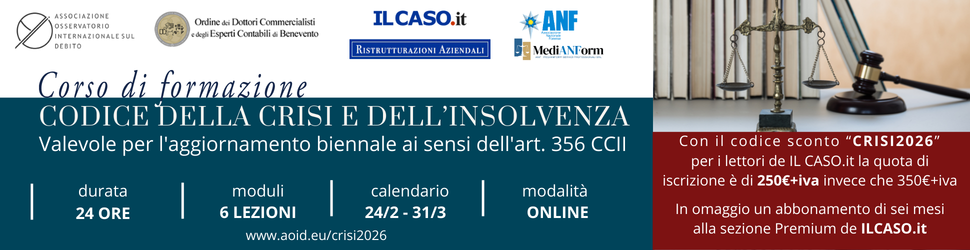ProcCivile
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 12/02/2014 Scarica PDF
L'art. 185 bis c.p.c.: un nuovo impulso alla conciliazione giudiziale?
Massimo Vaccari, MagistratoSommario: 1. Il testo originario della norma - 2. Le modifiche apportate in sede di conversione - 3. L’individuazione dell’ambito di applicazione della norma attraverso il suo coordinamento con l’art. 91, primo comma secondo periodo, c.p.c - 4. Tempi e modalità di formulazione della proposta. Le difficoltà conseguenti alla necessità di fissare il calendario del processo - 5. Il coordinamento tra i diversi sistemi alternativi di risoluzione delle controversie civili presenti nel nostro ordinamento
1. Il testo originario della norma
L’art. 77, comma 1, lett. a) del decreto legge 15 giugno 2013 n. 69 (c.d. decreto del fare), ha inserito dopo l’articolo 185 c.p.c., un nuovo articolo, il 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) il cui testo originario era il seguente: “Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.”[1]
Il legislatore, attraverso la previsione di un obbligo per il giudice di formulare alle parti una proposta conciliativa e l’attribuzione di un preciso significato al rifiuto di essa senza un giustificato motivo, aveva esteso, di fatto, al fine di favorire la conciliazione giudiziale, quella che prima era una disciplina del solo processo del lavoro[2] anche al giudizio ordinario di cognizione, ovviando così ad una disparità di disciplina tra i due giudizi che non era stata fino a questo momento giustificata, come chi scrive aveva evidenziato tempo addietro in un altro scritto[3].
La norma aveva anche chiarito che il giudice era abilitato alla formulazione della proposta di definizione amichevole del contenzioso ed anzi era tenuto a farlo[4]. Prima di questo intervento la questione non era affatto pacifica poiché l’unica norma che menzionava l’istituto della proposta conciliativa (l’art. 91, comma 1, introdotto dalla legge 4 luglio 2009 n. 69) non individuava anche i soggetti legittimati ad avanzarla. Mentre era indubbio che tra loro rientrassero le parti e i rispettivi difensori, anche se non muniti di procura speciale, era controverso se vi fosse ricompreso anche il giudice[5].
Ancora, la nuova disposizione aveva individuato i momenti processuali in cui la proposta conciliativa andava formulata (“alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione”) e, al pari della modifica del testo del comma 1 dell’art. 420 c.p.c, avevaqualificato la proposta di risoluzione come «transattiva o conciliativa».
Con riguardo a questa parte della previsione è opportuno rammentare come da tempo sia la dottrina che la giurisprudenza abbiano chiarito la distinzione tra l’istituto della transazione e quello della conciliazione giudiziale. In primo luogo sotto il profilo formale la prima è atto di diritto sostanziale mentre la seconda è istituto di diritto processuale. In secondo luogo la conciliazione è un negozio processuale trilaterale in quanto l’accordo tra le parti viene raggiunto grazie all’intervento di un terzo[6] e viene consacrato in un atto avente valenza di atto pubblico.
Sotto il profilo sostanziale la conciliazione giudiziale deve necessariamente riguardare la materia del contendere mentre la transazione può riguardare anche rapporti ulteriori e diversi da quello dedotti in causa, intercorrenti tra le stesse parti, sebbene possa essere redatta anche sotto forma di conciliazione giudiziale[7]. E’ stato anche notato che il contenuto della conciliazione può determinare l’accoglimento della domanda mentre ciò è pressochè impossibile per la transazione che comporta sempre reciproche concessioni e quindi l’accoglimento non integrale della domanda[8].
Sulla scorta delle superiori considerazioni è possibile affermare che il legislatore pur nell’ambito della previsione della obbligatorietà di una iniziativa di definizione amichevole del giudice aveva inteso attribuire a questi una discrezionalità nella scelta dello strumento conciliativo più opportuno, optando, a seconda dei casi, per una prospettiva più strettamente attinente alla materia del contendere o per una di carattere transattivo e, come tale, legata agli interessi delle parti eventualmente emersi nel corso del giudizio, e fondata su “reciproche rinunce”[9].
2. Le modifiche apportate in sede di conversione
In sede di conversione, operata dalla legge 9 agosto 2013 n.98[10], il testo ha subito significative modifiche e ha assunto la attuale versione che è la seguente: “Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”.
L'obbligo per il giudice di formulare una proposta di soluzione concordata della lite è quindi divenuto una facoltà, da esercitarsi sulla base di una valutazione delle caratteristiche della causa (natura e valore del giudizio, esistenza di questioni di diritto di facile e pronta soluzione).
E’ stato così eliminato quello che, a giudizio di chi scrive, era l’aspetto più critico della norma.
Non si comprendeva infatti la ragione dell’originario obbligo per il giudice di formulare la proposta conciliativa, a prescindere dalla tipologia della controversia[11] o dalla disponibilità delle parti a transigere, quando nella comune esperienza giudiziale si riscontra come tali variabili influenzino in maniera rilevante la possibilità di individuare una soluzione conciliativa[12].
A sconsigliare quella scelta avrebbe potuto concorre anche l’ulteriore considerazione che, qualora la proposta risultasse conveniente per solo una o alcune delle parti, queste molto difficilmente considererebbero soluzioni conciliative diverse cosicchè va attentamente valutato se sia opportuno formularla.
E’ stato quindi senza dubbio opportuno demandare al giudice la valutazione, sul punto, al giudice a seconda delle caratteristiche del caso concreto.
Non è altrettanto condivisibile invece la scelta di sopprimere la parte della norma che prevedeva le conseguenze sanzionatorie nei casi di rifiuto della proposta giudiziale senza giustificato motivo.
Quella versione presentava almeno tre vantaggi. Da un lato infatti, analogamente ad altre recenti disposizioni[13], consentiva di attribuire il massimo rilievo al rifiuto della proposta conciliativa, equiparandolo, in una prospettiva al tempo stesso sanzionatoria e di semplificazione del giudizio, ad un argomento di prova sul quale fondare la decisione, e costituiva quindi una declinazione del principio generale affermato dall’art. 116, comma 2, c.p.c. e di sempre più frequente applicazione nella giurisprudenza anche di legittimità[14].
In secondo luogo consentiva di svincolarsi dalle difficoltà operative del meccanismo dell’art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c.,[15] poiché semplificava, rispetto all’ipotesi della proposta conciliativa, la quantificazione della condanna alle spese, comunque possibile, consentendo di fare oggetto di essa tutte le spese sostenute dalla parte che avesse accettato la proposta conciliativa e non solo quelle maturate dopo il momento della sua formulazione, e rendeva più persuasiva quel tipo di iniziativa giudiziale attraverso il rischio di un maggior carico delle spese.[16]
Nella stessa prospettiva la prima versione ricollegava le medesime conseguenze al rifiuto della proposta conciliativa e a quello della proposta transattiva, mentre l’art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c., menziona solo la prima[17].
All’intervento correttivo parlamentare, può poi muoversi l’ulteriore rilievo che esso ha nuovamente differenziato la disciplina vigente nel giudizio ordinario rispetto a quella del processo del lavoro, sebbene tale discrepanza non sia giustificata poiché non vi è nessuna ragione logica o giuridica che consenta di attribuire al rifiuto della proposta conciliativa o transattiva del giudice nell’ambito del processo del lavoro una maggiore valenza di quella che lo stesso atteggiamento assume nell’ambito del giudizio ordinario.
Pure a fronte della previsione della facoltatività della proposta conciliativa o transattiva, appare poi superflua la precisazione che la formulazione di essa non costituisce motivo di astensione o ricusazione poiché tale conseguenza poteva essere esclusa già in virtù di una attenta considerazione della funzione che il giudice assume nella conciliazione giudiziale, quale è stata posta in luce da parte della dottrina[18] e anche da qualche pronuncia di merito[19].
A ben vedere anche il legislatore ha dimostrato di seguire tale concezione nel momento in cui, nell’ambito della disciplina del processo societario, aveva attribuito al giudice, sia pure limitatamente alle controversie societarie, un ruolo maggiormente propositivo nell’ambito del tentativo di conciliazione.
Ci si riferisce al già citato art. 16, 2°comma, d.lgs. n. 5/2003[20], ora abrogato, e all’art. 2378, 4°comma, c.c., introdotto dal d.lgs. n. 6/2003 (Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), che ha previsto che all’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione della delibera assembleare di s.p.a.: “… il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l’udienza”.
L’intervento sull’art. 185 bis c.p.c. operato in sede di conversione ha inteso però fugare i dubbi che altra parte della dottrina[21] aveva sollevato sulla questione in esame, sul presupposto, invero errato per quanto appena detto, che il giudice formulando una proposta conciliativa anticipa indebitamente il giudizio[22], cosicchè esso, anche per le ulteriori ragioni che subito si diranno, ha assunto una valenza meramente interpretativa.
3. L’individuazione dell’ambito di applicazione della norma attraverso il suo coordinamento con l’art. 91, primo comma secondo periodo, c.p.c.
Il legislatore parlamentare, in sede di conversione del d.l.69/2013, ha omesso di disciplinare la fase successiva alla formulazione dell‘eventuale proposta di soluzione amichevole del giudice ma la definizione di tale aspetto è indispensabile per poter individuare l’ambito di applicazione della nuova previsione.
Ad avviso di chi scrive essa va necessariamente integrata, perlomeno rispetto all’eventualità che dal giudice provenga una proposta conciliativa, con l’art. 91, comma 1, secondo periodo c.p.c[23][24], cosicchè, solo se il rifiuto di essa sarà sorretto da un giustificato motivo non vi saranno conseguenze per la parte che lo abbia opposto mentre in caso contrario essa sarà condannata alla rifusione delle spese maturate dopo la formulazione della proposta, salvo che non sussistano i presupposti per la loro compensazione parziale o integrale.
Per comprendere il significato della nozione di giustificato motivo occorre rimandare all’esegesi che di essa è stata data in sede di commento all’art. 91, primo comma, secondo periodo c.p.c. In estrema sintesi può dirsi che, a parte l’ipotesi, invero marginale, in cui la proposta non sia idonea a definire il giudizio[25], il giustificato motivo corrisponde alla ragionevole previsione di poter ottenere dalla pronuncia un risultato economico più vantaggioso di quello conseguibile con l’accettazione della proposta[26].
Per poter addivenire alla condanna occorre seguire un procedimento articolato in due momenti, ossia dapprima l’individuazione della “misura della proposta” (espressione che si rinviene nell’art.91, comma 1, secondo periodo c.p.c) e subito dopo l’esclusione della sussistenza di un giustificato motivo per rifiutarla. Questa seconda valutazione implica che ci si ponga nel momento processuale al quale risale la proposta conciliativa e si stabilisca, sulla base delle prospettazioni delle parti e delle emergenze processuali di quel momento, quindi secondo un criterio prognostico ex ante, se la previsione della parte non conciliante sull’esito economicamente vantaggioso per essa del giudizio fosse stata fondata o meno[27].
Con riguardo alla quantificazione della condanna è opportuno evidenziare come, dopo l’introduzione ad opera del d.m. 140 del 2012 di un metodo di liquidazione delle spese di lite basato sulla ripartizione del giudizio ordinario in più fasi (fase di studio, introduttiva, istruttoria o decisoria) e sull’individuazione di valori medi di liquidazione per ciascuna di esse, risulta semplificato il calcolo al quale deve procedere il giudice per determinare l’entità delle spese alla cui rifusione ha diritto la parte, pur soccombente che avesse accettato la proposta. Sarà infatti sufficiente che l’organo giudicante individui in quale delle predetti fasi si collochi la proposta conciliativa e poi quantifichi le spese maturate nella fase o nella frazione di fase[28] successive ad esso.
Le considerazioni sin qui svolte non valgono nel caso in cui il giudice si determinasse ad avanzare una proposta transattiva poiché l’art. 91, primo comma, secondo periodo c.p.c. non menziona anche una simile ipotesi e la soluzione non pare casuale. La suddetta previsione, infatti, non può nemmeno applicarsi al rifiuto di una proposta transattiva poiché presuppone la possibilità di confrontare la domanda giudiziale, da un lato, con l’esito del giudizio e, dall’altro, con il contenuto della proposta e tale raffronto non è possibile rispetto ad una proposta transattiva che implica, per sua natura, come si è detto, la definizione di rapporti ulteriori rispetto a quello dedotto in causa. Deve quindi prendersi atto che per il diniego della proposta transattiva non sono previste conseguenze e tale lacuna, indubbiamente, costituire un ostacolo all’impiego dell’istituto.
La collocazione sistematica dell’art. 185 bis c.p.c. indurrebbe a ritenere che esso possa trovare applicazione solamente nei giudizi di cognizione ordinaria in cui si controverta di diritti disponibili [29][30]. In realtà non vi sono ostacoli, sotto il profilo teorico, ad ammettere la formulazione di proposte conciliative, sempre a discrezione del giudice, anche in altri giudizi come nel procedimento camerale[31] o nel giudizio sommario di cognizione o in quello cautelare che possa concludersi con una condanna alle spese (art. 669 septies,, comma 2 e art. 669 octies, terz’ultimo comma, ,c.p.c..). Il maggiore limite ad una simile soluzione deriva invece dalla durata solitamente contenuta delle tipologia di procedimenti suddetti poiché tale caratteristica comporta un minimo effetto persuasivo connesso alla prospettiva del rifiuto della eventuale proposta conciliativa che fosse avanzata nel corso di essi.
La scelta del legislatore di individuare le caratteristiche della controversia in cui il giudice può determinarsi a formulare una proposta conciliativa o transattiva, a parere dello scrivente, non pare essere stata sorretta da adeguata ponderazione.
Infatti sia un giudizio che risulti definibile prontamente in punto di fatto, ad esempio per mancata specifica contestazione dei fatti dedotti dalla controparte, o quello che involga questioni complesse in punto di diritto possono predisporre il giudice ad assumere una simile iniziativa e le parti ad aderirvi, sia pure per ragioni opposte nell’uno e nell’altro caso.
Nel primo infatti potrebbero essere indotte ad accettare la proposta dalla prospettiva di evitare una decisione che, presumibilmente, sopraggiungerà in tempi brevi mentre nel secondo dalla incertezza sull’esito del giudizio e dal rischio conseguente che il contezioso si articoli in tutti i gradi di giudizio possibili.
In questa prospettiva risulta invece assai più appropriata il testo dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 28/2010 che individua tra gli elementi che il giudice può prendere in considerazione, al fine di disporre la mediazione, “la natura della causa” e “il comportamento delle parti” (il terzo elemento è lo stato dell’istruzione), ossia proprio le due variabili che possono meglio indirizzare l’autorità giudiziaria nella sua valutazione sulla opportunità di individuare soluzioni conciliative della lite.
Alla luce delle suddette considerazioni le indicazioni presenti nell’art. 185 bis c.p.c. vanno intese non già quali limiti all’impiego della proposta ma piuttosto come criteri, non vincolanti né esclusivi, ai quali il giudice può ispirarsi nell’esercizio della sua discrezionalità.
4. Tempi e modalità di formulazione della proposta. Le difficoltà conseguenti alla necessità di fissare il calendario del processo
Continuando nell’esame della disposizione, non può sfuggire come il dato testuale sembri limitare la possibilità per il giudice di formulare la proposta conciliativa ad alcuni momenti processuali (prima udienza o fase istruttoria[32]), vietandola quindi implicitamente per la fase di decisione. Tale conclusione non pare però essere il frutto di una scelta consapevole del legislatore quanto piuttosto il risultato, non considerato, della modifica della seconda parte della norma operata in sede di conversione. Se si pone attenzione alla versione originaria di essa ci si avvede che nel momento in cui imponeva al giudice di formulare la proposta conciliativa non escludeva che egli avesse la facoltà di farlo in un momento successivo, ed anche qualora avesse già avanzato, senza esito, una precedente proposta.
Del resto, come è stato stata giustamente notato da alcuni autori[33], consentire la responsabile delibazione e formulazione della proposta all’esito dell’istruttoria, ossia quando è più agevole la previsione dell’esito del giudizio, può evitare quello che è stato definito ”il collo di bottiglia del giudizio”, vale a dire il passaggio alla fase decisoria
Né a tale conclusione potrebbe obiettarsi che una proposta conciliativa o transattiva avanzata in quel momento processuale implica necessariamente una anticipazione del giudizio perché, se è indubbio che essa si fondi su una prognosi sull’esito della controversia, ben è possibile che questa sia rivista in sede di decisione atteso che il giudice conserva la facoltà e il dovere di rivalutare il materiale istruttorio e le questioni portate alla sua attenzione fino all’ultimo momento utile.
La nuova disposizione non prescrive che la formulazione della proposta conciliativa si collochi all’interno di un tentativo di conciliazione. Se può pertanto ammettersi che il giudice formalizzi una ipotesi di soluzione amichevole anche al di fuori dell’udienza, ad esempio a scioglimento di una riserva (in questo caso le parti potranno aderire con differenti modalità a quella iniziativa[34]), è indubbio che essa potrà più facilmente realizzarsi se l’iniziativa sarà stata preceduta da un tentativo di conciliazione, in quanto tale incombente consente al giudice di rendersi conto di quali siano le compiute ragioni del conflitto sostanziale tra le parti e quindi di acquisire tramite esso le notizie utili ad elaborare una proposta rispondente ad esse.
Peraltro per seguire tale schema operativo non è necessario che la proposta di definizione amichevole o il tentativo di conciliazione vengano sollecitati dalle parti, atteso che il giudice istruttore, ai sensi dell’art. 185, primo comma, seconda parte, c.p.c. ha facoltà, in ogni stato e grado del processo, di fissare l’udienza di comparizione personale delle parti per procedere al loro libero interrogatorio e in tale frangente può esperire per la prima volta o rinnovare il tentativo di conciliazione già esperito e all’esito di esso formulare la proposta. Ovviamente al fine di rendere proficuo questo percorso sarà opportuno che il giudice sondi presso i difensori delle parti la disponibilità delle stesse ad una soluzione amichevole della lite.
Non si può sottacere peraltro che un serio disincentivo all’utilizzo dell’istituto in esame, quantomeno dopo il momento dell’ammissione delle istanze di prova, può derivare dalla previsione (art. 81 bis, primo comma, c.p.c. sul calendario del processo[35]) che impone al giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, di fissare, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive[36].
E’ estremamente improbabile infatti che il giudice che ha già calendarizzato tutte le udienze in cui si svolgerà l’attività istruttoria delle cause che tratta si determini a formulare proposte di definizione bonaria di una o più di esse, perché in tutti i casi in cui lo dovesse fare dovrebbe riprogrammare le udienze successive a quel momento sia nell’eventualità in cui le parti aderissero alla proposta sia nel caso in cui una o più di esse chiedessero un termine per valutarla.
Allorchè il legislatore si è orientato a favorire il ricorso alla conciliazione giudiziale avrebbe dovuto risolvere l’evidente contrasto che esiste tra una simile finalità e quella, alla quale si ispira la norma in esame, di irrigidire il ruolo di direzione del giudizio che l’art. 175 c.p.c. riconosce al giudice.
In ogni caso, come si è detto, perché la proposta abbia maggiori probabilità di essere presa in considerazione dalle parti deve essere alquanto dettagliata e del resto il parere reso dalla commissione giustizia del Senato sul testo dell’art. 185 bis c.p.c. riconosce espressamente che possa essere espressa in termini molto specifici.
Ciò comporta che il giudice possa esplicitare “i profili di criticità delle reciproche posizioni delle parti…per consentire loro di valutare adeguatamente la proposta stessa e anche di giustificare, con opportuni argomenti l’eventuale rifiuto di essa”[37], sull’indispensabile presupposto di un preventivo, attento esame degli atti di causa e delle prospettazioni delle parti.
5. Il coordinamento tra i diversi sistemi alternativi di risoluzione delle controversie civili previsti nel nostro ordinamento
E’ indubbio che già con la novella 69/2009[38], ma ancor più con la introduzione e la successiva riproposizione della mediazione civile e commerciale, il legislatore abbia inteso dare un forte impulso a tutti i mezzi di soluzione delle controversie alternativi al giudizio, sebbene i diversi interventi normativi che si sono succeduti al fine di realizzare tale obiettivo si siano ispirati a principi a volte tra loro contrastanti[39].
Anche l’art. 185 bis c.p.c. si inserisce a pieno titolo nella predetta categoria di interventi sebbene, come si è visto, la norma sia stata notevolmente depotenziata rispetto alla sua prima versione.
A fronte della pluralità di sistemi conciliativi, che è stata in tal modo offerta ai cittadini, occorre interrogarsi su quale sia il rapporto esistente tra loro.
Se si tiene conto delle peculiarità proprie di ciascuno di essi tale rapporto non può che qualificasi in termini di concorrenzialità, con la conseguenza che è possibile un loro impiego combinato o in sequenza nell’ambito dello stesso contenzioso.
Muovendo da tali premesse è ben possibile che il giudice formuli anche più proposte conciliative nel corso dello stesso giudizio in diversi momenti di esso oppure sulla base di presupposti processuali diversi o anche passare da una proposta conciliativa ad una transattiva e viceversa qualora si renda conto, attraverso la necessaria interlocuzione con le parti o con i loro difensori, che la seconda opzione ha maggiori probabilità di appianare il conflitto giudiziale in atto.
Analogamente l’organo giudicante potrà trarre spunto dal tentativo di definizione che le parti abbiano esperito prima o nel corso del giudizio, o anche dall’esito di un atp, o dalla mancata accettazione della proposta proveniente da una delle parti[40] o dal ctu per individuare i presupposti di una ipotesi di conclusione bonaria da sottoporre a propria volta alle parti.
Il medesimo atteggiamento potrà assumere rispetto ad un procedimento di mediazione, svoltosi in corso di causa o ante causam, senza esito conciliativo.
Anche in una delle predette ipotesi sarà però necessario che il giudice, prima di procedere nei termini predetti, si faccia illustrare dai difensori delle parti costituite in giudizio le ragioni che hanno impedito, nelle precedenti occasioni, la conclusione di un accordo conciliativo[41].
Il giudice potrebbe anche orientarsi a formulare comunque una proposta conciliativa, specie nei processi la cui durata la superato il termine ragionevole di tre anni[42], poiché tale iniziativa se anche non servisse a definire la lite conseguirebbe il risultato di escludere la possibilità per le parti che l’avessero rifiutata di richiedere l’indennizzo per irragionevole durata del processo, stante il disposto dell’art. 55, comma 2 quinquies della legge 24 marzo 2001 n.89 (c.d. legge Pinto)[43].
In una prospettiva opposta potrebbe invece risultare produttivo demandare una mediazione anche dopo il fallimento di un tentativo di conciliazione giudiziale o il rifiuto di una proposta conciliativa del giudice[44], purchè vi siano concreti elementi che facciano ritenere che l’intervento del mediatore possa risultare più efficace di quello del giudice.
Una simile valutazione sarà più attendibile, ad avviso di chi scrive, qualora sia trascorso un certo lasso di tempo rispetto al momento in cui era stata tentata la conciliazione giudiziale. Tale evenienza infatti potrebbe aver indotto le parti a mutare atteggiamento rispetto ad una soluzione conciliativa e tale risultato potrebbe verificarsi ancor più facilmente se nel frattempo gli sviluppi del processo consentissero una prognosi più attendibile sul presumibile esito del giudizio[45].
Per optare per la mediazione delegata, dopo il fallimento di un tentativo di conciliazione giudiziale, il giudice dovrà comunque considerare la disponibilità delle parti ad affidare la individuazione di una soluzione conciliativa ad un soggetto diverso da quello deputato a decidere la controversia[46], sfruttando l’obbligo di riservatezza vigente nella mediazione, e a farsi carico delle relative spese.
Parimenti dovranno essere considerate le ragioni che hanno provocato il fallimento di una delle forme di definizione alternativa già sperimentate e a tal fine sarà indispensabile, ancora una volta, il confronto con i difensori delle parti.
Non può peraltro sottacersi che l’art. 185 bis c.p.c,. riconoscendo al giudice la facoltà di formulare alle parti anche una proposta di tipo transattivo, teoricamente, può interferire con l’ambito di applicazione della mediazione delegata. La norma infatti consente all’organo giudicante di individuare anche delle soluzioni facilitative della controversia, tenendo eventualmente conto a tal fine dell’esistenza di altre controversie tra le stesse parti,[47], sono quelle che possono consigliare l’utile ricorso alla mediazione demandata.
A ben vedere però poichè spesso può essere difficile per il giudice comprendere tutti i profili del contrasto tra le parti, qualora esso non sia limitato all’oggetto del contendere, l’istituto della mediazione delegata conserva tuttora un suo specifico ambito di applicazione con riguardo ai casi sopra detti e ad alcuni altri.
Peraltro, come si è già avuto occasione di evidenziare in altro scritto[48] la pluralità di sistemi conciliativi non costituisce automatica garanzia di un loro successo, singolo o congiunto, giacchè questo dipende soprattutto dalle capacità di chi si trovi a svolgere concretamente le funzioni di mediatore o di conciliatore giudiziale e, in questa prospettiva, occorre constatare come il fondamentale aspetto della formazione alla conciliazione sia stato ancora una volta trascurato dal legislatore.
Il rafforzamento della funzione conciliativa del giudice, per essere completo richiederebbe invece anche un deciso intervento sul piano della formazione, così dei magistrati come anche degli avvocati, che avrebbe costituito anche un significativo progresso in quel percorso di formazione comune di cui si parla da anni e che è ancora ai suoi albori.
[1] La norma è entrata in vigore il 21 giugno 2013, giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.L. 69/2013. Per una primissima applicazione di essa si veda Trib. Milano,, ord. 4 luglio 2013 e Trib. Milano, decr. 26 giugno 2013, entrambe in questa Rivista.
[2] Il riferimento è all’art. 420, comma 1, c.p.c. che, dopo la modifica ad opera dell’art. 31, comma 4, della L. 4 novembre 2010 183, prevede che: “Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula una proposta transattiva”. Si noti che la norma è stata integrata dall’art. 77, comma 1, lett. b) del decreto legge 15 giugno 2013 n. 69 che ha aggiunto l’attributo di conciliativa al termine proposta. In tal modo la disposizione risultava quasi coincidente con il disposto originario dell’art. 185 bis c.p.c.
[3] VACCARI, La proposta conciliativa nella nuova disciplina delle spese di lite, in Economia processuale e comportamento delle parti nel processo civile, Prime applicazioni del Protocollo Valore Prassi sugli artt. 91, 96 e 614 bis c.p.c. a cura di DALLA MASSARA e VACCARI, Napoli, 2012, p. 96 e nota 33. In quel passo si era evidenziato come la diversità di disciplina non fosse giustificata nemmeno dalla differente natura del tentativo di conciliazione, obbligatorio nel processo del lavoro e facoltativo in quello ordinario.
[4] Era dubbio che già per il giudice del lavoro vigesse un simile obbligo, atteso che l’art. 420, primo comma c.p.c., utilizza il tempo indicativo presente per indicare la sua iniziativa di formulazione della proposta (“formula alle parti una proposta transattiva”).
[5] Per l’opinione negativa, derivante dall’idea che la proposta conciliativa implicasse una anticipazione del giudizio: COMOGLIO, La durata ragionevole del processo e le forme alternative di tutela, in Riv. dir. proc. 2007, p.3; CUOMO ULLOA, La conciliazione. Modelli di composizione dei conflitti, Padova, p.306, nt. 416; SCARSELLI, Le modifiche in tema di spese, in Foro it., 2009, V, p.261.
Per la soluzione positiva: PAGNI, La riforma del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. Giur. 2009, p.1320; POTETTI, Novità della L. n.69 del 2009 in tema di spese di causa e responsabilità aggravata, in Giur. di merito, 2010, p.1851; VACCARI, La proposta conciliativa…cit., pp.95-98 e anche il Protocollo sugli artt. 91, 96 e 614 bis dell’osservatorio Valore Prassi del Tribunale di Verona, leggibile in www.valoreprassi.it, pf. I.1.
[6] CONVERSO, L’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, in Giur. It, 2001, p.635 ss. e in giurisprudenza: Cass. n.11677/1995, in Giust. civ. Mass. 2005, 6
[7] Nei termini riportati nel testo si veda: Cass. Civ. sez lav. 4 dicembre 1986 n.7193, in Giust. Civ. Mass, 1986, fasc. 12.
[8] CONVERSO, L’interrogatorio libero…cit., p.635 ss.
[9] Pare muovere dalle premesse teoriche indicate nel testo, pur senza esplicitarle, il decreto del Tribunale Milano 14 novembre 2013, in questa Rivista, che, nel formulare una proposta, qualificata espressamente come conciliativa, e da definirsi invece, più propriamente come transattiva, ha tenuto conto anche dell’oggetto di un’altra controversia tra le parti già pendente e di una prossima, in quanto pur sempre connesse con quello trattate da tale organo.
[10] Ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. 9 agosto 2013 n.98, la legge di conversione è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale cosicchè le modifiche all’art. 185 bis c.p.c. si applicano anche ai processi in corso in virtù del principio tempus regit actum.
[11] Il Vademecum sulla mediazione elaborato dal Tribunale di Milano (pag.23), in www.c.a.milano,it, elenca come controversie non mediabili: quelle in cui prevalgono questioni di principio, quelle in cui una delle parti è sorretta da mala fede, quelle nelle quali si vuole ottenere un precedente, quelle nelle quali le parti non vogliono mantenere rapporti; quanto la storia delle parti è caratterizzata da alcolismo, tossicodipendenza, episodi di violenza, malattia mentale; se le parti non vogliono incontrarsi e cercare una soluzione ma vogliono delegarla ad altri; se le parti chiedono giustizia rivolgendosi direttamente e unicamente al giudice.
[12] In questa prospettiva rispondeva alle esigenze di flessibilità e variabilità evidenziate nel testo la formula dell’art. 16, comma 2, del D. Lgs. 5/2003, abrogato, al pari di quasi tutte le altre norme regolanti il c.d. processo societario, dall’art. 54 della l.69/2009, che disponeva che: “quando nel decreto (di fissazione di udienza) è contenuto l’invito alle parti di comparire di persona, il giudice le interroga liberamente ed esperisce se la natura della causa lo consente (sottolineatura dello scrivente), eventualmente (sottolineatura dello scrivente), proponendo soluzioni di equa composizione della controversia”
[13] Il riferimento è all’art.8 comma 4 bis del D. Lgs. 28/2010, reintrodotto, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2012, n. 272, in www.cortecostituzionale.it, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa di numerose norme del D. Lgs. 28/2010, dall’art. 84, comma 1, lett. i) del D.L. 21 giugno 69, che prevede la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione.
[14] La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2013, in questa Rivista) di recente ha avuto occasione di affermare che: “L'art. 116 c.p.c. conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti (v. Cass., 5/12/2011, n. 26088; Cass., 10/8/2006, n. 18128, e già Cass., 26/2/1983, n. 1503), e il comportamento (extraprocessuale e) processuale - nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal rispettivo procuratore - delle parti può in realtà costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova, idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito, che con riguardo a tale valutazione è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione (v. Cass., 26/6/2007, n. 14748). Si veda anche Cass. Civ., sez. I, 17 luglio 2012 n. 12198, in www.altalex.it, che ha ritenuto il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.
[15] La norma citata nel testo, inserita nel corpo dell’art. 91 c.p.c. dalla L. 18 giugno 2009 n.69, è la seguente: “Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa , condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 92”
[16] Per una proposta di modifica dell’art. 91, primo comma secondo, periodo c.p.c. nei termini riportati nel testo e ripresi dalla prima versione dell’art. 185 bis c.p.c., si veda: VACCARI, La proposta conciliativa nella nuova disciplina delle spese di lite, cit. p.105.
[17] Gli effetti di questa parte della modifica verranno esaminati nel paragrafo successivo.
[18] SCARPA, Il tentativo di conciliazione nella prospettiva del novellato art. 91 c.p.c., in Corr. Merito, 2010, p. 905 ha puntualmente osservato come il giudice istruttore cumuli “una natura promiscua: quella di mediatore dell’accordo conciliativo, contenente la regolamentazione transattiva della lite, e quello di titolare del potere di decisione della controversia, in caso di fallimento della conciliazione”.
[19] Si veda la ordinanza del Tribunale di Verbania del 10 aprile 2004, leggibile per esteso in www.ordineavvocativerbania.it, con la quale, nella vigenza della disciplina introdotta dalla l.263/2005 che aveva previsto l’obbligatorietà dell’esperimento del tentativo di conciliazione alla prima udienza di comparizione, venne rigettata un’istanza di ricusazione che era stata proposta ai sensi dell’art. 51 c.p.c. nei confronti di un giudice istruttore che aveva formulato una proposta conciliativa alle parti.
[20] Il testo dell’articolo menzionato nel testo è stato riportato per esteso alla nota n.12.
[21] Vedi gli autori citati alla nota n.5.
[22] Nel parere della commissione giustizia del Senato si legge che la modifica ha inteso evitare rallentamenti del giudizio conseguenti a possibili istanze di ricusazione e, al contempo, la formulazione di proposte troppo generiche, dal momento che proposte di conciliazione intermini specifici avrebbe potuto apparire come una anticipazione del giudizio.
[23] Secondo parte della dottrina (ACIERNO-GRAZIOSI, La riforma del 2009 nel primo grado di cognizione. Qualche ritocco o un piccolo sisma, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ. 2010, p. 163) la condanna alle spese per mancata accettazione della proposta conciliativa costituisce applicazione del principio di causalità. Per altra parte della dottrina (BRIGUGLIO, Le novità sul processo ordinario di cognizione nell’ultima ennesima riforma in materia di giustizia civile, in www.judicium.it.) invece si tratterebbe di una condanna punitiva
[24] Per una interpretazione, quale quella riferita nel testo, sia pure relativamente della prima versione della norma si veda: Trib. Milano, sez. IX, decr. 26 giugno 2013, in questa Rivista, che ha anche ritenuto che il rifiuto ingiustificato della proposta può costituire comportamento valutabile ai sensi dell’art. 96 terzo comma c.p.c.
[25] L’ipotesi della proposta generica o inidonea a definire il giudizio riguarda soprattutto la proposta proveniente da una delle parti del giudizio e merita condivisione l’opinione di chi (LUISO, Diritto processuale civile, I, Principi generali, Milano, 2012, p.426) reputa che integri il presupposto menzionato nell’art. 91, primo comma secondo periodo c.p.c..
[26] Non possono integrare giustificati motivo di rifiuto della proposta conciliativa la personale convinzione della parte di poter risultare vittoriosa all’esito del giudizio o la indisponibilità in capo ad essa di risorse per adempiere agli obblighi conseguenti alla eventuale conciliazione.
[27] VACCARI, La proposta conciliativa…cit. p. 102 nonché il Protocollo sugli artt. 91, 96 e 614 bis dell’Osservatorio Valore Prassi del Tribunale di Verona, cit., pf. 3.A.
[28] Si noti che, anche qualora la proposta conciliativa venisse formulata prima dell’inizio dell’assunzione delle prove, sarebbe possibile determinare l’ammontare delle spese maturate successivamente a tale momento atteso che, come precisa la relazione governativa al d.m.140/2012 (pag.29), gli importi medi di liquidazione per la fase istruttoria sono stati calcolati tenendo conto di uno sviluppo standard di essa che prevede il deposito delle memorie ai sensi dell’art. 183, comma VI, cp.c. e tre udienze (un’udienza di trattazione e un’assunzione istruttoria per parte.
[29] Non è questa la sede per affrontare la questione, piuttosto complessa, se la proposta conciliativa sia praticabile nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, che pure sono soggette al rito lavoro e quindi almeno sotto il profilo astratto anche al disposto dell’art. 420, primo comma, c.p.c.. Per una risposta affermativa quantomeno nell’ipotesi in cui la proposta si limiti a ridurre il quantum della pretesa sanzionatoria della P.A. si veda: Trib. Verona, ordinanza 24 aprile 2012, in questa rivista.
[30] Un autore (POTETTI, Novità cit. p. 940) ha osservato che la nozione di misura della proposta risulta più facilmente utilizzabile nella cause il cui petitum è costituito da una somma di denaro. Se tale affermazione può condividersi in linea generale non va però trascurato che lo stesso parametro è utilizzabile anche nei casi in cui la domanda abbia ad oggetto più prestazione di facere ed anche che le proposte che non hanno ad oggetto somme di denaro spesso sono traducibili in termini monetari (sul punto sia consentito rinviare a VACCARI, La proposta conciliativa…,cit., p. 103). e inedita Per un esempio di proposta conciliativa del giudice avente ad oggetto esecuzioni di prestazioni di fare si veda l’ordinanza del Trib. di Bari articolazione di Modugno del 31 ottobre 2013, resa nel procedimento n.158/2012 e inedita, con la quale il convenuto è stato invitato ad eseguire determinati lavori meglio individuati in alcune bozze conciliative predisposte dalle parti.
[31] Trib. Milano, dec. 23 giugno 2013, cit., sul presupposto che l’istituto abbia portata generale, lo ha ritenuto applicabile nella fase presidenziale di un giudizio di separazione, anche con riguardo a misure riguardanti l’affidamento dei figlio o l’assegnazione della casa familiare.
[32] L’alternativa posta dalla norma si giustifica con il fatto che nelle cause definibili senza necessità di istruttoria o quelle in cui si tratti di valutare una istanza di provvedimenti interinali può essere opportuno avanzare la proposta già in prima udienza.
33 GRAZIOSI, La nuova figura del giudice tra riforme processuali, moduli organizzativi e protocolli di udienza, in www.judicium.it, che, a tale proposito, parla di conciliazione sostitutiva della decisione giudiziale; NARDELLI, Composizione del giudice, Comunicazioni e notificazioni. Spese e responsabilità aggravata, Eccezione di estinzione, ne La ragionevole durata del processo competitivo, a cura di DIDONE, Torino 2012, p.43.
[34] Le parti potranno infatti accettare formalmente la proposta, a mezzo dei rispettivi difensori, purchè essi siano muniti di procura speciale, o comparendo di persona davanti al giudice per concludere una conciliazione giudiziale o per rinunciare agli atti del giudizio o lasciando estinguere il giudizio.
[35] La norma è stata inserita dall’art. 52, comma 2, L.18 giugno 2009 n.69 e ad essa è stato aggiunto un secondo comma nel quale si afferma la “possibile” rilevanza disciplinare del mancato rispetto del calendario del processo dall’art. 1 ter, comma 1, lett. a) D.L. 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011 n.148.
[36] Con ordinanza 18 luglio 2013 n.216, leggibile in www.cortecostituzionale.it, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma citata nel testo che erano state sollevate in relazione agli art. 3 e 111 Cost. affermando il carattere obbligatorio dell’incombente in essa previsto per le cause in cui il Giudice ammetta attività istruttoria.
[37] Così VACCARI, La proposta conciliativa…cit., p.98.
[38] Si pensi, oltre che alla modifica, già esaminata dell’art. 91, comma 1 secondo periodo c.pc., alla introduzione dell’istituto della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite (art. 696 bis c.pc.).
[39] BOVE;, La conciliazione nel sistema dei mezzi di risoluzione delle controversie civili, in www.judicium.it e VACCARI, Media-conciliazione e funzione conciliativa del giudice, in www.judicium.it.
[40] Nella ordinanza del Trib. di Bari articolazione di Modugno, del 19 dicembre 2013, resa nel giudizio n.158/2012, inedita, si valorizza propria la disponibilità conciliativa palesata dalle parti nel corso del giudizio attraverso lo scambio di proposte conciliative “secondo lo scadenziario concordato nel rispetto delle linee guida della prassi conciliativa formatasi presso quell’ufficio, quale occasione per il giudice ad avanzarne una propria.
[41] La indicazione contenuta nel testo deriva dalla considerazione che il giudice non dispone di elementi per comprendere i motivi che possono aver indirizzato le parti nella fase di mediazione stante il divieto di utilizzare le dichiarazioni che esse abbiano reso o le informazioni che siano state acquisite di cui all’art. 10 del D. Lsg. 28/2010.
[42] Il termine è stato fissato in tale misura, per il giudizio di primo grado, dall’art. 55, comma 2 bis, del d.l. 22 giugno 2012 n.83 (c.d. decreto sviluppo), convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.83.
[43] La norma citata nel testo è stata inserita dal d.l. 22 giugno 2012 n.83 (c.d. decreto sviluppo), convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.83 e prevede che: “Non e’ riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte soccombente condannata a norma dell’articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all’articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;
e) quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’articolo 2-bis.
f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.
[44] Deve escludersi che il fallimento della conciliazione giudiziale esoneri il giudice dall’inviare le parti in mediazione nelle controversie in cui essa costituisce condizione di procedibilità. Parimenti lo svolgimento di un atp prima dell’inizio di una di quelle controversie non realizza la condizione di procedibilità, come può desumersi dal disposto dell’art. 4, lett. c) del D. Lgs. 28/2010 che stabilisce che il procedimento di atp non deve essere preceduto dalla mediazione. Da ciò si ricava che il giudizio conseguente all’atp deve invece preceduto da tale fase.
[45] Il solo rifiuto della proposta conciliativa non pare, da solo, elemento sufficiente a giustificare la mediazione delegata ed anzi può essere indicativo della indisponibilità di almeno una delle parti al raggiungimento di una soluzione conciliativa, integrando quindi la specifica ragione ostativa all’utilizzo di un simile istituto che è prevista dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 28/2010. Hanno invece ritenuto il contrario, sia pure implicitamente, alcuni provvedimenti di merito: Trib. Milano, sezione specializzata delle imprese, ordinanza del 13 novembre 2013, in questa rivista; Trib. Roma, sez. XIII, ord. 30 settembre 2013, in www.mondoadr.it Quest’ultimo provvedimento merita di essere segnalato anche per un’altra ragione, vale a dire per aver ritenuto possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato. Sulla base di tale presupposto il giudice ha assegnato alle parti un termine per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta e un termine di quindici successivo alla scadenza del primo per depositare presso un organismo di mediazione, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decreto
[46] Sul punto chi scrive ha già avuto occasione di evidenziare (VACCARI; Media-conciliazione… cit., p.13) come la caratteristica della riservatezza, tipica della mediazione, non costituisca di per sé un elemento favorente la conciliazione poiché spesso le parti preferiscono affidare anche l’individuazione della soluzione transattiva della controversia a colui che è deputato a deciderla. La considerazione trova un riscontro in quella dottrina (GARRI, L’udienza di discussione: il ruolo del giudice “conciliatore” e il novum della proposta transattiva, in Quest. Giust., 2010, pp. 149-151) che ha individuato la causa del fallimento della fase conciliativa pregiudiziale del giudizio del lavoro nella preferenza che le parti, nell’esperienza pratica, hanno accordato alle capacità di conciliazione del giudice.
[47] Si peni all’ipotesi in cui il giudice si trovi a gestire un ruolo con un numero di cause elevato, così da essere impossibilitato a dedicare allo svolgimento dei tentativi di conciliazione il tempo che essi richiedono o ancora, come si è osservato in altra occasione (VACCARI, Media-conciliazione…cit., p. 14), a quella di cause caratterizzate da cumulo oggettivo o soggettivo di domande per una sola delle quali la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità
[48] VACCARI, Media-conciliazione… cit. pp.15-16.
Scarica Articolo PDF