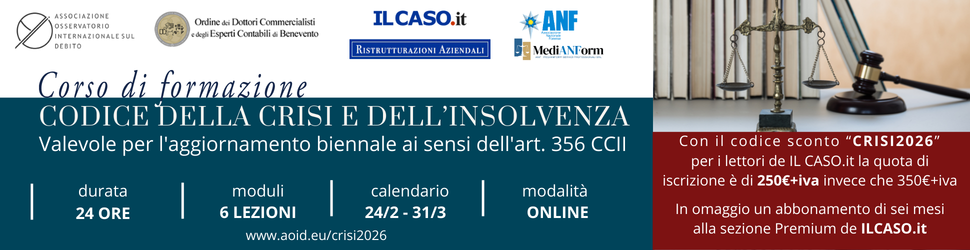CrisiImpresa
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 02/04/2025 Scarica PDF
Gli esiti della composizione negoziata e il compenso dell'esperto
Tommaso Nigro, Dottore commercialista in Salerno, Revisore legale, Giornalista Pubblicista e membro del Comitato scientifico AIECCQuesto contributo è stato realizzato all’interno del comitato scientifico di AIECC - Associazione Italiana Esperti della Composizione della Crisi ed è destinato alla raccolta degli atti del Convegno “Company Recovery Strategies nel Codice della Crisi e nella CNC: il correttivo 136/24, le prassi applicative ed il diritto concorsuale europeo”.
Sommario: 1. Premessa. 2. Gli esiti della composizione negoziata ed i riflessi sulle nomine. 3. Gli esiti della composizione negoziata e la determinazione del compenso
1. Premessa
La questione degli esiti della composizione negoziata è centrale rispetto alla trattazione dello strumento ed è in grado di orientare le successive scelte in ordine all’individuazione della figura dell’esperto più confacente ed alla determinazione del compenso ad esso spettante. In un contesto in cui si può immaginare un unico filo conduttore, nasce l’esigenza di esaminare i tre differenti temi, strettamente interrelati, con un focus che parte, appunto, dalla corretta interpretazione degli esiti della composizione negoziata.
In un precedente contributo[1], cui si rimanda per una completa trattazione, partendo dalla nuova struttura del riformato art. 23 CCII (che sancisce ora esplicitamente il principio dell’alternatività nella scelta del percorso da intraprendere), è stata data enfasi al tenore della Relazione illustrativa al decreto Correttivo ter, la quale ricorda che la composizione negoziata “non deve essere vista come uno strumento che ha esito positivo solo se ed in quanto porta ad una delle soluzioni di risanamento di cui al comma 1 o al comma 2, lettera b)” posto che “anche gli eventuali sbocchi giurisdizionali, infatti, vanno considerati come risultati positivi della composizione che, rispetto ad essi, è chiamata a svolgere un ruolo preparatorio tale da garantire ristrutturazioni più rapide ed efficienti”.
Il che ha indotto ad alcune riflessioni, calibrate anche sull’antitetico rimando che il medesimo art. 23 CCII fa all’art. 12 co.1 CCII, che inducono a “sfumare i contorni, abbandonando l’idea di una netta perimetrazione tra esiti positivi e negativi della composizione negoziata ed introducendo un concetto “stratificato” e “modulare” di “esito positivo” che può assumere diverse gradazioni a seconda del punto di osservazione e della finalità che si intende raggiungere ed indagare”.
2. Gli esiti della composizione negoziata ed i riflessi sulle nomine
L’interpretazione corretta degli esiti della composizione negoziata impatta, dunque, in primo luogo sulla posizione dell’esperto, nella misura in cui essi potrebbero astrattamente contribuire ad orientare le scelte da parte della Commissione designatrice. Il Decreto Correttivo 136/2024 ha, infatti, innestato una serie di modifiche all’art. 13 CCII dando rilevanza primaria ai risultati della composizione negoziata, prevedendo, in primo luogo, che la domanda di iscrizione all’elenco vada corredata, tra gli altri, da un curriculum vitae che va, di volta in volta, aggiornato “con la sintetica indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito”; e poi prevedendo l’istituzione di una “scheda sintetica contenente le informazioni utili alla individuazione del profilo dell’esperto, anche con riferimento agli esiti delle composizioni negoziate seguite” per l’inserimento nell’elenco previsto dal comma 3.
Detto corredo documentale è finalizzato a consentire alla Commissione deputata alla scelta del professionista di nominare in maniera più confacente l’esperto, tenendo conto, sempre nei limiti dei principi di rotazione e trasparenza, “della complessiva esperienza formativa risultante dalla scheda sintetica, anche esaminando, ove occorra, il curriculum vitae, e dell’attività prestata come esperto nell’ambito di precedenti composizioni negoziate e del loro esito”.
Nessun dubbio, allora, sulla valenza del requisito esperienziale fondato sulle composizioni che il professionista abbia avuto l’opportunità di condurre. In detto contesto la disposizione sembrerebbe, prima facie, premiare gli esiti positivi, con il pericolo di condizionamenti in ordine al profilo di terzietà rispetto al risultato finale da raggiungere, dovendo immaginare un interesse dell’esperto ad una conclusione favorevole del percorso. A sconfessare tale interpretazione è, però, il chiaro tenore della Relazione illustrativa, la quale ha cura di precisare che tutti gli epiloghi delle composizioni negoziate seguite debbano essere presi in considerazione e, dunque, “non solo gli esiti positivi, su cui l’esperto abbia influito con la propria capacità nella facilitazione delle trattative, ma anche quelli negativi, ben potendo essere valutato positivamente l’esperto che ha saputo cogliere con prontezza l’inutilità di una prosecuzione dei negoziati”.
Se questo è l’intento, qualche profilo di incertezza può prospettarsi in ordine alla “lettura” del dato da parte della Commissione, stante la necessaria sinteticità del dato offerto, ed alla conseguente difficoltà di interpretare, nei casi di “esiti negativi”, un’informazione autocertificata, non potendo escludersi che la composizione si sia chiusa negativamente per imperizia dell’esperto. In tal senso sarebbe stato forse auspicabile prevedere l’obbligatoria menzione di eventuali ipotesi di segnalazione dell’imprenditore (o di due parti) rese ai sensi dell’art.17 co. 6 CCII.
3. Gli esiti della composizione negoziata e la determinazione del compenso
La modifica dell’art. 25 ter CCII interviene, tra gli altri, sul comma 6, dedicato alla maggiorazione del compenso in particolari ipotesi in cui anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all’articolo 17, comma 8 si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b).
Qui le Commissioni Giustizia di Camera e Senato avevano richiesto, nell'ottica di riduzione dei costi, “di eliminare la possibilità di duplicazione del compenso dell'esperto”, incontrando il disfavore del Legislatore che, tuttavia, ha, a fini compensativi, valutato opportuno inserire un elemento correttivo, collegando il raddoppio del compenso all’”opera effettivamente svolta dall’esperto”, così “evitando un automatico aumento del costo relativo al suo compenso non collegato a risultati a lui riconducibili”.
La disposizione tuttavia non convince, essendo difficile escludere motivatamente che un esito favorevole, quand’anche realizzatosi dopo la chiusura della composizione, non sia frutto anche dell’attività dell’esperto. Come può dirsi che l’opera prestata non sia servita e qual è il discrimine per considerare detta opera non rilevante? Se a seguito delle trattative condotte sotto l’egida dell’Esperto si conclude un contratto o un accordo, ancor più nei casi di efficacia estesa, è assai difficile ritenere che il risultato raggiunto non sia “riconducibile” all’attività prestata dall’esperto. Non può esserci composizione negoziata senza esperto[2] e pensare diversamente significherebbe non riconoscere il primario ruolo delle trattative, minando l’essenza stessa dello strumento. Del resto, anche la stessa motivazione posta a base del mancato recepimento delle osservazioni attesta inequivocabilmente che la finalità del processo “è quella di incentivare l’esperto a facilitare le trattative verso una soluzione di tipo negoziale o verso gli accordi di ristrutturazione (e quindi di incentivare tali esiti della composizione negoziata)”, così riconoscendo l’essenzialità dell’opera.
Altro rilevante intervento si registra al comma 8 il quale, nella nuova formulazione, prevede che “quando l’imprenditore non compare davanti all’esperto oppure l’esperto non procede ai sensi dell’articolo 17, comma 5, terzo periodo, il compenso è liquidato in misura compresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00, tenuto conto delle dimensioni dell’impresa e della complessità della documentazione esaminata”.
In tal modo viene riconosciuto, nelle ipotesi di chiusura anticipata della composizione negoziata, che l’onorario dell’esperto, quand’anche ridotto, va comunque adeguato al reale impegno profuso, abbandonando l’illogico criterio della determinazione in misura fissa. Così facendo viene incentivato il lavoro del professionista, scongiurando gli effetti distorsivi causati dalla esiguità del precedente compenso, particolarmente penalizzante nelle ipotesi di verifiche complesse operate dall’esperto ai fini del riscontro sulla effettiva perseguibilità del risanamento. E viene così anche paralizzata la diffusa prassi di riconvocare l’imprenditore ed i creditori anche in mancanza delle necessarie condizioni, al solo fine di dare dimostrazione di un’attività compiuta e di “transitare” nel perimetro del compenso a scaglioni.
Meritevole è, dunque, l’intervento seppur restano ancora alcune zone d’ombra conseguenti ad una non facile perimetrazione del lavoro dell’esperto.
Il confine tra l’archiviazione per la mancanza di concrete prospettive di risanamento e l’avvio delle trattative (che poi costituisce il discrimine tra compenso fisso e variabile), non è poi così marcato, potendo immaginare, in presenza di una astratta possibilità di risanamento, che l’esperto convochi i creditori anche al solo fine di poter acquisire il dinego alla prosecuzione delle trattative. In tal senso è allora determinante comprendere se il piano sia quantomeno strutturato e potenzialmente perseguibile e, dunque, prospettabile ai creditori. Se ciò accade deve ritenersi che il percorso sia avviato con la conseguente attivazione del meccanismo del compenso a scaglioni (anche se poi le trattative non abbiano concreta prosecuzione).
Vi è poi un altro aspetto da esaminare che attiene al profilo dell’impossibilità di condivisione del compenso con l’imprenditore. La forbice, molto ampia, del criterio di applicazione (tra euro 500,00 ed euro 5.000,00) ed il richiamo ad un compenso “liquidato” induce a ritenere che il principio della preventiva pattuizione sia, di fatto, derogato, spettando, invece, alla Commissione il compito di determinare l’effettivo importo da corrispondere che tenga conto delle dimensioni dell’impresa e della complessità della documentazione esaminata.
Il conclusivo innesto coinvolge, infine, l’ultimo capoverso del comma 11 il quale prescrive ora che “L’accordo è nullo se interviene prima di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione di cui all’articolo 17, comma 5, salvo che le trattative si concludano prima”.
Trattasi, evidentemente, dell’ipotesi in cui le trattative si siano effettivamente aperte e risponde alla sentita necessità di evitare costi eccessivi per l’impresa e, soprattutto, quantificazioni del compenso non in linea con i criteri dettati dal comma 1 dell’art. 25 ter CCII.
Qui va ricordato che il compenso da riconoscere subisce delle oscillazioni all’interno degli scaglioni che vengono fatte dipendere dall’opera prestata, dalla complessità della trattativa e dal modo in cui la negoziazione è stata seguita. Il che spiega, almeno nelle intenzioni del Legislatore, come questo accordo non possa essere consacrato prima che sia possibile apprezzare la reale portata dell’impegno richiesto all’esperto e, quindi, in un tempo che viene reputato congruo in 120 giorni dal primo incontro con l’imprenditore.
Anche in tal caso si profilano criticità conseguenti ad un innesto postumo rispetto all’articolato impianto iniziale.
A tacer del fatto che, contrariamente ai principi che regolano i rapporti tra cliente e professionista, il compenso va determinato dopo lo svolgimento dell’incarico, occorre anche operare un coordinamento tra il nuovo testo ed il non toccato comma 13 il quale continua a prevedere che “Dopo almeno sessanta giorni dall’accettazione dell’incarico, su richiesta dell’esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata”.
L’impossibilità di poter pattuire il compenso prima dei 120 giorni - sul presupposto di non poter apprezzare la reale portata dell’impegno richiesto all’esperto - porta con sé la conseguenza di non poter concordare, ma neppure stimare, l’acconto, tra l’altro nel più ristretto termine di 60 giorni, con l’unica derivata possibile di considerare non operante il riferimento ai “risultati ottenuti” e alla “attività prestata”, e di poter ancorare la richiesta di acconto al solo compenso minimo previsto.
* Questo contributo è stato realizzato all’interno del comitato scientifico di AIECC - Associazione Italiana Esperti della Composizione della Crisi ed è destinato alla raccolta degli atti del Convegno “Company Recovery Strategies nel Codice della Crisi e nella CNC: il correttivo 136/24, le prassi applicative ed il diritto concorsuale europeo”.
Tommaso Nigro è Dottore commercialista in Salerno, Revisore legale, Giornalista Pubblicista e membro del Comitato scientifico AIECC.
[1] T.Nigro, “Art 23 CCII: oggi la conclusione delle trattative può avvenire in alternativa con gli strumenti dell’art 23 secondo comma CCII” in www.ilcaso.it
[2] M.Fabiani, “Ruolo, funzioni e responsabilità dell'Esperto nella Composizione negoziata”, in Diritto della crisi.
Scarica Articolo PDF