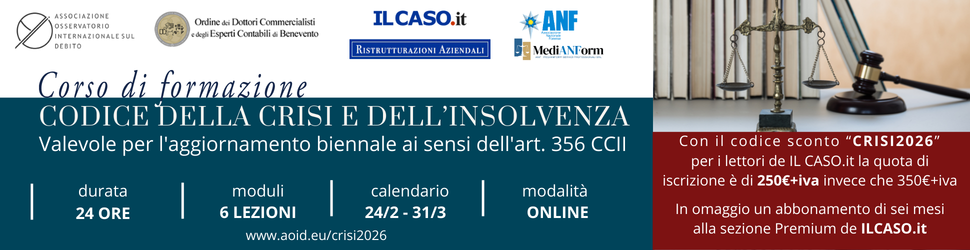EsecuzioneForzata
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 18/02/2015 Scarica PDF
La verifica dell'idoneità del titolo esecutivo alle luce di recenti orientamenti giurisprudenziali
Gianluca Cascella, Avvocato in Torre AnnunziataOsservazioni a margine di Trib. Torre Annunziata, 3 maggio 2013
1. Titolo esecutivo e suoi requisiti. - 2. Idoneità del titolo e verifica del giudice dell'esecuzione. - 3. Il caso concreto. - 4. Il contratto di mutuo condizionato. - 5. Il fulmine a ciel sereno di Cass. civ., Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11067. - 6.- Osservazioni conclusive.
1. Titolo esecutivo e suoi requisiti
La disciplina del titolo esecutivo e dei suoi requisiti è dettata dall'art. 474 c.p.c. che, al primo comma, formula la premessa secondo cui l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile; al secondo comma individua due categorie di titoli esecutivi, rispettivamente quelli giudiziali e quelli stragiudiziali, di seguito brevemente descritti.
Nella prima di tali categorie rientrano le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.
Nella seconda, innanzitutto le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia (ed è il caso degli assegni); infine, sempre da considerarsi titoli stragiudiziali sono gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli; al riguardo, la riforma delle procedure esecutive, attuata con la L. 28.12.2005, n. 263 e con la successiva L. 24.02.2006, n. 52, ha aggiunto tali scritture al catalogo dei titoli esecutivi, finendo quindi, sostanzialmente, per riconoscere alla stesse efficacia equivalente alle cambiali[1]nonchè virando, altresì, in direzione decisamente opposta all'orientamento della S.C. che, sino a qualche mese prima, espressamente aveva negato efficacia di titolo esecutivo alle scritture private autenticate, sul rilievo per cui il riconoscimento della qualità di titolo esecutivo all’atto ricevuto da un pubblico ufficiale (notaio in quel caso) relativamente all’obbligazione di somma di denaro generata dal negozio che nel predetto atto risulta documentato, innanzitutto presuppone che esso contenga l’indicazione degli elementi strutturali essenziali dell’obbligazione, indispensabili per la funzione esecutiva[2]; efficacia che, invero, dipende non dalla particolare efficacia probatoria dell’atto, costituendo invece conseguenza della pubblica fede che il notaio vi attribuisce, il che comporta che la predetta qualità non può essere riconosciuta alla scrittura privata autenticata, nonostante l’efficacia probatoria di cui essa è dotata, in ragione dell’autenticazione da parte del notaio.[3]
Quella innanzi evidenziata costituisce, indubbiamente, una scelta legislativa che, oltre a cancellare il citato orientamento di legittimità, si mostra anche totalmente divergente dalle scelte ravvisabili, sul punto, in ambito europeo, dal momento che, prima la giurisprudenza e poi, successivamente, anche la normativa comunitaria, hanno escluso che la scrittura privata possa valere quale titolo esecutivo[4].
Al terzo comma la norma stabilisce innanzitutto che all'esecuzione forzata per consegna o rilascio può procedersi solo in forza dei titoli esecutivi di cui ai nn. 1) e 3) del secondo comma ed, inoltre, che nel caso in cui si agisca in forza delle scritture private autenticate di cui al n. 2) del secondo comma, il precetto deve contenere una trascrizione integrale di esse, ai sensi dell'art. 480, secondo comma c.p.c.
Allora, se dalla riforma del 2006 appare emergere l'intenzione del legislatore di allargare il perimetro della nozione di titolo esecutivo, va detto che la giurisprudenza di legittimità, inserendosi in tale scia, ha di recente apportato un contributo nella predetta direzione, affermando che il decreto emesso all’esito del procedimento di modifica delle condizioni di separazione è immediatamente esecutivo, in quanto ad esso non si applica il differimento dell’efficacia esecutiva previsto in via generale dall’art. 741 c.p.c. per gli altri provvedimenti camerali[5], mutando il proprio (di poco) precedente orientamento, che invece propendeva per l'esclusione di tale immediata esecutività[6]; il fondamento di tale revirément è stato dalla Corte individuato nel principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, desumibile dall’art. 24 Cost. in riferimento alla garanzia del diritto di azione, in ossequio al quale, nella concreta e specifica fattispecie, ne discende che, alla valutazione del legislatore circa la necessità di una tutela sommaria anticipatoria esecutiva rispetto alla definizione del giudizio, deve necessariamente corrispondere una valutazione di identica immediatezza di tutela esecutiva sulla base del provvedimento definitivo, che risulta incompatibile con la diversa regola dell’art. 741 c.p.c.[7].
Per concludere il discorso sui titoli esecutivi, va fatto un breve accenno al c.d. titolo esecutivo europeo, come disciplinato dal Reg. n. 1215/2012, appena entrato in vigore[8], che ha costituito una rilevante innovazione, permettendo la circolazione nello spazio giudiziario dell’Unione Europea non solo all’efficacia di accertamento dei provvedimenti giudiziari, ma anche alla loro efficacia esecutiva; si è avuto, in tal modo, come si rileva in dottrina, il superamento della tecnica c.d. dell’exequatur, per effetto della quale si crea un rapporto bilaterale tra lo Stato di origine del titolo esecutivo e quello in cui viene richiesta l’esecuzione del comando, in cui il titolo deve essere omologato, rendendo invece possibile instaurare un processo di esecuzioneall’interno di un qualsiasi Stato membro diverso da quello di origine del provvedimento (ovvero della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico) mediante la sola produzione di una copia della decisione e di una attestazione rilasciata dal giudice dello Stato di origine, a semplice richiesta dell’interessato[9].
Ritornando ai caratteri del titolo esecutivo esso, come sostiene la dottrina, è, al tempo stesso, atto di accertamento di un diritto e/o di applicazione di una sanzione, nonché documento che tale diritto comprova[10]; si tratta, quindi, di un atto di accertamento contenuto in un documento che rappresenta per Legge tale atto e che, per il fenomeno della c.d. astrazione, rappresenta il diritto alla prestazione, senza che l’esecuzione possa essere paralizzata dall’inesistenza effettiva di tale diritto[11], poiché nulla executio sine titulo.
Il titolo esecutivo, secondo la dottrina, svolge la funzione di individuare (e documentare) il diritto del quale al giudice dell'esecuzione verrà chiesta l'attuazione, in quanto a tale ultimo giudice non si chiede altro che di dare a tale diritto una concreta attuazione attraverso le forme e le modalità del processo di esecuzione, mentre per converso non gli si richiede affatto di esaminare ed approfondire, in punto di diritto, il contenuto del titolo medesimo, poiché tanto non rientra tra i suoi compiti precipui[12], anche se un recente orientamento di legittimità, che appresso si proverà ad analizzare, ha messo in discussione tale approdo sistematico-ricostruttivo, che pareva – giustificatamente invero – ben consolidato. Occorre poi tenere presente che, in sostanza, il titolo non si identifica con il documento che lo rappresenta, se non dal punto di vista meramente formale, in quanto da tale ultimo punto di vista è tramite il documento che l'ufficio del giudice dell'esecuzione presta la propria opera per realizzare in concreto l'accertamento ed il comando che il titolo documenta[13].
Alla luce di tale principio – che tuttavia, per recente giurisprudenza di legittimità, non deve essere interpretato in modo troppo rigido - secondo autorevole opinione, l’assenza di un titolo esecutivo non solo impedisce che sia posta in essere una esecuzione (ordinaria) ma, altresì, preclude la possibilità del compimento di atti di esecuzione che vadano oltre ciò che il titolo esecutivo consente nella sua portata obiettiva[14]; il titolo, in pratica, è tutto ciò che serve per avviare la tutela in forma esecutiva del diritto che in esso risulta accertato, essendo in possesso di una sorta di autosufficienza, come afferma la dottrina[15].. Del resto, parimenti incontestato, secondo la dottrina prevalente, appare il fatto che il titolo – con particolare riguardo a quello formatosi nel processo di cognizione – nel processo di esecuzione assume rilevanza non come prodotto o, peggio ancora, quale prosecuzione del giudizio in cui esso trova origine, bensì in termini di dato autonomo ed indipendente rispetto a quel processo (anche) di formazione[16], e anche tale dato, tuttavia, oggi risulta messo in discussione dal richiamato orientamento della S.C.[17] Per converso, allo stesso modo non pare revocabile in dubbio che, come afferma un autore già richiamato, nonostante tale pacifica idoneità del titolo, non può certo escludersi – con specifico riferimento ai titoli di formazione giudiziale, come la sentenza – che possa verificarsi un eventuale difetto di coincidenza tra la sentenza quale provvedimento decisorio e la sentenza quale titolo esecutivo, dato che un provvedimento, se valido sotto il primo profilo, perché congruamente motivato, può non esserlo sotto il secondo, e quindi non costituire un valido titolo esecutivo, perché carente dei requisiti richiesti dall’art. 474 c.p.c.[18].
Allora, in concreto il titolo esecutivo può essere definito e ricostruito in termini di concreta fattispecie a cui l'ordinamento giuridico attribuisce l'idoneità a produrre un determinato effetto, che è quello di assicurare la possibilità di tutelare, attraverso il processo di esecuzione, una posizione giuridica sostanziale di diritto (di credito ovvero altra natura) che un soggetto vanti nei confronti di un altro soggetto, attraverso il ricorso all'attività prestata dall'ufficio del giudice dell'esecuzione[19]; tale effetto, come sostiene altra dottrina, rappresenta la conseguenza di una scelta del legislatore che, con il riconoscimento dell'esecutività al titolo, inteso come risultato finale dell'attività di accertamento di un determinato diritto, svolta nel processo di cognizione ovvero in via stragiudiziale, lo prevede quale strumento volto a permettere la concreta attuazione e realizzazione di un determinato diritto sostanziale,[20] che ha ritenuto meritevole di essere tutelato ed attuato attraverso il titolo stesso[21].
Invero, come si afferma da alcuni, requisiti quali astrattezza dell'azione esecutiva, e certezza/liquidità/esigibilità del credito portato dal titolo esecutivo, non sono affatto mere formule di stile, bensì la manifestazione di quella che costituisce la ratio posta alla base del sistema delle esecuzione civile, dato che ogni volta che nel titolo (esemplare in tal senso è l’ipotesi delle condanne pecuniarie) appare labile e sbiadita la individuazione del diritto e della sua estensione, il requisito dell’astrattezza risulterà di pari passo affievolito, rendendo molto meno giustificato e giustificabile l'attacco al patrimonio del debitore ove manchi, al riguardo, il contraddittorio con quest'ultimo dinanzi al giudice[22]. Ancora, e tanto rileva da altro e non meno importante punto di vista, ulteriore effetto che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la fattispecie del titolo esecutivo, come individuata dallo studioso innanzi citato, è quello di precludere la possibilità, nel processo di esecuzione, di (ri)mettere ogni volta in discussione l'accertamento che il titolo predetto contiene[23] e cioè, sostanzialmente, quello relativo all'esistenza del diritto che si pone a base dell'azione esecutiva, avendo riservato ad altre sedi la possibilità – anzi, la necessità indefettibile – di formulare eventuali contestazioni riguardo l'esistenza o meno del diritto in questione. Tanto appare invero indiscutibile atteso che, come afferma la S.C., in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, anche se si pone come «giudicato esterno» (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo) non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo[24] e pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell’esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa[25]; da ciò discende, allora, che non è verosimilmente ipotizzabile che si possa rimettersi in discussione l'accertamento in cui esso consiste, in quanto si risolve in un apprezzamento su di un determinato fatto, anche se qualche dubbio al riguardo inizia a sorgere, per quanto dedotto in precedenza.
Non va però trascurato di dare conto del fatto che altra parte della dottrina, tuttavia, dubita che il titolo esecutivo rappresenti tutto ciò che occorre per procedere ad esecuzione forzata, in quanto se il titolo è indispensabile, al tempo stesso occorre, in favore del creditore, anche la sussistenza del relativo diritto, che va riconosciuto anche grazie allo svolgersi dell’azione esecutiva, nonché della fase di cognizione delle eventuali opposizioni all’esecuzione, a maggiore ragione in quanto, se un titolo non sussiste, per il creditore risulterà indispensabile superare anche l’eventuale disconoscimento del credito da parte del debitore, come dispone l’art. 499 c.p.c. riformato dalla legge n. 80/2005[26].
In conclusione, può rilevarsi come tale incertezza ed oscillazione giurisprudenziale conduce a far ritenere indubbiamente condivisibile quanto afferma chi sostiene che, proprio i requisiti della certezza e della liquidità del diritto consacrato nel titolo esecutivo, nonostante dovrebbero rappresentare un punto di partenza sicuro da cui prendere le mosse per affrontare la problematica dell’interpretazione del titolo, sono tutt’altro che pacifici, sia per la dottrina sia per la giurisprudenza[27], il che finisce sostanzialmente per mettere in discussione la saldezza di quello che rappresenta il presupposto per l'esercizio della tutela in executivis, cioè un valido titolo esecutivo; va detto, infine, che la nozione di titolo esecutivo cui sopra si è fatto riferimento attiene al profilo sostanziale del medesimo, mentre considerando lo stesso da un aspetto diverso ed ulteriore, quello cioè del titolo esecutivo in senso documentale, nozione che si ricava dall’art. 475 c.c., con essa la dottrina indica quel documento che ha la funzione di rappresentare un aspetto della più ampia fattispecie costituita dal diritto ad agire in executivis, rappresentato dalla nozione di titolo esecutivo nel senso sostanziale[28], di cui si è detto.
2. Idoneità del titolo e verifica del giudice dell’esecuzione
Il titolo esecutivo, come ci ricorda la giurisprudenza, è il necessario presupposto per conseguire dal debitore l'esatto adempimento dell'obbligazione ed il relativo diritto dev'essere, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., certo (cioè incontroverso nella sua esistenza), liquido (ossia di ammontare determinato) ed esigibile (in quanto non sussistano ostacoli, come la condizione o il termine, alla sua riscossione), per cui solo il concorso di tali requisiti rende il credito suscettibile di esecuzione forzata[29].
Orbene, anche se la cosa dovuta - che si tratti di una somma di denaro o di un bene di natura fungibile non rileva - non va obbligatoriamente indicata nella sua precisa entità quantitativa, che può ricavarsi anche attraverso un calcolo matematico, è invece irrinunciabile che il titolo in base al quale si procede contenga in sé tutti gli elementi certi e positivi idonei alla determinazione del quantum[30].
Fatta tale doverosa premessa, deve rilevarsi come il potere-dovere del giudice di controllare, anche d’ufficio, le condizioni per il valido svolgimento dell’azione esecutiva è stato oggetto di un contrasto giurisprudenziale che ha visto il susseguirsi di decisioni di tenore divergente: dall'esame dei repertori di giurisprudenza, infatti, emergono prima decisioni favorevoli[31], poi contrarie[32] ed, ancora successivamente, di nuovo positivamente orientate a riconoscere tale potere di controllo officioso al giudice, con l’affermare che il giudice dell’opposizione all’esecuzione è tenuto a compiere d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’azione esecutiva, potendo rilevare sia l’inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, vicende che determinano – entrambe - l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l’esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa[33]; inoltre, l’importanza di tale compito viene sottolineata dalla dottrina sul rilievo come essa è comprovata dal fatto che il potere/dovere in questione compete non solo al giudice dell’esecuzione, ma anche a quello dell’opposizione all’esecuzione.
Si afferma, infatti, che, come il giudice dell'esecuzione ha il compito di controllare l'esistenza del titolo esecutivo, incidentalmente nel momento in cui compie l’atto esecutivo, poiché egli ha l’obbligo di delibare l’esistenza ed idoneità del titolo[34], parimenti va riconosciuto al giudice dell'opposizione analogo ruolo di verifica[35], e tanto perché, come da altri affermato, se non si riconoscesse tale potere al giudice dell’opposizione all’esecuzione, dovrebbe ammettersi un condizionamento del secondo processo, nei confronti del primo, invero assai difficile da giustificare, in quanto il giudizio di opposizione avrebbe un esito diverso a seconda che il giudice dell’esecuzione abbia o meno fatto uso del suo potere officioso, dal momento che in sede di opposizione all’esecuzione, se il relativo giudice non potesse procedere d’ufficio a verificare la sussistenza o meno del titolo, allora l’eventuale venire meno di quest’ultimo potrebbe produrre gli effetti che la legge gli attribuisce esclusivamente se l'estinzione sia già stata pronunziata dal giudice dell’esecuzione, la cui decisione sul punto, dunque, finirebbe per condizionare le sorti del giudizio di opposizione all’esecuzione[36].
Ritornando al tema qui esaminato, va rilevato come recente decisione, in una vicenda sostanzialmente analoga, quantomeno con riferimento agli elementi fondamentali – attinenti cioè alla sussistenza o meno dei requisiti per valere come titolo esecutivo, di un atto ricevuto da notaio – a quella che ha fornito lo spunto per questa riflessione, ha negato simile valenza ad un atto di concessione di ipoteca da parte del terzo datore, su rilievo che esso non conteneva una dichiarazione di volontà ricognitiva dell'esistenza del debito nei confronti del creditore, ma una semplice dichiarazione di scienza rispetto al debitore, rilevando come il solo atto di concessione di ipoteca non risultava idoneo a produrre un effetto confessorio o anche solo ricognitivo circa l'esistenza del debito per il quale veniva prestata la garanzia.[37]
Ed invero, il requisito della certezza del diritto, risultante dal titolo medesimo, è essenziale per i titoli esecutivi, giudiziali e stragiudiziali, menzionati dall’art. 474 c.p.c., ed esso va inteso nel senso che la situazione giuridica accertata in favore di un soggetto deve emergere esattamente e compiutamente, nel suo contenuto e nei suoi limiti, dal relativo provvedimento giurisdizionale o atto negoziale, di guisa che ne risulti determinato e delimitato anche il contenuto del titolo.
In caso contrario, allora, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ove difetti tale intrinseco requisito, il titolo esecutivo non può essere riconosciuto come tale, né può attingersi aliunde siffatta certezza, nemmeno, ove si tratti di esecuzione forzata di obblighi di fare[38]; tale orientamento è stato ribadito dalla S.C. con successiva pronunzia, ove si è affermato che, in vista dell’esecuzione forzata, potrà ritenersi valido un titolo che presenti il requisito della certezza del diritto soggettivo non solo nel caso in cui, in esso, il contenuto del diritto in questione risulti precisamente determinato, ma anche quando esso sia facilmente determinabile alla stregua degli elementi indicati nella sentenza che lo accerta in modo definitivo e non vengano mosse contestazioni specifiche dall’obbligato[39].
Per restare alla fattispecie specifica oggetto del provvedimento qui richiamato, la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno praticamente sempre escluso che il contratto di mutuo condizionato potesse risultare idoneo a fondare una azione esecutiva. Invero, con pronunzia risalente, la S.C. ha rilevato che non costituisce titolo esecutivo, né nei confronti del mutuatario, né verso il fideiussore di costui, il contratto di finanziamento condizionato stipulato con atto pubblico notarile poiché tale contratto, prevedendo la restituzione della somma promessa a mutuo solo dopo la concreta erogazione del finanziamento stesso, non documentava l’esistenza di un diritto di credito dotato del requisito della certezza[40]; inoltre, la giurisprudenza di merito ha evidenziato come esso, per la sua stessa e peculiare natura, risulti carente dei requisiti di cui all’art. 474, n. 3, c.p.c., con conseguente sua totale inidoneità, sotto qualsiasi profilo, a costituire titolo esecutivo[41]; va però tenuto presente, come di recente osservato da alcuni, che, a seguito della riforma del 2005, tale documento contrattuale, pur se carente all'origine, potrebbe acquistare successiva valenza di titolo esecutivo per effetto della sua integrazione tramite una quietanza rilasciata dal debitore, nelle forme della scrittura privata autenticata nella sottoscrizione, relativamente alle somme ricevute dal mutuante[42].
Infine, deve evidenziarsi, con riguardo ai caratteri peculiari della predetta ordinanza di improcedibilità resa dal giudice dell’esecuzione in sede di processo esecutivo – quindi da un punto di vista eminentemente processualistico - che alla stessa vada riconosciuta natura puramente dichiarativa in ordine alle condizioni di procedibilità dell’azione esecutiva, come tale inidonea a statuire su diritti, essendo priva di contenuto decisorio in ordine al diritto di credito azionato ed ai relativi accessori, ivi compresa la garanzia ipotecaria, come del resto ritiene la giurisprudenza di merito[43], e come conferma in pieno quella di legittimità, secondo cui, costituendo l’esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall’art. 474 c.p.c., un presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all’esecuzione, suo logico corollario deve individuarsi nella circostanza del riconoscimento al giudice dell’esecuzione del potere-dovere - con accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo in quanto funzionale all’emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione - di verificare l’idoneità del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto[44].
Evidente, allora, appare la differenza con l'accertamento che il medesimo giudice è chiamato a compiere in quella parentesi di cognizione nel processo esecutivo rappresentata dall’opposizione all'esecuzione, poiché in tal caso, come afferma la S.C., l’accertamento dell’idoneità del titolo ha natura preliminare per la decisione dei motivi proposti anche se questi non investano direttamente tale questione, in quanto l’opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 c.p.c. si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente.[45]
3. Il caso concreto
Lo spunto per la presente riflessione è fornito da una decisione di merito[46], in cui il tribunale si è trovato ad affrontare la – invero tutt'altro che pacifica - questione relativa alla verifica, da parte del giudice dell'esecuzione, della sussistenza o meno dei requisiti del titolo posto a base dell'azione esecutiva proposta dal creditore; problematica, questa, oggetto di recenti approfondimenti da parte della giurisprudenza di legittimità, che ha fatto anche registrare posizioni non sempre esattamente coincidenti, e che ha fatto affermare, alla dottrina, che la relativa problematica risulta una di quelle meno approfondite a proposito del titolo esecutivo[47].
Innanzitutto, si tratta di una questione che, avendola rilevata d’ufficio, il giudice ha sottoposto alle parti previo invito a discuterla nonché ad integrare le proprie difese sul punto, in ossequio a quell’orientamento della S.C. secondo cui il giudice dell’esecuzione, qualora rilevi che il titolo esecutivo non presenti i requisiti richiesti dall’art. 474 c.p.c., prima di adottare i provvedimenti conseguenti, deve invitare le parti - nel rispetto del principio del contraddittorio - a discutere la questione e a integrare le proprie difese anche sul piano probatorio, per non incorrere nel vizio di ultrapetizione.[48]
Si tratta di un rilievo che, nel caso specifico, il tribunale, riscontrando come il documento posto a base dell’azione esecutiva – un titolo esecutivo stragiudiziale – si rivelava contraddittorio in ordine al requisito della traditio, in quanto vi erano dichiarazione contrastanti in proposito, che non consentivano di ritenere raggiunta la relativa prova [49], aveva formulato con il richiamare quell’orientamento della S.C. secondo cui il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario conferisce al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo[50].
Secondo il Tribunale, nel caso sottoposto al suo esame si era in presenza dell'apposizione di una condizione al c.d. preliminare di mutuo – previsto dall'art.1822 c.c. - ipotesi ammessa dalla dottrina (e se ne comprende la ragione, sulla scorta di quanto innanzi rilevato) in quanto indicativa della volontà dei contraenti di differire la consegna delle cose e, quindi, l'efficacia del contratto, al momento dell'avverarsi della condizione[51]; che il Tribunale a tanto potesse legittimamente provvedere conduce a ritenerlo l’orientamento della S.C. secondo cui, ove l'esecuzione forzata sia basata su un titolo di natura contrattuale, il giudice dell'esecuzione può rilevare d'ufficio non solo l'inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti[52], in quanto nel processo esecutivo vige il principio per il quale il titolo esecutivo deve esistere al momento in cui inizia l'azione esecutiva, non potendosi formare successivamente, e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione[53].
E’ anche vero, tuttavia, che la rigidità del richiamato principio pare essere stata di recente mitigata dalla S.C., con l’affermare che la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall’inizio alla fine della procedura va intesa, con riguardo al processo di esecuzione, nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì, la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure di eventuale interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell’originario pignoramento[54]; come dire che, secondo la Corte, è sufficiente che vi sia un titolo esecutivo, che non deve necessariamente essere quello dell'originario creditore procedente, in quanto nessuna norma lo impone.
In conseguenza, in ossequio a tale principio, il Tribunale ha rilevato che le contrastanti dichiarazioni contenute nel documento posto a base dell’azione esecutiva evidenziavano, in sostanza, l’intento del mutuante di procrastinare il perfezionamento dell’accordo, di guisa che, dal contratto medesimo, non poteva inferirsi l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, a maggiore ragione perché il sorgere dell’obbligo restitutorio a carico del mutuatario risultava condizionato al verificarsi di eventi successivi, la cui prova non poteva fornirsi secondo formalità diverse dall’atto pubblico ovvero dalla scrittura privata autenticata; tale rilievo appare in linea con quella giurisprudenza secondo cui il contratto medesimo non è suscettibile di assumere valore di titolo esecutivo, per effetto della sua integrazione con le quietanze dei versamenti fatti dal mutuante al mutuatario, trattandosi di atti non formalmente omogenei con esso, in quanto manca il ricevimento, da parte di, notaio della dichiarazione negoziale costitutiva di debiti pecuniari[55].
Questa scelta del Tribunale appare a maggiore ragione condivisibile in quanto dal contratto medesimo emergeva che la somma in questione – ecco una delle contraddizioni rilevate dal giudice – mentre in una parte del predetto documento veniva dichiarata come erogata, in altra, invece, veniva indicata come ancora vincolata, quindi non disponibile per il mutuatario, e come tale, allora, secondo il richiamato orientamento di legittimità, mai entrata nella giuridica disponibilità del mutuatario medesimo[56]; contraddizione insorgente, dunque, quale conseguenza di clausole contrattuali che, sostanzialmente, finivano per escludersi l’una con l’altra.
In questo, del resto, il predetto giudice di merito risulta preceduto da quell'orientamento di legittimità secondo cui in un contratto di mutuo, ove le parti abbiano pattuito che la consegna della somma mutuata debba avvenire solo successivamente all’espletamento, da parte del mutuatario, di alcune formalità – è proprio quanto previsto dal contratto esaminato dal tribunale oplontino - la fattispecie negoziale non si perfeziona prima del compimento di tali adempimenti, anche se, per ipotesi, la somma in questione sia stata annotata nei registri della sezione mutuante della banca[57]; si tratta di adempimenti che, all'evidenza, per volontà delle parti sono stati considerati prodromici ed al tempo stesso imprescindibili perchè potesse ritenersi validamente perfezionato un contratto di mutuo. Al riguardo va poi aggiunto che la giurisprudenza di legittimità, sin da tempo risalente, ha ritenuto che tale tipologia di contratto non è suscettibile di assumere valore di titolo esecutivo, per effetto della sua integrazione con le quietanze dei versamenti fatti al mutuatario e degli estratti dei libri contabili dell’istituto mutuante, trattandosi di atti non formalmente omogenei con esso, in quanto manca il ricevimento da parte di notaio della dichiarazione negoziale costitutiva di debiti pecuniari.[58]
Per concludere sul punto, va infine rilevato come anche altra decisione di merito, di recente, ha mostrato di ritenere che, ogni qual volta dal meccanismo negoziale emergente dal mutuo non risulta possibile individuare l’atto di disposizione del mutuatario e con esso la giuridica fuoriuscita della somma da un patrimonio all’altro, dovrà allora riconoscersi che la banca abbia trattenuto la somma presso di sé, con una modalità che effettivamente mira a procrastinare il perfezionamento del contratto di mutuo e, conseguentemente, escludersi la valenza di titolo esecutivo di detto atto, restando mere clausole di stile quelle relative alla ricezione delle somme di cui viene data formale quietanza.[59]
4. Il contratto di mutuo condizionato
Atteso che il provvedimento indirettamente qui annotato si incentra intorno ad una peculiare ipotesi di potenziale titolo esecutivo, il contratto di mutuo condizionato, rientrante nella categoria dei titoli stragiudiziali, appare opportuno una breve disamina dei caratteri generali dell'istituto in questione.
Ai sensi dell'art. 1813 c.c., il mutuo è quel contratto che si perfeziona con la traditio del suo oggetto, circostanza confermata dal fatto che la norma medesima prevede, appunto, che in forza di esso il mutuante si obbliga a consegnare al mutuatario una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili; si tratta, quindi, di un contratto reale, nell'accezione che di tale categoria la dottrina concordemente accoglie, e quindi di un contratto per il cui perfezionamento la consegna è indispensabile,[60] di guisa che ad essa si riconosce valenza di requisito che concorre a far ritenere perfezionata l'ipotesi prevista della norma, nel senso di non potersi parlare di mutuo in assenza di essa[61].
Invero, circa la rilevanza del requisito della consegna in un contratto come il mutuo, non pare superfluo un breve richiamo all'insegnamento della S.C., per la quale, nel diritto moderno, i contratti si perfezionano di regola con il semplice consenso delle parti, in applicazione del cd. principio consensualistico, previsto dall'art. 1376 c.c., e di tanto l'esempio più calzante viene individuato nel contratto di compravendita, che si perfeziona nel momento in cui si raggiunge l'accordo, per cui il consenso, formatosi secondo legge, produce gli effetti voluti, indipendentemente, e quindi anche prima, del trasferimento del possesso e del pagamento del dovuto[62]; dunque, se da tale ricostruzione emerge la indispensabilità del consenso, è la stessa giurisprudenza di legittimità che si premura, tuttavia, di precisare che esso, in relazione ad alcuni contratti speciali, anche se sempre necessario, al tempo stesso non è sufficiente, nel senso che il contratto si perfeziona esclusivamente al momento e con la consegna della cosa, con il materiale trasferimento alla controparte dell'oggetto del contratto – ed il mutuo è uno di questi – di guisa che, prima della consegna non c'è contratto, bensì solo uno degli elementi della fattispecie complessa (consenso + traditio) di cui è formato il contratto reale, traendone quale logico corollario che la consegna non è effetto obbligatorio del contratto, ma un elemento costitutivo dello stesso.[63]
Per le Sezioni Unite, infatti, i contratti obbligatori – quali locazione, mandato, comodato – ed i contratti con efficacia reale o traslativa - quali invece compravendita, permuta, donazione – concretamente si distinguono dal punto di vista degli effetti ed, in particolare, sotto il profilo della loro ampiezza, nel senso che, mentre i primi producono soltanto effetti obbligatori, poiché il consenso non produce automaticamente l'effetto voluto, ma determina il sorgere, a carico delle parti, dell'obbligazione di compiere un determinato atto ovvero di tenere un determinato comportamento, per converso i secondi producono anche effetti reali perchè, accanto e oltre l'effetto principale di trasferire o costituire diritti, determinano il sorgere, tra le parti, anche di obbligazioni da adempiere[64]; in conseguenza, nei contratti con efficacia reale, se sono consensuali (come la compravendita), il trasferimento o la costituzione del diritto reale si attuano per effetto immediato del consenso, mentre nel mutuo, che invece è un contratto reale, la proprietà sulla cosa fungibile si trasferisce solo nel momento in cui il contratto è perfetto, cioè nel momento in cui avviene la traditio della cosa prestata[65].
Ritornando alla consegna, va rilevato come detta nozione non può ritenersi limitata – e, per converso, il relativo requisito, integrato - esclusivamente al fatto materiale della traditio vera e propria, potendosi ritenere soddisfatta, invero, anche attraverso il riconoscimento, in favore del mutuatario della disponibilità giuridica della somma, visto che, come si rileva da alcuni, se esaminata dalla prospettiva del mutuatario, la causa del contratto di mutuo può individuarsi nel far conseguire a quest'ultimo nel modo più sollecito possibile – materiale o giuridico, a questo punto, non rileva – la disponibilità delle cose mutuate;[66] pertanto, secondo la richiamata opinione, la consegna immediata di queste ultime, prevista dal codice civile, si rivela idonea a raggiungere tale risultato in modo ottimale, poiché evita al mutuatario di adire la giustizia nel caso in cui il mutuante ci abbia ripensato, rendendosi inadempiente al suo specifico obbligo di consegnare le cose in questione.[67]
Va poi aggiunto che in giurisprudenza si è anche prospettata una ricostruzione del mutuo in termini di contratto a formazione successiva, che viene ad esistenza per effetto del susseguirsi, ad una prima fase integrata dal consenso dei contraenti, di una successiva fase, quella della consegna, avente carattere reale ed in grado di perfezionare l'accordo precedentemente raggiunto, secondo le modalità in esso preventivamente pattuite dalle parti stesse[68]; in ogni caso, che una traditio meramente ed esclusivamente materiale non sia indispensabile, è confermato da quella giurisprudenza che ha avuto modo di rilevare come, affinchè si perfezioni il contratto, ciò che risulta indispensabile è la creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario, in quanto esclusivamente attraverso tale creazione può ritenersi prodotto, dal punto di vista giuridico, l'effetto dell'uscita della somma concessa in mutuo dal patrimonio del mutuante, al fine del suo ingresso in quello del mutuatario[69]; in conseguenza, per la medesima giurisprudenza, la disponibilità giuridica di detta somma viene ad esistenza, in favore del mutuatario, allorquando il medesimo venga posto nelle condizioni di poterne disporre non solo senza la necessaria intermediazione della sua controparte contrattuale ma, eventualmente, anche contro il volere di quest'ultimo[70].
Se tanto è indiscutibile, altrettanto indubbio, però, è il fatto che la natura reale del contratto di mutuo non richiede in via tassativa che la cosa mutuata sia materialmente consegnata al mutuatario, in quanto il rispetto del requisito della traditio ben può ritenersi garantito, in determinati casi, allorquando il risultato pratico concretamente raggiunto si identifichi con quello che si sarebbe realizzato con la consegna materiale al mutuatario del bene mutuato, come ritiene la S.C.[71], per cui tale contratto è da ritenersi validamente perfezionato con il conseguimento della giuridica disponibilità delle cose mutuate da parte del mutuatario[72].
Allora, per rimanere alla fattispecie qui esaminata, la traditio rei può essere realizzata attraverso l’accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l’uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario[73]; tuttavia, quella appena indicata, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare, non costituisce l'unica modalità attraverso cui il predetto requisito può ritenersi soddisfatto, atteso che altra modalità è stata individuata, ad esempio, nella consegna di un assegno circolare, intestato alla parte mutuataria e recante la clausola di intrasferibilità, seguita da accettazione di tale assegno, da parte di quest’ultima, in luogo del denaro contante, e contestuale rilascio di quietanza a saldo[74]. Ancora, la realizzazione del requisito in questione è stata dalla giurisprudenza positivamente ravvisata allorquando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario conferisce al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo[75], come avviene nel caso - che rappresenta sostanzialmente l’ipotesi abituale - delle compravendite immobiliari, in cui la somma viene ad essere erogata direttamente in favore di un terzo, il venditore.
Invece, l’idoneità ad integrare il requisito della traditio ed il conseguente passaggio della somma mutuata nella giuridica disponibilità del mutuatario è stata dalla giurisprudenza esclusa con riferimento all'ipotesi in cui, a tale ultimo soggetto, sia stato consegnato, invece di quello circolare, un mero assegno bancario, sul rilievo che l’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro in quanto la stessa, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l’accipiens - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità[76], per cui, in tal caso, la consegna viene ritenuta sostanzialmente irrilevante in termini probatori; analogamente la giurisprudenza ha statuito nell'ipotesi in cui oggetto della consegna siano cambiali, in quanto titoli di credito in relazione ai quali la traditio potrebbe considerarsi attuata solo al momento dell’effettivo incasso delle somme in essi portate[77].
Tale ultima situazione, poi, determina anche rilevanti conseguenze in tema di riparto dell’onere probatorio, avendo infatti i giudici di legittimità affermato che l’attore risulta, in tale ipotesi, tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l’inversione dell’onere della prova[78]; si tratta, all'evidenza, di un principio chiaramente applicabile anche al creditore che agisce in executivis, con tutte le prevedibili conseguenze per la posizione di tale ultimo soggetto.
Dal versante dottrinale, è possibile innanzitutto rilevare come la consegna viene ritenuta elemento che possiede una duplice valenza, in quanto da un lato è necessaria e, dall'altro, riveste carattere di strumentalità nei confronti del consenso, di modo che, nel caso in cui i due predetti elementi non si combinassero, sarebbe impedito il perfezionamento del contratto di mutuo[79]; né, del resto, sempre secondo la medesima opinione, l'eventuale anticipata traditio sarebbe suscettibile di produrre tale effetto, ove alla stessa non tenesse dietro il definitivo consenso[80]; secondo alcuni, poi, la sua funzione è quella di creare, in favore del mutuatario, un titolo autonomo ed esclusivo di disponibilità, sia in quanto la somma esce dal patrimonio del mutuante per entrare in quello del mutuatario – di qui l'autonomia – sia in quanto il mutuatario deve poterne disporre non solo liberamente, quanto anche senza il consenso del mutuante – di qui la disponibilità - trattandosi quindi di una disponibilità giuridica[81]; con essa, in sostanza, deve effettivamente realizzarsi, secondo altro autore, la piena disponibilità della cosa da parte dell'accipiens, con contestuale perdita, da parte del tradens, di tale disponibilità[82].
Infine, si riscontra anche l'opinione di chi, ponendosi in una prospettiva funzionale, attribuisce alla consegna valenza sostanziale di appesantimento e/o aggravamento del procedimento di formazione di quello che è un contratto consensuale, giustificato dal fine che il contratto di mutuo mira a conseguire, il che dunque renderebbe comprensibile la circostanza per la quale, con la previsione di tale tipologia di contratti, richiedenti la consegna per il loro perfezionamento, il legislatore ha voluto introdurre una eccezione al principio del consenso[83], la cui rilevanza, anzi, si ritiene tale da costituire un vero e proprio vulnus al principio consensualistico[84].
Si sostiene, cioè, che il legislatore avrebbe, anche se in via del tutto eccezionale, costruito quella che si definisce una fattispecie forte, nell'ambito della quale la consegna viene in rilievo quale elemento aggiuntivo ulteriore rispetto all'accordo contrattuale, impedendone la conclusione in sua assenza, ed evidenziando, in relazione a tale ipotesi, l'insufficienza del consenso[85].
Per concludere sul punto, va aggiunto che, secondo alcuni, il carattere reale del contratto di mutuo, con la rigidità che esso presenta, risulta oggi, per varie ragioni e sotto vari aspetti, attenuato, in quanto il legislatore, anche se con sfumature differenti ed in contesti diversi, non ha mostrato assoluto rigore nel qualificare il mutuo come contratto reale, quantomeno con riferimento alla sua accezione più rigorosa di inderogabile contestualità tra conclusione del contratto e consegna del denaro[86]; di tanto la richiamata opinione individua, quali indici normativi, tra gli altri, l'art. 1822 c.c. sulla promessa di mutuo, nonché la possibilità, ammessa dal secondo comma dell'art. 39 del d.lgs n. 385 del 1.9.1993, che la stipulazione del contratto di mutuo e l'erogazione del denaro non avvengano contestualmente, ma con atti separati[87].
Da altro punto di vista, in dottrina si esclude la possibilità di sottoporre un mutuo ad una condizione che ne differisca l’efficacia ad un momento successivo alla sua conclusione – in concreto, quindi, ad una condizione sospensiva – sul rilievo per cui in tal modo il contratto medesimo non potrebbe dirsi validamente concluso, in quanto risulterebbe procrastinata la vera e propria conclusione del contratto e non soltanto la produzione dei suoi effetti, e tanto in ragione della fondamentale importanza che, ai fini della conclusione, assume l’elemento della consegna[88]; si afferma, in sostanza, che l'apposizione di un elemento accidentale che sospenda l'efficacia del contratto in attesa dell'avverarsi della condizione è inconcepibile poichè il mutuo è sottoposto già, ex lege, ad una condizione di efficacia, rappresentata dalla consegna[89], che in quanto impedita dalla condizione, a sua volta impedirebbe la valida conclusione del contratto medesimo, stante la sua natura reale[90]; del resto, in tale ipotesi la giurisprudenza ritiene che nemmeno potrebbe parlarsi di una condizione in senso tecnico apposta ad un mutuo, bensì un qualcosa di diverso, una operazione contrattuale scomposta in due fasi distinte tra loro[91]; per altra opinione, maggioritaria invero, deve invece ritenersi ammissibile la conclusione di un mutuo condizionato, affermandosi – con l'avallo della giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata – che, in realtà, ad essere assoggettato a condizione sospensiva non è il contratto di mutuo, il quale in assenza di consegna non può dirsi sia stato validamente concluso[92], ma piuttosto il preliminare accordo intervenuto tra le parti, la cui efficacia definitiva è subordinata alla consegna, attuata al verificarsi dell'evento dedotto in condizione[93]. Altra opinione ancora, poi, propone la ricostruzione del contratto di mutuo come contratto validamente perfezionatosi per effetto della mera prestazione del consenso dai parte dei contraenti, e tuttavia, in termini di sua efficacia, invece, sospensivamente condizionato al compimento di una determinata attività da parte di uno di essi, e cioè la consegna delle cose mutuate, a compiersi dal mutuante, ritenendo quindi il mutuo un contratto consensuale, ma sottoposto alla condizione sospensiva della consegna volontaria da parte del mutuante[94]; infine, si registra anche l’opinione di chi esclude che il contratto di mutuo condizionato possa valere quale titolo esecutivo, sul rilievo che tale documento contrattuale, sostanzialmente, non si rivela in grado di definire con esattezza l'obbligazione assunta dal mutuatario[95].
Dal punto di vista degli effetti, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il c.d. contratto condizionato di mutuo produce i medesimi effetti derivanti dalla promessa di mutuo, disciplinata dall'art. 1822 c.c., rilevando come, una volta iscritta ipoteca, costituisce inadempimento contrattuale la condotta della banca che si rifiuti di adempiere al suo obbligo di erogare la somma mutuata in tutte le ipotesi in cui non ricorra una valida giustificazione[96], quale potrebbe essere, ad esempio, un intervenuto mutamento delle condizioni patrimoniali del mutuatario che abbia reso le stesse tali da rendere notevolmente difficile la restituzione e non risultino offerte idonee garanzie, quindi l'ipotesi prevista dall'art. 1461 c.c.
Del resto, nel corso degli anni la giurisprudenza, con alcune pronunzie, di legittimità e di merito, ha sostanzialmente escluso che il contratto di mutuo condizionato risultasse idoneo a costituire valido titolo esecutivo, pervenendo di recente ad affermare che simile contratto, ove la consegna della somma sia differita nel tempo, non documenta di per sé l'esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro e, pertanto, pur se stipulato con atto pubblico notarile (per gli effetti che è destinato a produrre in ordine alla costituzione della garanzia ipotecaria), non può essere utilizzato come titolo esecutivo dalla banca mutuante che intenda procedere ad espropriazione forzata per la restituzione delle somme erogate, in quanto esso difetta dei requisiti previsti dall'art. 474, II comma, n. 3, c.p.c.[97].
5. Il fulmine a ciel sereno di Cass. civ., Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11067
La richiamata decisione delle Sezioni Unite è intervenuta, mutuando un termine dal linguaggio sportivo, a gamba tesa su decenni di consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale, suscitando sia critiche della dottrina più autorevole, come si evidenzierà infra - salvo qualche isolata voce favorevole – sia pronunzie, in seno al medesimo consesso, da parte delle sezioni semplici, di tenore opposto.
Sostanzialmente, due sono gli aspetti che risultano stravolti da tale arresto, innanzitutto l'autosufficienza del titolo esecutivo, e poi la netta separazione ed autonomia tra processo di cognizione e processo di esecuzione, che, in particolare, è stato dai giudici legittimità (ri)configurato come una sorta di ideale prosecuzione del processo di cognizione, allorquando, invece, esso dovrebbe essere esente, e non gravato, dal compito accessorio (ma che nel discorso delle SS.UU sembra diventato, invece, una sua finalità peculiare) di un riesame, al fine di conferire concreta tutela in executivis, alla situazione del creditore come accertata in sede di cognizione; come se, in sostanza, si dovesse accertare nuovamente se quel medesimo diritto, già oggetto di accertamento in sede di cognizione, esista effettivamente o meno o, quantomeno, esista nei termini in cui dalla pronunzia emessa in sede di cognizione è stato accertato.
Innanzitutto, una prima osservazione può farsi con riguardo alla individuazione della concreta estensione del potere di interpretazione del titolo esecutivo che può considerarsi attribuito al giudice della esecuzione: a tale proposito, occorre rilevare come, se appare non seriamente revocabile in dubbio che detto giudice, nel caso di incertezze derivanti dal dispositivo e dalla motivazione circa l’esatta estensione dell’obbligo configurato nella sentenza, possa procedere all’integrazione extratestuale del titolo stesso, si rivela altrettanto ben difficilmente contestabile che il medesimo, nello svolgimento di tale attività, risulti assoggettato ad alcuni limiti precisi ed invalicabili.
Quello che sembra essere uno di essi è stato dalle Sezioni Unite individuato in una sorta di origine per c.d. endprocessuale dei dati/elementi sulla scorta dei quali procedere ad integrare il titolo medesimo, essendo infatti inderogabilmente richiesto che i dati cui il giudice di merito intenda a tal fine fare riferimento, siano stati acquisiti al processo in cui il titolo giudiziale si è formato[98]; va detto, in positivo, che quella che a prima vista potrebbe sembrare una limitazione, come emergente dalla sopra richiamata ricostruzione formulata dalla giurisprudenza di legittimità, in realtà si rivela essere l'esatto opposto, ove si tenga presente che, con la richiamata decisione, la S.C. ha capovolto il proprio precedente orientamento, sulla scorta del quale si affermava che i dati per acquisire la necessaria certezza del diritto in esso indicato dovevano essere ricavati solo dal contenuto del titolo medesimo e non anche da elementi esterni non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla emanazione della sentenza di condanna[99].
Quindi, da tale punto di vista, è da riscontrare una evoluzione giurisprudenziale il cui scopo dichiarato appare quello di assicurare la maggiore e più estesa possibile, effettiva concreta attuazione del diritto consacrato nel titolo, orientamento mosso dall'intento di superare limitazioni di stampo prettamente formalistico, ritenute contrastanti con esigenze di giustizia sostanziale, e come tali in grado di pregiudicare la concreta realizzazione di queste ultime; inoltre, al fine di intendere il significato e l’estensione dell’accertamento compiuto con la sentenza, si afferma che è consentito di integrare il pensiero del giudice consegnato alla sentenza con quanto risulta dagli atti delle parti, dai documenti da esse prodotti, dalle relazioni degli ausiliari del giudice[100].
Questo perchè, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, se è indubbio che ai sensi dell'art. 474 c.p.c. il diritto accertato nel titolo posto in esecuzione deve essere assistito dall'indispensabile esattezza della sua individuazione[101], al tempo stesso tanto non implica che il titolo medesimo debba essere necessariamente compiuto e completo, di guisa che, in assenza di tale compiutezza, non può ritenersi precluso, al giudice, accedere agli atti del processo in cui il provvedimento si è formato, per colmare eventuali carenze di esso[102].
In dottrina, come detto, vi è chi accoglie con favore quello che pare costituire un vero e proprio capovolgimento dei principi generali, sulla scorta di quella che viene definita come una differente opzione ideologica, in grado di rovesciare tutte le preesistenti acquisizioni[103], sul rilievo per cui “quanto più l'ordinamento e la società nel loro complesso vengono a trovarsi in una fase di evoluzione, quale è l'attuale, in cui la giustizia civile è alla ricerca di soluzioni ai propri endemici problemi di lentezza ed inconcludenza, tanto più può accadere che si affermi un'interpretazione razionale alternativa, fondata su un diverso assetto dei valori in gioco”[104].
In tale modo, potrebbe cogliersi, quale reale intento dei giudici di legittimità, quello di individuare gli esatti contorni dell'attività di interpretazione del titolo, che sostanzialmente viene identificata nel compito di verificare che la parte che agisca in executivis abbia fatto valere realmente un documento che rientra tra quelli che l'art. 474 c.p.c. espressamente prevede e riconosce come titoli esecutivi, dovendosi infatti ritenere che il titolo predetto non presenti lacune e/o incertezze nella individuazione della situazione sostanziale che in esso risulta accertata; infatti, come afferma la S.C.“Colui che si rivolge al giudice ha diritto a conseguire una pronuncia chiara e comprensibile, suscettibile - se del caso - di essere messa in esecuzione senza necessità di alcuna attività di supplenza, in sede di cognizione o di esecuzione, finalizzata all’integrazione di eventuali lacune, aporie o contraddizioni del titolo”[105].
Tuttavia, se quanto innanzi rilevato appare tutto sommato non revocabile in dubbio, va detto altresì che la giurisprudenza di legittimità si mostra alquanto elastica nella individuazione degli elementi endoprocessuali tramite i quali deve ritenersi consentita al giudice della esecuzione l'integrazione/interpretazione del titolo ai fini della realizzazione della pretesa sostanziale tramite il processo di esecuzione, ove si consideri che, sulla premessa per cui il titolo esecutivo giudiziale, di cui all’art. 474, 2º comma, n. 1, c.p.c., non può ritenersi esaurito nel documento in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, perviene a ritenere come consentita l’integrazione del provvedimento con elementi extratestuali, purché idoneamente richiamati, ed ammette a tal fine la possibilità di integrare una sentenza d’appello anche attraverso un espresso rinvio alla condanna operata in primo grado, anche se la decisione di prime cure sia stata annullata in sede di impugnazione[106]; chi ritiene positivo il sostanziale revirement operato dalle SS.UU. ne individua l’elemento di maggiore rilievo nel riconoscimento dell'attività interpretativa extratestuale come contenuto di un dovere del giudice, finalizzato, anche nell’ottica del giusto processo, a cercare di ridurre al massimo possibile le ipotesi in cui risulti indispensabile ritornare indietro, dunque in sede di cognizione, tutte le volte che il predetto giudice dell’esecuzione sia in grado, individuando l’effettivo contenuto del titolo, di cogliere la reale ampiezza della statuizione in esso contenuta[107]; ciò in quanto, per la richiamata opinione, il fine ultimo che appare perseguito dai giudici di legittimità appare quello di contrastare le condotte ostruzionistiche di coloro il cui unico scopo è quello di ritardare il più possibile l’effettiva attuazione del diritto sostanziale azionato dal creditore procedente, sottolineato dall’esigenza, di cui vengono onerate le parti, di clare loqui, nel rispetto di un principio di lealtà (processuale), diretta conseguenza dei superiori principi emergenti dall’art. 2 Cost.[108]
Da un altro punto di vista, va detto che, indipendentemente da quanto affermato dalle S.UU., vi sono anche ipotesi in cui tale attività interpretativa da parte del giudice dell'esecuzione risulta invero indispensabile; tanto si verifica, ad esempio, nell'ipotesi in cui il contenuto del titolo sia rappresentato da un accertamento, e successiva condanna, a carico del destinatario, all'adozione di un determinato comportamento, come nel caso degli obblighi di fare: in tale ipotesi, infatti, il compimento dell'attività integrativa/interpretativa da parte del giudice dell'esecuzione assume una valenza stavolta fondamentale, dato che il predetto giudice, essendo chiamato a dare i provvedimenti necessari per l’attuazione di un obbligo di fare, accertato con sentenza emessa in un giudizio di cognizione, deve necessariamente, al fine di permettere la concreta esecuzione del relativo comando, procedere ad interpretare la sentenza, individuandone la portata precettiva sulla base delle statuizioni contenute nel dispositivo e delle considerazioni enunciate in motivazione, in quanto le stesse si rivelano essere le premesse logiche e giuridiche della decisione, come del resto riconosce la giurisprudenza di legittimità[109].
Nella predetta eventualità, allora, in applicazione dell'art. 612 c.p.c., il giudice della esecuzione potrà emettere provvedimenti di natura e contenuto diversi, sempre all'esito dell'attività di interpretazione del titolo esecutivo; infatti, innanzitutto potrà, con ordinanza, determinare le modalità dell’esecuzione forzata di una sentenza per violazione di un obbligo di fare o di non fare, ed in questo caso si tratterà di un provvedimento con il quale vengono fissate le regole dello svolgimento del procedimento esecutivo, per cui detta ordinanza non investe (né tantomeno esamina) il diritto della parte di procedere all’esecuzione, essendo il suo contenuto limitato alle modalità secondo cui deve procedersi all'esecuzione del titolo, come afferma la S.C.[110]; al contrario, sempre secondo i giudici di legittimità, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, sempre con una ordinanza (che è la forma di provvedimento espressamente prevista e richiamata dall'art. 612 c.p.c.) per addivenire a stabilire le modalità di svolgimento di una esecuzione, debba preventivamente risolvere contestazioni attinenti la portata del titolo esecutivo nonché l’ammissibilità o meno dell’azione esecutiva intrapresa dal procedente, il relativo provvedimento avrà inevitabilmente un contenuto decisorio, poiché accerterà o negherà il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e pertanto da ritenersi equivalente ad una sentenza, con tutte le relative conseguenze, anche in termini di mezzi di impugnazione avverso la stessa esperibili[111].
Anche in questo caso, però, l'estensione di tale potere riconosciuto al giudice dell'esecuzione non può ritenersi senza limite, in quanto nell'emettere il provvedimento ritenuto idoneo a dar corso alla coattiva realizzazione di quanto venga ritenuto conforme al titolo esecutivo azionato, anche ponendo in stretta relazione le operazioni materiali individuate come concretamente da attuare, con la interpretazione che il medesimo giudice attribuisce al titolo esecutivo in questione, egli non potrà spingersi sino al punto di sostituire e/o integrare il titolo azionato con un ulteriore e diverso titolo da lui emesso, poiché in tal modo finirebbe per gravare il creditore dell’onere di porre in esecuzione un separato comando, impartito al debitore in aggiunta o sostituzione di quello recato dal titolo originario[112].
Appare opportuno, allora, tenere nella dovuta considerazione che, con particolare riguardo ai titoli esecutivi il cui oggetto è costituito da somme di denaro, secondo una opinione dottrinale il giudice dell'esecuzione non dovrebbe incontrare grosse difficoltà a reperire gli elementi integrativi necessari alla concreta attuazione del diritto consacrato nel titolo esecutivo[113]; ecco perchè, visto il compito che la S.C. attribuisce al giudice dell'esecuzione, la cui rilevanza è indubbia, e che altrettanto indubbiamente diviene progressivamente più impegnativo – ma anche, per converso, più importante ai fini della concreta attuazione del diritto consacrato nel titolo (passando dai titoli esecutivi relativi a somme di denaro, a quelli che hanno ad oggetto obblighi di fare, allora il giudice dell'esecuzione) – il predetto giudice, accogliendo quella sollecitazione che da parte della dottrina gli viene chiaramente rivolta, concretamente potrà (rectius, deve ritenersi che, più esattamente, dovrà) abbandonare un ruolo, nella gestione della procedura, tante volte meramente ragionieristico, per assumere una effettiva contitolarità della regia giudiziaria[114]. Tale sollecitazione, per inciso - ad avviso di chi scrive - l'estensore della pronunzia che ha dato lo spunto a questo scritto appare aver colto ed espletato in pieno, avendo verificato in maniera compiuta ed esaustiva se, nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, il documento posto a base della proposta azione esecutiva poteva o meno valere come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
6. Riflessioni conclusive
Dopo il tentativo di ricostruire la vicenda e gli istituti che in essa vengono in rilievo, che si è provato a fare nelle pagine precedenti, in conclusione, appare opportuno brevemente enucleare alcune considerazioni finali.
Occorre infatti tornare un attimo indietro alle preoccupazioni manifestate da alcuni in ordine all'apertura mostrata dalle Sezioni Unite, nel 2012, circa la possibilità che il giudice dell'esecuzione proceda ad una integrazione extratestuale del titolo esecutivo, preoccupazioni che evidenziano, invero, anche risvolti preoccupanti e tutt’altro che positivi per la certezza del diritto.
Invero, secondo autorevole opinione, la ricostruzione fornita dalla giurisprudenza di legittimità con la richiamata decisione rischia di produrre conseguenze pericolose e fuorvianti[115], e pertanto quello che chi scrive ha ipotizzato di qualificare in termini di limite a tale potere del giudice dell'esecuzione, sembrerebbe comunque insufficiente, in tale prospettiva. Emerge allora con evidenza, che, per effetto di tale ricostruzione, nello svolgimento della predetta attività il giudice dovrà limitarsi al compimento esclusivamente di una attività interpretativa, volta ad individuare l'esatto contenuto e la portata precettiva del titolo, sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni[116]; la ragione di tale limitazione ben si comprende tenendo presente che il titolo esecutivo deve essere determinato e delimitato, in relazione all’esigenza di certezza e liquidità del diritto, in particolare se trattasi di diritto di credito, che ne costituisce l’oggetto.
Va evidenziato che tale ampliamento della attività latu sensu ermeneutica del titolo esecutivo, da parte del giudice dell'esecuzione, nei termini che innanzi abbiamo osservato, come ormai pacificamente ammessa da parte della giurisprudenza di legittimità, per certi versi sembrerebbe, a prima vista, un controsenso, poiché conduce a mettere in discussione quella ricostruzione del titolo esecutivo come strumento che basta a sé stesso[117], rendendolo allora bisognoso, per svolgere la sua funzione, di un intervento esterno, quale quello del giudice dell'esecuzione, che finirebbe per smentire tale autonomia ed autosufficienza, portando quindi ad ammettere, al contrario, che il concreto svolgimento della funzione del titolo sia condizionata ad un intervento in tali termini del giudice della esecuzione; ed infatti, tale ricostruzione viene decisamente criticata da una parte della dottrina, che rileva come, in tal modo, si finisce per sovrapporre e confondere attività quali attuazione, da un lato, ed integrazione, dall'altro, del titolo esecutivo, che pur se separate da un confine senza dubbio labile, vanno comunque tenute distinte[118], mentre, sempre secondo la medesima opinione, l'assunto della Corte potrebbe essere visto come un tentativo di attenuare la cesura tra cognizione ed attuazione, accentuando la prima all'interno della seconda[119].
Si afferma, infatti, che con tale ricostruzione la S.C. ha finito per modificare la struttura e la funzione del titolo esecutivo, sostanzialmente affermando che il titolo esecutivo non va più individuato nel documento-sentenza, bensì nella decisione che quel documento rappresenta, e che, in conseguenza, potrà essere interpretata ed integrata con tutto il materiale che il giudice ha utilizzato ovvero avrebbe dovuto utilizzare, per formulare il suo giudizio, di guisa che il titolo, anche se non certo, attraverso la sua interpretazione/integrazione mediante il riferimento a tutti i predetti elementi, utilizzati e/o utilizzabili dal giudice che ha emesso la decisione, recupera la certezza ma, per converso, perde autonomia ed astrattezza[120]; secondo ulteriore opinione, poi, la possibilità di rinvenire ab externo elementi integrativi del titolo esecutivo, onde addivenire alla esatta individuazione dell’ampiezza e confini del comando in esso contenuto, costituisce una scelta che si colloca agli antipodi del principio della letteralità del titolo sulla scorta di un parametro di sua autosufficienza documentale[121].
Risulta quindi evidente che, in tal modo, il passo avanti che pare aver compiuto la S.C. nella prospettiva di ampliare le possibilità di intervento, per il giudice dell'esecuzione, al fine di assicurare concreta attuazione al diritto azionato in forma esecutiva - atteso che, come si rileva da parte di alcuni, appare indubitabile che la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di integrare il titolo esecutivo, comporta risparmio di tempo e fatica per il creditore, nonché una riduzione dei procedimenti di cognizione[122] - nei fatti appare assorbito e controbilanciato, in negativo, per il fatto che, con tale ricostruzione, si viene a ricondurre il titolo nell'alveo del processo di cognizione che ha portato alla sua formazione, mettendo quindi in discussione il fondamentale requisito della certezza e compiendo, in tal modo, quello che gli anglosassoni definiscono one step up and two steps back; del resto, come si afferma in dottrina, non può dubitarsi del fatto che una pronunzia giudiziale dubbia o carente non è suscettibile di essere integrata dal giudice in sede di opposizione all’esecuzione attraverso il richiamo a norme di diritto e/o orientamenti giurisprudenziali non richiamati dal giudice che la pronunzia in questione ha emanato[123], poiché il documento, astrattamente riconducibile al catalogo di cui all’art. 474 c.p.c. costituisce titolo esecutivo non solo quando rivesta la forma necessaria, ma anche quando, in ogni caso, cristallizzi l’esistenza dell’obbligazione in modo certo, senza che sia indispensabile attingere altro gli elementi probatori a tal fine occorrenti[124].
In conseguenza, deve convenirsi con chi sostiene che non è accettabile l'idea di fondo che, pur se non dichiarata, appare indiscutibilmente presupposta alla decisione n. 11067/12 delle Sezioni Unite, ovvero che il processo di esecuzione possa, all'occorrenza, divenire una sorta di prosecuzione di quello di cognizione, in cui risulti possibile liberamente discutere del contenuto del titolo esecutivo, dell'accertamento in esso consacrato, al fine di delinearne i confini esatti, finendo per creare una sorta di duplicato della impugnazione del titolo, riservata espressamente dal legislatore ad altra sede, appunto quella delle impugnazioni[125]; inoltre, come altro autore rileva, con tale ricostruzione si determina uno stravolgimento del sistema sotto vari aspetti[126]; essi interessano, solo per citarne alcuni, la nozione di titolo esecutivo, la quale è tradizionalmente ancorata all’atto ovvero al documento, e non certo al giudizio che di esso costituisce espressione, nonché la nozione di certezza del diritto, quale può emergere esclusivamente da un provvedimento che individua con certezza contenuto e limiti di un determinato diritto[127].
Appare evidente, allora, che, a voler seguire la ricostruzione prospettata dai giudici di legittimità con la decisione innanzi richiamata, si finirebbe per creare rilevanti problemi, sia da punto di vista del creditore procedente, sia da quello del debitore esecutato, mettendo seriamente in discussione la natura e la funzione del titolo esecutivo che il legislatore, nonché decenni di precedente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ci hanno consegnato, originando diversi inconvenienti.
Innanzitutto, il primo inconveniente lo si riscontra dal punto di vista del creditore, poiché l'arresto della S.C. finisce per legittimare la possibilità di attribuire, all'atto di precetto, una funzione di precisazione, se non addirittura di integrazione, del titolo esecutivo, funzione che non solo non è attribuibile a tale atto stragiudiziale – la cui unica funzione, come è noto, è quella di intimare al debitore l'esecuzione della prestazione come risultante dal titolo – ma che, altresì, oltre ad essere errata, è anche pericolosa, poiché in pregiudizio della certezza del diritto, che nel processo di esecuzione rinviene (rectius, dovrebbe rinvenire) solo il luogo di sua realizzazione, e non anche di suo accertamento[128].
Inoltre, il secondo e non meno rilevante inconveniente lo si riscontra dal punto di vista del debitore esecutato, dal momento che, seguendo alla lettera tale orientamento di legittimità, secondo la dottrina, con riferimento, ad esempio, all'ipotesi del giudizio di opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo, per tale via si finirebbe per ammettere la possibilità di sollevare, contestazioni avverso il titolo ed il procedimento di sua formazione che, invece, avrebbero dovuto essere sollevate esclusivamente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, mettendo in discussione la sua emanazione sulla scorta sia degli elementi presi in considerazione dal giudice che ha emesso il titolo, sia di quelli, presenti in tale procedimento ma che il predetto giudice non ha inteso prendere in considerazione, sia ancora quegli elementi magari non presenti in tale procedimento, ma che comunque il giudice avrebbe potuto prendere in considerazione, o perchè desumibili da quelli effettivamente presenti, oppure, ancora, perchè ricavabili dal notorio, ex art. 115 c.p.c.[129].
Risulta pertanto senza dubbio condivisibile quanto afferma chi sostiene che le Sezioni Unite, allorquando predicano che le parti – il creditore con il precetto, il debitore con l'opposizione all'esecuzione - devono clare loqui, evidentemente trascurano che è prima di tutto il titolo esecutivo che dovrebbe esprimersi nei termini che esse pretendono dal creditore e debitore[130], aggiungendosi poi, al riguardo, che, come rilevato da un autore già citato, in tal modo si ottiene l'effetto esattamente opposto, poichè riconoscendo al giudice dell'esecuzione un potere di interpretazione così ampio, si finisce per quasi esonerare le parti dal dettagliare le proprie domande nella fase della cognizione, con i conseguenti effetti sul titolo, atteso che, di frequente, l'incertezza del pronunciato è diretta conseguenza dell'incertezza del chiesto[131]; dal punto di vista concreto, anzi, tale impostazione rischia di indurre le parti ad assumere – se non addirittura estremizzare - un atteggiamento processuale tendente ad esplicitare in modo tutt'altro che specifico e chiaro le proprie pretese, se le stesse riterranno di poter fare, comunque, affidamento su una così ampia attività interpretativa/integrativa del giudice dell'esecuzione.
Deve allora riaffermarsi - confidando che le SS.UU. quanto prima ritornino sui loro passi per restituire al titolo esecutivo le sue caratteristiche istituzionali di certezza, autonomia ed astrattezza, perchè la certezza, liquidità ed esigibilità del diritto risultante dal titolo realmente sono tutto ciò che conta nella prospettiva dell'esecuzione forzata,[132] ma anche, al tempo stesso, tutto ciò che occorre – che i citati requisiti della della certezza, liquidità ed esigibilità del diritto, emergenti da un titolo che si riveli effettivamente astratto ed autonomo, sono imprescindibili e non possono essere chiariti, integrati e/o esplicitati da elementi extratestuali, poiché il processo di esecuzione, al pari delle eventuali opposizioni, non sono il luogo in cui le parti devono contraddire per individuare l'oggetto della pretesa esecutiva, nè tantomeno può dirsi ammissibile, in essi, la introduzione di elementi volti a superare e/o surrogare quanto è e deve essere nel titolo esecutivo[133]; tanto, invero, rileva a maggiore ragione considerando che, come da alcuni evidenziato, ulteriore e non meno rilevante inconveniente che la ricostruzione prospettata dalle SS.UU. si rivela suscettibile di causare, è costituito da una ingiustificata diversificazione della nozione di titolo esecutivo giudiziale da quello di titolo esecutivo stragiudiziale, poiché le sopra evidenziate caratteristiche del titolo esecutivo appaiono ben difficilmente trasferibili ad un titolo di diversa natura, quale è quello stragiudiziale, con la inevitabile quanto ben difficilmente giustificabile conseguenza di dover ammettere che il processo di esecuzione risulti diverso a seconda che a base del medesimo venga posto un titolo esecutivo giudiziale oppure stragiudiziale.[134]
Pertanto, va recuperata e ribadita la netta separazione tra cognizione ed esecuzione, la distinzione delle loro funzioni – invero pericolosamente messa in discussione dalla richiamata decisione di legittimità – mettendo un deciso freno, da subito, a quei potenziali, e potenzialmente incontrollati ed incontrollabili, fenomeni di osmosi che potrebbero verificarsi tra le due tipologie di processi; questo perchè, come si afferma in dottrina, la citata decisione della S.C., con il propugnare l'idea che il titolo giudiziale è l'intero processo, di cui la sentenza è il precipitato, e che l'opposizione all'esecuzione è il luogo non solo normalmente, quanto anche e soprattutto, istituzionalmente, deputato proprio all'individuazione del diritto che deve essere attuato, non solo sulla scorta del titolo, ma anche di altri elementi esterni, finisce per alterare il delicato rapporto tra processo di cognizione e processo di esecuzione[135].
In proposito, non va dimenticato che, come autorevolmente si afferma, l'attività giurisdizionale esecutiva si contrappone dunque alla cognizione, nel senso che, mentre con quest’ultima si passa dall’affermazione del diritto al suo accertamento, con l’esecuzione si passa dall’accertamento all’attuazione materiale coattiva[136]; inoltre, secondo la medesima opinione, il processo esecutivo possiede autonomia parziale ovvero totale rispetto alla fase di accertamento del diritto, atteso che, mentre quando fa seguito al processo di cognizione (di condanna), si coordina con quest’ultimo sotto il profilo funzionale, nel senso che la condanna è in funzione dell’esecuzione forzata, la quale è a sua volta in funzione dell’attuazione del diritto, pur essendo, rispetto al primo, del tutto autonomo sul piano strutturale[137], per converso, quando rinviene a proprio fondamento un accertamento non giudiziale la sua autonomia rispetto alla cognizione è totale, involgendo anche il piano della funzione concretamente svolta[138]; si mostra invece in disaccordo con l'orientamento maggioritario chi sostiene che, dall'analisi di alcune recenti riforme legislative, quali l'art. 709ter cpc e l'art. 614bis cpc in particolare, sembrerebbe emergere una tendenza legislativa di segno esattamente opposto, rivolta ad accentuare l'attuazione esecutiva del diritto all'interno della cognizione, affidando cioè allo stesso giudice che autorizza la condanna, l'incarico di dettare anche le modalità attuative della condanna medesima, finanche sovrintendendo alla fase esecutiva, poiché, in questo modo, si favorisce l'immediatezza della tutela esecutiva, a discapito delle lunghe parentesi di cognizione insorgenti a seguito di proposizione di opposizione all'esecuzione da parte del debitore esecutato, nel contempo mettendo anche al riparo la parte vittoriosa dai rischi derivanti da un eventuale eccessiva genericità del titolo esecutivo[139]. Ciò perché, secondo tale autore, ove sussista il rischio che eventuali difficoltà di esecuzione possano incidere sul contenuto del titolo esecutivo, la soluzione preferibile è quella di affidare l'incarico al giudice che ha svolto il processo di cognizione, ritenuto l'unico in grado di ristabilire l'armonia tra mezzo e risultato.[140]
In ogni caso, detto che la soluzione ipotizzata dall'opinione da ultimo richiamata, se appare per un verso astrattamente condivisibile[141], da altro punto di vista tale non si rivela concretamente praticabile, in quanto appare spingersi eccessivamente nella direzione opposta, auspicando che sia il giudice della cognizione ad agire come giudice dell'esecuzione (se non del tutto sostituirsi a questi), atteso che si basa su di un presupposto che non appare idoneo a suffragare tale prospettato capovolgimento[142], il cui impatto, peraltro, non appare meno radicale di quello suscettibile di essere determinato da SS.UU n. 11067/2012 - che pure tale opinione critica – allora non può che ribadirsi come sia massimamente auspicabile che il sopra richiamato rapporto di autonomia tra cognizione ed esecuzione, venga opportunamente mantenuto e preservato nei termini in cui lo stesso è stato configurato e voluto dal legislatore, poiché solo in tal modo potrà dirsi assicurato il requisito, in particolare, della certezza del diritto consacrato nel (e dal) titolo esecutivo.
Ne consegue, pertanto, che appare senza dubbio meritevole di adesione l'opinione di chi sostiene che la citata decisione si rivela latrice di un principio di diritto assolutamente non condivisibile in quanto, da un lato, permette al creditore di aggredire in executivis il patrimonio del debitore anche nel caso in cui il diritto emergente dal titolo non si presenti assistito dai caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità (con peculiare riferimento quindi al diritto di credito, ma suscettibile di estendersi anche a diritti diversi) mentre, da altro punto di vista, confina ad un momento solo eventuale e successivo, quello dell’opposizione, il contraddittorio con il debitore, ad esecuzione già avvenuta[143]; allora, come sostiene la richiamata opinione, esso si appalesa quale vero e proprio monstrum, avulso da qualsiasi riscontro e sostegno sia nella logica sia nel diritto positivo, i cui effetti negativi risultano ben difficilmente evitabili con il ricorso al contraddittorio in sede di opposizione che la Corte richiama ed invoca[144], quasi che – opinione di chi scrive – esso costituisca antidoto per tutti i mali…..di cui all’evidenza la Corte medesima si mostra consapevole potranno derivare dalla censurabile e censurata (forse non ancora abbastanza) ricostruzione prospettata, dato che con tale decisione le Sezioni Unite, come affermato da uno studioso, hanno indirettamente capovolto le funzioni dei principali istituti del processo esecutivo, in quanto il precetto si è visto attribuire funzioni peculiarmente attribuite al titolo, mentre il debitore, con l’obbligo posto a suo carico di clare loqui anch’egli, è come se gli si chiedesse, in sostanza, di aiutare il creditore a colmare le lacune della propria pretesa, rimediando ai vizi e carenze del titolo[145].
Tale ricostruzione, invero, e concludo, appare nettamente sbilanciata, in violazione della doverosa parità delle armi, privilegiando, per quanto si è innanzi provato ad evidenziare, oltremisura, e senza valida giustificazione, la posizione del creditore, a discapito, nell'immediato, della posizione del debitore, nonchè, mediatamente, della superiore esigenza di certezza del diritto; tali dubbi della dottrina paiono aver trovato eco e conferma in un recente arresto giurisprudenziale, in cui la corte di legittimità è pervenuta a dubitare del fatto che il titolo esecutivo costituisca la condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per procedere ad esecuzione forzata, ad esempio nel caso di un titolo esecutivo che, nel dispositivo, si limiti a condannare al pagamento di accessori "dal di del dovuto", senza presentare altra specificazione e senza espressa o implicita menzione di tale decorrenza nel corpo della motivazione[146]; in tal caso, infatti, il titolo in questione è stato drasticamente censurato siccome tautologico ed irrimediabilmente illegittimo per indeterminabilità dell'oggetto, venendo esso meno, con tale formula, alla sua funzione di identificazione compiuta e fruibile - cioè specifica o determinata, ovvero almeno idoneamente determinabile del dovuto[147], e questo nonostante il fatto che indiscutibilmente di un titolo esecutivo si trattava.
In tal modo, pare essere stato, almeno in parte, disatteso il citato precedente orientamento palesato dalle Sezioni Unite, con cui, come si è detto, si era sostenuto che il giudice dell’esecuzione, nel caso di incertezze derivanti dal dispositivo e dalla motivazione circa l’esatta estensione dell’obbligo configurato nella sentenza, può procedere all’integrazione extratestuale, a condizione che i dati di riferimento siano stati acquisiti al processo in cui il titolo giudiziale risultava essersi formato[148]; questo perché, non appare superfluo ricordarlo, nel processo esecutivo il contraddittorio tra le parti non si atteggia in modo analogo a quello che si instaura nel processo di cognizione, in quanto, da un lato, le attività che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all'accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo e, dall'altro, proprio l'esistenza di un titolo esecutivo impedisce al debitore esecutato di contestare l'azione esecutiva in via di eccezione, come avviene per il convenuto nel giudizio di cognizione, ma gli consente soltanto di avvalersi del rimedio dell’opposizione, come del resto ritiene proprio la S.C.[149]
Saranno sufficienti le osservazioni critiche formulate da tante ed autorevoli voci dottrinali, e gli orientamenti difformi delle sezioni semplici della stessa S.C., per un contro-revirement che permetta al titolo esecutivo di recuperare quella autosufficienza che antica dottrina predicava e difendeva a spada tratta[150]?
Invero, allo stato la situazione si rivela di certo problematica, e non molte appaiono le possibilità di una repentina marcia indietro che consenta di ristabilire gli antichi equilibri, in quanto il richiamato orientamento della S.C. conduce in direzione esattamente opposta, dichiarando apertamente di voler sostituire, al concetto di titolo esecutivo quale normativa autosufficiente, come emergente dai saldi insegnamenti di Salvatore Satta, un concetto di titolo completamente diverso, in sostanza aperto e parimenti debole[151]; un titolo, quindi, che ha bisogno di una etero integrazione per potersi completare e svolgere compiutamente la propria funzione, in spregio alla – peraltro indiscussa, o quasi – autonomia e separazione tra cognizione ed esecuzione.
Sembra emergere allora, da tale prospettazione delle Sezioni Unite, una nozione di titolo esecutivo che si presenta quasi – si perdoni il paragone forse provocatorio ma che non pare non fuori luogo - come una sorta di fattispecie a formazione progressiva, ed ecco quindi che la Suprema Corte ci propone[152] il concetto di titolo esecutivo quale work in progress, quindi un titolo, come definito da una dottrina innanzi richiamata, aperto ad una integrazione sostanzialmente bidirezionale, in quanto proveniente sia dal passato, cioè dal materiale istruttorio raccolto nel corso del procedimento che ha visto la sua conclusione con il titolo in questione, sia anche, in pratica, anche dal futuro (rispetto al titolo ed al momento temporale di sua emanazione) per effetto di un atto ad esso successivo nonché formato unilateralmente dal creditore, quale appunto l'atto di precetto.[153]
Il che, invero, se per un verso appare(ed è, senza dubbio) inaccettabile, e suscita critiche e levate di scudi da più parti, dall’altro si mostra – non che tanto posso giustificarlo, è ovvio - singolarmente, ma anche pericolosamente, coerente con la condizione di eterno cantiere in cui versa, da oltre venti anni ormai, il processo civile in Italia, per cui non viene altro da pensare - visto il tenore e spessore delle ultime riforme legislative nonché dei più recenti orientamenti nomofilattici della S.C.[154] - che (non solo) mala tempora currunt, sed peiora parantur.
[1] Alle quali l'efficacia esecutiva è riconosciuta dalla Legge che le disciplina (art. 63 del R.D. 14.12.1933 n. 1669) al pari di quanto previsto per gli assegni (art. 55 R.D. 21.12.1933 n. 1736), sempre che siano in regola con il bollo.
[2] Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2005, n. 15219, in Foro it., Mass., 2005, 1234.
[3] Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2005, n. 15219, cit.
[4] Dal primo versante, si segnala la sentenza 17 giugno 1999 della Corte di Giustizia CEE, in relazione al procedimento C-260/97, in Giust. civ., 1999, I, 3209, la quale ha affermato “Il titolo di credito esecutivo secondo il diritto dello stato d’origine, la cui autenticità non sia stata attestata da autorità pubblica o da altra autorità a ciò legittimata da tale stato, non costituisce atto autentico ai sensi dell’art. 50 della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del regno di Danimarca, dell’Irlanda e del regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della repubblica ellenica”; dal secondo punto di vista, va segnalato il Regolamento (CE) n. 805/2004 che, con l'istituire il c.d titolo esecutivo europeo, all'art. 3 ha previsto che I titoli esecutivi che possono essere certificati come titoli esecutivi europei sono : i)le decisioni giudiziarie; ii) le transazioni giudiziarie; iii) gli atti pubblici relativi a crediti non contestati, prevedendo un elenco dal quale, come appare evidente, risulta esclusa la scrittura privata.
[5] Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2012, n. 4376, in Riv. esecuzione forzata, 2012, 370.
[6] Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2011, n. 9373, in Famiglia e diritto, 2011, 877.
[7] Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2012, n. 4376, cit.
[8]Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 20 dicembre 2012, L 351/1, ed entrato in vigore il 1o gennaio 2015.
[9] D’Alessandro E., Il titolo esecutivo europeo nel sistema del regolamento 1215/2012, in Riv. dir. proc., 2013, 4-5, 1044.
[10] Mandrioli C., L’azione esecutiva, Milano, 1955, p. 327; Zucconi Galli Fonseca E., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, p. 67 e ss.; Mazzarella F, Tesoriere G., Guida al processo civile riformato, Padova, 2013, p. 427.
[11] Arieta G., De Santis F., Montesano L., Corso di diritto processuale civile, Padova, 2010, p. 770 e ss.
[12] Mandrioli C., Corso di diritto processuale civile, Torino, 1978, III, p. 31 e ss.
[13] In questi termini, Castoro P., Il processo di esecuzione nei suoi aspetti pratici, Milano, 2002, p. 7 e ss.
[14] Capponi B., Autonomia, astrattezza e certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza? in Corriere giur., 2012,1169.
[15] Liebman E. T., Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione, Roma, 1931, p. 128 e ss.
[16] Capponi B., op. loc. cit.
[17] Cass. civ., Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11067, in Foro it., 2012, I, c. 3019.
[18] Capponi B., op. cit., 1171.
[19] Luiso F.P., Diritto processuale civile. Il processo esecutivo, Milano, 2009, p. 21 e ss.
[20] Proto Pisani A., Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2002, p. 709 e ss.
[21]Proto Pisani A ., op. loc. cit.
[22] Delle Donne C., Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., Sez. Un., n. 11067/2012, in Esecuzione forzata, 2013, 1, 4 e ss.
[23] Proto Pisani A., op. loc. cit.
[24]Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2010, n. 15282, in Foro it., Mass., 2010, 719.
[25]Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2010, n. 15282, cit.
[26] Mazzarella F., Tesoriere G., op. loc. cit.
[27] FABIANI E., C'era una volta il titolo esecutivo, in Foro it., 2013, I, 1282 (m), par.I.
[28] LUISO F. P., op. cit., p. 36 e ss.
[29] Trib. Milano, sez. III, 17 maggio 2010, in banca dati Pluris-cedam.utetgiuridica.it., voce obbligazioni e contratti.
[30] Trib. Milano, sez. III, 17 maggio 2010, cit.
[31] Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2000, n. 1337, in Foro it., Rep., 2000, voce Titoli di credito, n. 26 secondo cui il titolo esecutivo, essendo condizione dell’azione esecutiva, deve essere verificato d’ufficio dal giudice, tenuto a dichiararne l’inesistenza, e quindi la nullità del precetto come nel caso che sia costituito da assegno bancario privo di data, perché inidoneo a valere come titolo esecutivo, in difetto di tale elemento.
[32] Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2002, n. 3316, in Foro it., Rep., 2002, voce Sentenza civile, n. 18, che ha stabilito come, nel caso in cui oggetto di contestazione sia la liquidità del credito fatto valere, l’eventuale difetto di titolo esecutivo non può essere rilevato d’ufficio dal giudice.
[33] Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 2004, n. 22430, in Foro it., Rep., 2004, voce Esecuzione civile, n. 49.
[34] Soldi A.M., Manuale dell'esecuzione forzata, Padova, 2012, 50.
[35] Soldi A. M., op. cit., 1159.
[36] Arieta G., De Santis F., L'esecuzione forzata, in Trattato di diritto processuale civile, a cura di Montesano-Arieta, III, 2, Padova, 2007, 1664 e s s.
[37] Trib. Asti, 1 marzo 2013, in IlCaso.It, 2013, I,8646.
[38] Cass. civ., 25 febbraio 1983, n. 1455, in Foro it., Rep., 1983, voce Esecuzione in genere, n.8.
[39] Cass. civ., sez. II, 18 luglio 1997, n. 6611, in Foro it., Rep., 1996, voce Esecuzione in genere, n. 9.
[40] Cass. civ., 18 gennaio 1983, n. 477, in Giust. civ., 1983, I, 1493.
[41] Trib. Roma, 28 luglio 1998, in Dir. Fall., 1999, II, 150.
[42] Conte R., Sull'identificazione e sull'inesistenza del titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata, in Giur.it, 2014, 3, 594.
[43] Trib. Bari, 27 ottobre 2005, in Corti pugliesi, 2006, 930.
[44] Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16610, in Foro it., Mass., 2011, 624.
[45] Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16610, cit.
[46] Trib. T.Ann.ta, 3.5.13, est. dr.ssa Vitulano, in questa Rivista, 2014, I, 10447.
[47] Fabiani E., Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., Sez. Un., n. 11067/2012, in Esecuzione forzata, 2013, 1, 1 e ss, che richiama in senso adesivo quanto affermato, tra gli altri, da Capponi B., op.cit., 1169.
[48] Cass. civ., Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11066, in Riv. Esecuzione forzata, 2012, 355
[49] Per cui risultava incerta l’effettiva erogazione della somma o, quantomeno, la messa a disposizione di essa, con rilevanza giuridica autonoma, in favore del mutuatario.
[50] Cass. civ., 28 giugno 2011, n. 14270, in Giust. Civ., 2013, I, 1194.
[51] Magni F. A., Il mutuo, in Diritto Civile, diretto da N. Lipari e P. Rescigno,coordinato da A. Zoppini, III, Torino, 2009, p. 881.
[52] Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2011, n. 21293, in CED, Cassazione, 2011.
[53] Cass. civ., sez. III, 18 agosto 2011, n. 17349, in CED, Cassazione, 2011.
[54] Cass. civ., Sez. Un., 7 gennaio 2014, n. 61, in Foro it., Rep., 2014, voce Esecuzione in genere, n. 9.
[55] Trib. Latina, 18 maggio 2010, cit.
[56] Cass. civ., 28 giugno 2011, n. 14270, cit.
[57] Cass. civ., sez. I, 8 marzo 1999, n. 1945, in Foro it., Rep., 1999, voce Mutuo, n. 11.
[58] Cass. civ., 19 luglio 1979, n. 4293, in Banca, borsa, tit. cred., 1981, II, 5.
[59] Trib. Napoli, sez. V^bis, 20 giugno 2012, in www.giuffrè.it, addenda online, giurisprudenza di merito, 4/2013.
[60] Sacco R., Il contratto, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F. Vassalli, Torino, 1975, p. 613.
[61] Giampiccolo G., voce Mutuo, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1977, p. 447 e ss,
[62] Cass. civ., Sez. Un., 21 giugno 2005, n. 13294, in Foro it., 2006, I, 2423.
[63] Cass. civ., Sez. Un., 21 giugno 2005, n. 13294, cit.
[64] Cass. civ., Sez. Un., 21 giugno 2005, n. 13294, cit.
[65] Cass. civ., Sez. Un., 21 giugno 2005, n. 13294, cit.
[66] Sangiovanni V., Contratto di mutuo e consegna del bene, in I contratti, 2010, 11, 981 e ss.
[67] Sangiovanni V., op. loc. cit.
[68] App. Firenze, 24 marzo 1994, in Gius., 1994, 15, 79.
[69] Trib. Latina, 18 maggio 2010, in IlCaso.it., 2010, I, 2240.
[70] Trib. Latina, 18 maggio 2010, cit.
[71] Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2001, n. 9074, in Foro it., Rep., 2001, voce Mutuo, n. 36.
[72] Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2483, in Foro it., Rep., 2001, voce Mutuo, n. 37.
[73] Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2483, cit.
[74] Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2011, n. 14, in Foro it., Mass., 2011, 1.
[75] Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 1992, n. 11116, in Corriere giur., 1992, 1329.
[76] Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 2004, n. 3642, in Riv. Not., 2005, 583.
[77] Cass. civ., 8 marzo 1977, n. 950, in Giust. Civ., 1977, I, 1208.
[78] Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 2004, n. 3642, cit.
[79] Mastropaolo F., I contratti reali, in Trattato di Diritto Civile, diretto da R. Sacco, Torino, 1999, p. 400 e ss.
[80] Mastropaolo F., op. loc. cit.
[81] Capotorto M., Utilizzo strumentale del contratto di mutuo per estinguere debiti preesistenti tra le parti, in Nuova Giur. Civ., 2013, 12, 1070.
[82] Forchielli P., I contratti reali, Milano, 1952, 55 e ss.
[83] Benedetti A. M., Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto tra legge e volontà delle parti, Torino, 2002, 248.
[84] Benedetti A. M., op. loc. cit.
[85] BENEDETTI A.M., op. cit., 249.
[86] Sangiovanni V., Brevi note sull'erogazione del danaro nel mutuo, in Corriere giuridico, 2012, 1, 138.
[87] Sangiovanni V., op. loc. cit.
[88] Teti R., Il mutuo, in Trattato di Diritto Privato, diretto da Pietro Rescigno,XII, Torino, 1992, p.671.
[89] TETI R., op. loc. cit.
[90] Natoli U., I contratti reali. Appunti delle lezioni, Milano, 1975, p. 96.
[91]Cass. civ, sez. I, 24 aprile 1997, n. 3618, in Vita Not., 1997, 760.
[92] Fragali P., Del mutuo, in Commentario al Codice Civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 312 e ss.
[93] Fragali P., op. loc. cit.
[94] Di Gravio V., Teoria del contratto reale e promessa di mutuo, Milano, 1989, p. 83.
[95] Soldi A. M., Opposizione a precetto e all'esecuzione, p. 20, in http://astra.csm.it/incontri/relaz/24753.pdf.
[96] Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2003, n. 9101, in Foro it., 2003, I, c. 2646.
[97] Trib. Latina, 18 maggio 2010, cit.
[98] Cass. civ., Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11067, in Ammin.it, 2012, 1166.
[99] Cass. civ., sez. lav., 21 novembre 2006, n. 24649, in Foro it., Mass., 2006, 1979; conforme, Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 2009, n. 9693, in Foro it., Rep., 2009, voce Esecuzione in genere, n. 35.
[100] Cass. civ., Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11067, cit.
[101] Cass. civ., Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11067, cit.
[102] Cass. civ., Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11067, cit.
[103] Belle’ R., Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., Sez. Un., n. 11067/2012, in Esecuzione forzata, 2013, 1, 2 e ss.
[104] Belle’ R., op. loc. cit.
[105] Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6111, in Foro it., Mass., 2013, 183.
[106] Cass. civ., sez. III, 16 aprile 2013, n. 9161, in Riv. esecuzione forzata, 2013, 477.
[107] Belle’ R., op. cit., p. 3.
[108] Belle’ R., op. loc. cit.
[109] Cass. civ., sez. III, 22 marzo 1996, n. 2510, in Foro it., Rep., 1996, voce Esecuzione di obblighi di fare, n. 2.
[110] Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2012, n. 3722, in Foro it., Mass., 2012, 216.
[111] Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2012, n. 3722, cit.
[112] Cass. civ., sez. III, 29 agosto 2013, n. 19877, in Foro it., Mass., 2013, 621.
[113] Gentile S., L'esecuzione forzata del titolo giudiziale non numerario, in Foro it., 2012, I, 3019, par. X.
[114] Gentile S., op. loc. cit.
[115] Capponi B., op. cit., 1176.
[116] Cass. civ., sez. lav., 31 maggio 2013, n. 13811, in Foro it., Rep., 2013, voce Esecuzione in genere, n. 54.
[117] Liebman E. T., op. cit., p. 150 e ss.
[118] Zucconi Galli Fonseca E., Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012, in Esecuzione forzata, 2013, 1, 4.
[119] Zucconi Galli Fonseca E., op. cit., 5.
[120] Capponi B., op. loc. cit.,
[121] Pilloni M., Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012, in Esecuzione forzata, 2013, 1, 2.
[122] Zucconi Galli Fonseca E., op. cit., 2.
[123] Soldi A.M., op. loc. ult. cit.
[124] Soldi A.M., op. ult. cit., p. 32.
[125] Capponi B., op. cit., 1177.
[126] Fabiani E., op. ult. cit., p. 3.
[127] Fabiani E., op. loc. ult. cit.
[128] Capponi B., op. cit., 1176.
[129] Capponi B., op. loc. cit.
[130] Capponi B., op. loc. cit.
[131] Zucconi Galli Fonseca E ., op. cit., 2.
[132] Capponi B., op. loc. cit., 1177.
[133] Capponi B., op. loc. cit.
[134] Fabiani E., op. ult. cit., p.5.
[135] Capponi B., op. cit., 1176 e ss.
[136] Mandrioli C., Carratta A. , Corso di diritto processuale civile, Torino, 2013, IV, p. 8 e ss.
[137] Mandrioli C., Carratta A., op. loc. cit.
[138] Mandrioli C., Carratta A., op. loc. cit.
[139] Zucconi Galli Fonseca E ., op. cit., 5.
[140] Zucconi Galli Fonseca E., op. loc. cit.
[141] In quanto mossa da una comprensibile preoccupazione di assicurare comunque una effettiva tutela ed attuazione al diritto sostanziale che viene accertato nel processo di cognizione.
[142] Ovvero alcune modifiche legislative la cui natura estremamente settoriale e specifica non pare in grado di far ritenere introdotto nell'ordinamento, loro tramite, un principio avente carattere generale, come tale suscettibile di estensione applicativa al di fuori dei singoli e specifici settori ordinamentali in cui è stato previsto.
[143] Delle Donne C., op. loc. cit.
[144] Delle Donne C.., op. loc. cit.
[145] Sassani B., Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012, in Esecuzione forzata, 2013, 1, 3.
[146] Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2013, n. 8576, in Foro it., Mass., 2013, 281.
[147] Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2013, n. 8576, cit.
[148] Cass. civ., Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11067, cit.
[149] Cass. civ., sez. III, 2 novembre 2010, n. 22279, in CED, Cassazione, 2010.
[150] Uno per tutti, Salvatore Satta.
[151] Sassani B., op. loc. cit.
[152] Rectius, impone.
[153] Sassani B., op. loc. cit.
[154] Di cui quello palesato dalla Sentenza n. 11067/2012 costituisce un calzante esempio in malam partem
Scarica Articolo PDF