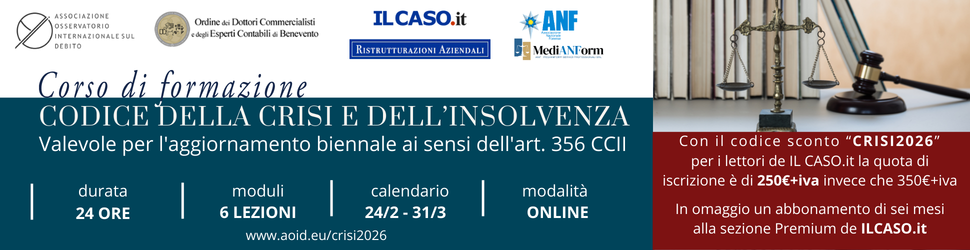Civile
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 01/08/2015 Scarica PDF
I nuovi profili della clausola di diseredazione
Lodovica De Stefano, NotaioSommario: 1. Significato del termine “diseredazione”; 2. Il problema della validità di una scheda testamentaria contenente soltanto la clausola di “diseredazione” di un successore non necessario; 2.1. la tesi dell’inammissibilità della clausola di diseredazione; 2.2. La tesi della validità della disposizione che impedisce la vocazione ex lege dell’escluso; 2.3. La tesi della c.d. istituzione implicita; 2.4. Il mutamento di opinione da parte della Cassazione sulla clausola di diseredazione meramente negativa; 3. Problemi interpretativi relativi alla clausola di “diseredazione” e disciplina applicabile; 3.1. La questione dell’operatività della rappresentazione a favore dei discendenti dell’escluso; 4. La diseredazione dei legittimari; 5. Considerazioni conclusive.
1. La “diseredazione”
La tematica della diseredazione è tornata di attualità a seguito di una recente sentenza della Corte di Cassazione[1], dirompente rispetto al passato, che, essendosi distaccata dagli orientamenti precedentemente sostenuti, consente una lettura in chiave moderna della clausola che estromette uno dei chiamati dalla successione. Il punto nodale, da sempre discusso, concerne la valutazione giuridica della manifestazione di volontà di esclusione di taluno dalla successione il cui tema coinvolge, solo per la sua definizione, molti e complessi argomenti di diritto successorio ai quali il presente studio può soltanto accennare e comunque nei limiti in cui le soluzioni accolte siano propedeutiche alla soluzione dei problemi posti dalla clausola di diseredazione[2].
Al fine di comprendere le principali questioni sottese all’istituto è necessario, anzitutto, chiarire il significato della parola utilizzata per descrivere tale fenomeno giuridico e, quindi, iniziare con l’osservazione che il termine diseredazione costituisce, nella lingua italiana, l’omologo del sostantivo latino exheredatio[3].
Il diritto romano prevedeva, oltre all’indegnità, anche la diseredazione, la quale conferiva al pater familias il potere di escludere dalla propria successione gli heredes sui. Il fatto che la diseredazione, nel diritto romano, fosse limitata agli heredes sui (dai quali discendono, molto approssimativamente, i legittimari del nostro sistema giuridico) e che essa fosse considerata superflua per gli eredi legittimi, cioè coloro che non fossero sui, trova spiegazione nel fatto che in epoca romana il testamento doveva contenere, obbligatoriamente, l’istituzione di erede. Qualora fosse stato istituito un soggetto estraneo alla famiglia, occorreva anche una espressa exheredatio del suus heres, in quanto la sua semplice preterizione era causa di nullità del testamento. Era superflua, invece, la diseredazione degli eredi che non fossero sui. In altri termini, nel diritto romano la diseredazione non era fine a se stessa, ma serviva ad attribuire efficacia all’istituzione di un erede diverso dagli heredes sui, privandolo così della qualifica di erede che possedeva per legge[4].
Tuttavia anche nel diritto romano, con l’evolversi della morale, si cominciò a ritenere ingiusto che il testatore potesse arbitrariamente escludere taluno dalla successione che per legge vi era chiamato. Nella prassi dei Tribunali centumvirali si iniziarono a dichiarare illegittime le diseredazioni non sorrette da una causa adeguata. Successivamente, con la Novella 115 del 542, Giustiniano codificò il principio secondo il quale per escludere un successibile non bastava più la sola diseredazione espressa ma occorreva anche indicare il motivo dell’esclusione. Si introdussero così delle cause di diseredazione tassative, che rimasero anche nel diritto intermedio.
Fu il code Napoléon ad abolire l’istituto della diseredazione testamentaria, lasciando solo l’indegnità quale causa di esclusione a succedere. Le ragioni di questa scelta, stante i lavori preparatori, derivano da valutazioni di natura morale relativi al dovere familiare verso i prossimi congiunti, e dal ritenuto assorbimento di tale figura nell’istituto dell’indegnità. L’istituto riappare con il Codice Albertino il quale, oltre a prevedere l’indegnità ipso iure per le violazioni più gravi, permette al testatore di escludere di taluno dalla propria successione[5].
Nonostante molti odierni ordinamenti di civil law prevedono la diseredazione[6], in Italia essa trovò il suo epilogo nel codice del 1865[7]. La sua esclusione, però, ha aperto il dibattito dottrinario e giurisprudenziale della ammissibilità, all’interno della autonomia testamentaria, di una clausola volta ad escludere taluno dalla propria successione da risolversi in base ai principi generali che regolano le successioni e le disposizioni testamentarie[8].
Prima di discorre dell’ammissibilità della clausola di diseredazione, va, in primo luogo, chiarito quale accezione debba essere oggi attribuita all’espressione “diseredazione” e, più precisamente, quale sia l’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto[9]. Secondo Coviello, infatti, esisterebbero due specie di diseredazione: una, oggi non più ammessa, che colpisce i legittimari; l’altra, lecita, escluderebbe solo gli altri parenti.
Il termine diseredazione, inoltre, è a volte utilizzato quale sinonimo di preterizione: il preterito è escluso dalla successione per il fatto che altri sono stati istituiti eredi al posto suo. La ricomprensione della preterizione nel concetto di diseredazione non è però utile al fine di chiarire la stessa, in quanto con la preterizione l’esclusione dalla successione è solo indiretta ed eventuale. Si opta così per una concezione più tecnica che concepisce la diseredazione solo come l’espressa dichiarazione che taluno non debba essere chiamato erede. La diseredazione quindi discende in via diretta da una espressa volontà testamentaria[10].
Secondo altra tesi, l’espressione, in senso tecnico, sarebbe riferibile esclusivamente ai soggetti che hanno diritto a una quota di riserva del patrimonio del defunto e quindi, nel nostro ordinamento, ai soli successori necessari, ossia i soggetti elencati nell’art. 536 cod. civ. che, come è noto, hanno per legge diritti nella successione[11]. Quindi, stante il principio di intangibilità della legittima (artt. 457, comma 3, e 549 cod. civ.), si dovrebbe concludere, già solo per questa considerazione, per l’inammissibilità, nel nostro sistema giuridico, di una diseredazione in senso tecnico[12]. La principale argomentazione a favore di tale tesi si fonda su ragioni storiche: il diritto romano classico, come si è visto, ammettendo la exheredatio degli heredes sui, riconosceva al testatore la facoltà di escludere dalla successione coloro che ne avessero diritto. Dal momento che, nel nostro ordinamento, soltanto i successori necessari hanno diritto a una quota dell’asse ereditario, non sarebbe corretto parlare di diseredazione relativamente ai successibili ex lege (non legittimari), essendo questi ultimi privi di ogni diritto concreto sull’eredità, ma titolari solo di una aspettativa. Sarebbe ammissibile, invece, una clausola con la quale il testatore si limitasse a escludere dall’eredità alcuni successori ab intestato, potendo disporre a suo piacimento della quota disponibile. Dal punto di vista giuridico, quindi, sarebbe più corretto qualificare la disposizione testamentaria in esame come «clausola di esclusione di eredi legittimi (non legittimari)» anziché come “diseredazione”[13].
Nonostante l’autorevolezza della tesi appena esposta, prevale, in dottrina e in giurisprudenza, un diverso orientamento[14], per il quale, stante il principio di intangibilità della quota di riserva, il testatore non potrebbe manifestare la volontà (negativa) di escludere dalla successione un legittimario. Quest’ultimo, ove pretermesso, potrebbe sempre agire in riduzione per ottenere quanto gli spetta per legge e l’unico strumento a favore del de cuius per escluderlo dalla successione sarebbe il legato in sostituzione di legittima ex art. 551 cod. civ. In conclusione, anche se la “diseredazione” vera e propria sarebbe riferibile soltanto ai legittimari, oggi se ne potrebbe parlare con un campo di operatività più ristretto di quello che aveva nel diritto romano: potrebbe riferirsi solo all’esclusione, dalla delazione ab intestato, di un successore non necessario.
L’espressione “diseredazione” sarà, quindi, utilizzata, nel prosieguo della trattazione, per indicare la clausola che consente al testatore di paralizzare, in sede di successione legittima, la chiamata ereditaria di uno tra i soggetti virtualmente designati dalla legge, purché non legittimario.
In secondo luogo, sia il codice civile del 1865, sia quello vigente, pur non prevedendo la diseredazione, conoscono l’istituto della indegnità. Indegnità e diseredazione sono, tuttavia, istituti tra loro profondamente diversi. L’indegnità, senza volersi addentrare nei suoi profili problematici, è una sanzione civile con fondamento pubblicistico, che comporta, una volta accertata, l’esclusione del chiamato alla successione. Il suo fondamento è oggettivo: non risiede tanto nella presunta volontà del de cuius, quanto nella riprovazione sociale dell’atto commesso dall’indegno. La clausola di diseredazione, invece, rappresenta una sanzione civile di fonte privata e si fonda esclusivamente sulla volontà del testatore: essa consiste nell’espressa dichiarazione da parte del de cuius di voler escludere taluno dalla propria successione. In altri termini, tramite la diseredazione si vuole raggiungere il risultato di impedire, con l’apertura della successione, la chiamata ereditaria[15].
Si deve infine considerare che, anche ove ammessa, la facoltà di diseredazione non è priva di limiti: l’autonomia privata non può arrivare al punto tale da consentire al testatore di diseredare tutti i potenziali eredi legittimi, compreso lo Stato. Una tale disposizione sarebbe nulla, in quanto in contrasto con l’interesse pubblico, sotteso alla disciplina della successione mortis causa, volto a garantire, in ogni caso, la continuità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius. Qualora, invece, essa si riferisse a tutti i successori ab intestato, senza fare menzione dello Stato, potrebbe essere interpretata come un’implicita istituzione a favore di quest’ultimo[16].
Resta aperta l’ulteriore questione, che sarà trattata alla fine del presente lavoro, relativa alle conseguenze giuridiche di una disposizione testamentaria diretta a escludere un legittimario dalla successione.
2. Il problema della validità di una scheda testamentaria contenente soltanto la clausola di “diseredazione” di un successore non necessario
La clausola di esclusione dalla successione di un erede non legittimario, come accennato, non trova una disciplina positiva nel nostro ordinamento ponendosi quindi il problema della sua ammissibilità ed efficacia quale espressione di autonomia privata[17].
In particolare, occorre stabilire se e in quale modo il testatore possa ottenere il risultato di escludere un determinato soggetto dalla propria successione. La dottrina e la giurisprudenza hanno individuato tre diverse ipotesi, ognuna delle quali presenta caratteristiche proprie e pone all’attenzione dell’interprete diverse problematiche[18].
La prima non comporta diseredazione ma solo preterizione[19]: il testatore, attraverso istituzioni di erede e/o legati, dispone di tutte le proprie sostanze a favore di altri soggetti, senza fare alcuna menzione di colui che intende escludere. Come è evidente, in questo caso l’esclusione dalla successione è una conseguenza indiretta delle disposizioni mortis causa: mediante l’attribuzione di tutti i beni ad altri soggetti, la persona non menzionata risulta essere, di fatto, esclusa dalla successione. Un tale testamento è pienamente ammissibile, ma va notato che la preterizione non possiede quella certezza di estromissione dalla successione propria della diseredazione: in caso di mancata accettazione da parte di uno dei chiamati, il pretermesso, salvo che operino i meccanismi della rappresentazione e dell’accrescimento, può sempre venire chiamato ex lege. Al fine di evitare ciò, è necessario prevedere delle sostituzioni (c.d. a catena) per il caso in cui l’erede o gli eredi istituiti non possano o non vogliano accettare l’eredità. L’ultima delle sostituzioni dovrà, preferibilmente, essere disposta a favore di un ente pubblico, in modo da ridurre al minimo il rischio di apertura della successione legittima[20]. La diseredazione, invece, ha effetti più drastici: elimina del tutto la chiamata ereditaria, anche nel caso di apertura della successione legittima. La preterizione, come precedentemente osservato, non può però considerarsi diseredazione in senso tecnico, anche se, secondo autorevole dottrina, la diseredazione sarebbe una sorta di pretermissione con effetti più ampi, proprio perché escluderebbe anche le future e potenziali chiamate ereditarie ex lege[21].
La seconda possibilità è che il testatore, in una scheda contenente la chiamata all’eredità di un determinato soggetto, manifesti esplicitamente o implicitamente anche la volontà di diseredare un successibile ex lege[22]. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, un testamento di questo tipo non creerebbe problemi all’interprete: un negozio mortis causa contenente anche disposizioni attributive di beni, attraverso l’espressa esclusione di un determinato soggetto, avrebbe soltanto la funzione di rafforzare il contenuto positivo delle disposizioni medesime e non integrerebbe una diseredazione in senso tecnico[23]. Secondo la giurisprudenza sarebbe valido anche un testamento che contenga solo una disposizione meramente negativa, dalla quale si può però desumere la volontà implicita di attribuire ad altri il proprio patrimonio[24].
Infine, può accadere che la scheda testamentaria non preveda alcuna disposizione positiva, ma si limiti ad esprimere la sola volontà negativa di escludere dalla successione uno o più potenziali eredi ab intestato. Questa ipotesi è quella che ha suscitato in dottrina e in giurisprudenza i maggiori contrasti, in quanto occorre risolvere il quesito se il testatore, nell’esercizio dell’autonomia privata, possa manifestare una volontà da concretizzarsi in una clausola logicamente e giuridicamente autonoma, svincolata da eventuali disposizioni attributive, diretta esclusivamente a privare della delazione uno o più successibili ex lege (purché, si ripete, non legittimari)[25].
Sulla validità della clausola di diseredazione esistono storicamente due orientamenti contrapposti, che saranno esaminati nel dettaglio nei prossimi paragrafi. La dottrina tradizionale[26] e parte della giurisprudenza, specialmente di legittimità[27], escludono la validità e l’efficacia della clausola si diseredazione. Altra dottrina[28] e parte della giurisprudenza, soprattutto di merito[29], con diverse argomentazioni, manifestano, invece, un atteggiamento di apertura.
La tesi negativa si fonda su molteplici ragioni: la pretesa preminenza della successione legittima rispetto alla successione testamentaria; la configurazione della diseredazione come ulteriore ipotesi di indegnità non prevista dal legislatore; la radicata e diffusa convinzione che il contenuto del testamento debba consistere, necessariamente, nell’attribuzione di beni; l’impossibilità, stante l’assenza di una disciplina legislativa, di ricondurre la diseredazione nell’alveo delle disposizioni testamentarie ex art. 587, comma 2, cod. civ.; ragioni di carattere storico; il convincimento che la clausola de qua, essendo ispirata, nella normalità dei casi, da sentimenti di odio o rancore, non soddisfi interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
La tesi positiva, invece, pur basandosi sulle medesime considerazioni, giunge a risultati opposti: la preminenza della successione testamentariarispetto a quella ab intestato; differenza tra l’istituto della diseredazione e quello dell’indegnità; l’osservazione che il contenuto del testamento non si esaurisce nell’istituzione di erede e nel legato, ma comprende tutte le manifestazioni di volontà, genericamente idonee a regolare post mortem la sorte del patrimonio, comprese quelle aventi contenuto negativo; la considerazione che anche la clausola di esclusione dalla successione può soddisfare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico; l’assenza di limiti di ordine pubblico e di ragioni ostative alla diseredazione; l’evidenza che, stante la pacifica ammissibilità della preterizione, non vi sarebbero ragioni per escludere la validità di un’espressa diseredazione; il potere del testatore, nell’esercizio dell’autonomia negoziale, di inserire nella scheda una clausola che non esprima altro che la volontà di diseredare.
Infine, parte della giurisprudenza, spinta dal proposito di attenuare le conseguenze negative dell’invalidità di un testamento contenente la diseredazione, ha accolto una soluzione di compromesso: pur condividendo le premesse e le conclusioni della teoria negativa, ha escluso la sanzione della nullità nell’ipotesi in cui, dalla clausola di esclusione dalla successione, si possa ricavare, implicitamente, la non equivoca volontà del testatore di istituire eredi i soggetti non esclusi[30]. Come si vedrà, anche questa soluzione, che si fonda su una complessa operazione ermeneutica, ha suscitato dubbi e perplessità, non essendo chiaro se sia ammissibile un’istituzione di erede che non risulti da una dichiarazione scritta di volontà e che lasci un ampio margine di incertezza relativamente alle persone stesse degli istituiti.
2.1. La tesi dell’inammissibilità della clausola di diseredazione
Riassumendo brevemente l’esposizione sopra svolta, dottrina e giurisprudenza sono state chiamate a pronunciarsi sulla validità di un testamento contenente esclusivamente la clausola di diseredazione, essendo pacifico che, accanto alle disposizioni a favore di determinate persone, il testatore possa, esplicitamente, escluderne altre[31]. La questione verte, inoltre, solo sull’esclusione di un successore ab intestato che non sia un legittimario, esulando dai confini della presente trattazione, per il momento, l’ulteriore problematica relativa alle conseguenze giuridiche di una disposizione testamentaria che privi un successore necessario dalla quota di riserva. La questione della validità della diseredazione, come accennato, si intreccia con la tematica dell’autonomia testamentaria e dei limiti ad essa posti, occorrendo chiarire se il potere del testatore di regolare post mortem i propri interessi possa spingersi fino al punto di stabilire che la persona indicata non benefici in alcun caso dei suoi beni. Al riguardo, numerosi Autori[32] e alcune pronunce della Cassazione[33] hanno dato al quesito risposta negativa: nonostante l’ampia libertà riconosciuta al testatore, sarebbe inammissibile una disposizione di carattere negativo, che esaurisse l’intero contenuto del testamento[34].
Un primo argomento utilizzato per sostenere che la diseredazione non sarebbe ammissibile risiederebbe nel fatto che la stessa comporterebbe una modificazione, non consentita all’autonomia privata, delle norme della successione legittima: al testatore non sarebbe concesso sostituirsi al legislatore stabilendo norme diverse da quelle dettate dallo stesso, senza che si apra in tutto o in parte la successione testamentaria. L’orientamento in esame si fonda su una peculiare lettura dell’art. 457, comma 2, cod. civ., che considera la disciplina successoria legale come regola e quella testamentaria come l’eccezione[35]. Poiché la successione ab intestato perseguirebbe interessi superiori, le norme che la disciplinano non avrebbero carattere meramente suppletivo, bensì dispositivo; in altri termini, le norme sulla successione legittima non troverebbero il loro fondamento nella presunta volontà del de cuius, ma sarebbero ispirate a fini di utilità sociale: il dovere morale o sociale dell’individuo nei confronti della famiglia[36]. Qualunque modifica del regolamento legale di successione sarebbe subordinata all’esistenza di un valido testamento, contenente disposizioni attributive: soltanto disponendo dei propri beni il testatore potrebbe pervenire a un risultato diverso o contrario rispetto a quello previsto dalla successione ab intestato. Inoltre non sarebbe efficace un testamento diretto esclusivamente a modificare o a escludere l’applicazione delle norme sulla successione legittima.
In conclusione, un atto di ultima volontà, il quale contenesse esclusivamente la clausola di diseredazione di un potenziale erede legittimo, sarebbe invalido, in quanto non sarebbe ipotizzabile un’unica chiamata scaturente da due distinte volontà, quella negativa del testatore e quella positiva del legislatore, in quanto ciò significherebbe contemplare un tertium genus di successione, che determinerebbe una devoluzione del patrimonio ereditario difforme tanto dalla volontà del de cuius, quanto da quella della legge. In tal senso si è pronunciata la Corte di Appello di Catania[37], che ha escluso l’ammissibilità di una chiamata all’eredità “mista”, ovvero frutto della combinazione delle diverse e divergenti volontà del testatore e della legge, anche per le conseguenze che potrebbero derivarne. Il significato dell’art. 457, secondo comma, cod. civ., è quello secondo cui la legge può integrare l’incompleta volontà del testatore e non quello che la legge possa completare la volontà del de cuius nell’individuazione dell’erede in modo che esso sia chiamato alla successione sia per testamento che per legge.
In secondo luogo, è stato, altresì, sostenuto che, considerando valida la clausola di diseredazione, si introdurrebbe una causa di indegnità ulteriore a quelle previste tassativamente dalla legge, autorizzando, così, il testatore a creare nuove ipotesi di esclusione dalla successione. In particolare, data la gravità degli effetti giuridici che il legislatore riconnette all’istituto di ordine pubblico disciplinato dagli artt. 463 e ss. del codice civile, apparrebbe ictu oculi evidente come non sia ammissibile un’estensione delle cause di indegnità ad opera dei privati[38]. A sostegno di tale argomentazione, viene invocata un’ulteriore e non meno decisivo ragionamento, fondato su ragioni di carattere storico. Nel corso dei secoli, a partire dalla Novella 115 di Giustiniano, la diseredazione, ove prevista, è sempre stata circoscritta a cause gravi, tassativamente indicate dal legislatore. Se si riconoscesse, nonostante il silenzio della legge, validità a tale istituto, si attribuirebbe al testatore il potere di disporre l’esclusione dalla successione senza limite alcuno e, quindi, anche per i motivi più futili e capricciosi[39].
L’invalidità della clausola di diseredazione è stata affermata, inoltre, sulla base di considerazioni riguardanti il contenuto dell’atto di ultima volontà. Tale tesi è stata anche avvalorata da una risalente decisione della Suprema Corte[40]. La premessa maggiore sarebbe data dal rilievo che affinché vi sia successione legittima, è necessario che manchi la successione testamentaria, la quale opera attraverso il negozio unilaterale che è il testamento. La premessa minore consiste in una particolare lettura del contenuto tipico del testamento secondo la quale sembra da escludersi che la scheda testamentaria possa esaurirsi in una clausola di disposizione negativa. Il legislatore, infatti, descrive il negozio mortis causa come l’atto con cui taluno “dispone”, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte o parte delle proprie sostanze (art. 587, primo comma, cod. civ.). In base al secondo comma dell’articolo in esame, il contenuto del testamento può anche essere atipico, e quindi non patrimoniale, purché tale disposizione sia consentita dalla legge: la diseredazione, se letta come disposizione a carattere non patrimoniale in quanto non dispositiva di beni, non potrebbe quindi rientrate in questa categoria, non essendo prevista ed ammessa da alcuna disposizione legislativa[41]. Peraltro, nessuno dubita che la clausola di esclusione sia una diposizione patrimoniale che incide sul patrimonio del de cuius, riducendosi così il problema se essa possa esaurire il contenuto tipico del testamento.
Pur non mettendo in discussione il principio della libera e sovrana libertà del testatore, per i fautori della tesi dell’inammissibilità della diseredazione il termine “disposizione” dovrebbe essere interpretato restrittivamente, nel senso di atto esclusivamente attributivo e non anche privativo a favore di un soggetto determinato. Ciò troverebbe conferma nell’art. 588, primo comma, cod. civ., il quale individua quali strumenti idonei a realizzare un’attribuzione patrimoniale mortis causa solo l’istituzione di erede e il legato[42]. In conclusione, non sarebbero ammissibili le disposizioni a carattere meramente negativo.
La diseredazione non comportando alcuna positiva attribuzione di beni, ma solo una disposizione sul regolamento della successione diverso da quello legale, non sarebbe riconducibile alle suddette figure tipiche e non potrebbe conseguentemente, esaurire il contenuto del testamento. In altri termini, il significato usato dal legislatore non è ricollegabile al concetto di qualsiasi regolamentazione, anche negativa, del patrimonio, cosicché per non inficiare la validità dell’atto di ultima volontà, la clausola in esame dovrebbe necessariamente ricollegarsi a un contenuto positivo dell’atto medesimo[43].
Ulteriore dimostrazione della non ammissibilità della clausola diseredazione si rinviene nella considerazione che la stessa non sarebbe atta a soddisfare interessi meritevoli di tutela poiché risulterebbe ispirata, nella normalità dei casi, da sentimenti di odio, vendetta o livore[44].
A conclusione del discorso, aderendo alla tesi negativa, l’unica tecnica redazionale, consigliata a chi voglia ottenere il risultato di escludere dalla propria successione un potenziale erede ab intestato, sarebbe quella della preterizione.
2.2. La tesi della validità della disposizione che impedisce la vocazione ex lege dell’escluso
Secondo un diverso orientamento, sostenuto da numerosi Autori[45] e da parte della giurisprudenza, soprattutto di merito[46], il testamento, seppur privo di disposizioni attributive e contenente esclusivamente una clausola di diseredazione, sarebbe da considerarsi valido. A favore di questa tesi sono state invocate varie argomentazioni, tutte particolarmente significative[47], prima fra tutte la considerazione che se è vero che la clausola di diseredazione non trova fondamento nella legge, è altrettanto inconfutabile che nessuna norma vieta la diseredazione: essa non contrasta con alcuna norma imperativa né con l’ordine pubblico o il buon costume[48]. A ciò si aggiunge la riflessione, non meno persuasiva, che nulla vieta al testatore di effettuare una preterizione, ossia di disporre dei propri beni, in tutto o in parte, a favore di determinati soggetti, in modo tale da escludere dalla successione uno o più eredi ab intestato. Se si ammette tale facoltà, non si trova la ragione di non consentire al medesimo soggetto il potere di escludere, attraverso un’espressa dichiarazione in tal senso, uno o più successibili[49].
La tesi che ammette la clausola di diseredazione, inoltre, ha confutato tutte le argomentazioni apportate a sostegno della tesi negativa. In particolare, contro l’affermazione secondo la quale la diseredazione non sarebbe ammissibile poiché implicherebbe una modificazione (non consentita) del regolamento legale di successione che presuppone la prevalenza della successione ab intestato rispetto a quella testamentaria, si è osservato che essa si pone in aperto contrasto con il dettato normativo, ai sensi del quale non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi, in tutto o in parte, quella testamentaria (art. 457, secondo comma, cod. civ.). Il favor per la successione testamentaria e la conseguente propensione a conservare il più possibile l’efficacia dell’atto di ultima volontà emergono, infatti, da numerose norme del codice civile, quali la conferma delle disposizioni testamentarie nulle (art. 590 cod. civ.), la cosiddetta regola sabiniana, in forza della quale la condizione illecita o impossibile vitiatur sed non vitiat (art. 634 cod. civ.), la regola in base alla quale l’onere impossibile o illecito si considera non apposto (art. 647, terzo comma, cod. civ.)[50].
Autorevole dottrina afferma che, nel rapporto tra la successione testamentaria e quella legittima, la prima prevarrebbe sulla seconda, poiché se fosse vero il contrario le norme sulla successione ab intestato dovrebbero essere cogenti e non dispositive; secondo tale impostazione, al contrario, le norme della successione ab intestato avrebbero carattere meramente suppletivo, destinate a supplire a un’eventuale mancanza di dichiarazione del privato[51]. Si è fatto notare che il postulato del fondamento della successione legittima nella tutela della famiglia appare improprio: anche a seguito della riforma del diritto di famiglia, la tutela alla stessa riservata è riferibile solo alla famiglia “nucleare” (art. 29 Cost.), e non anche a quella allargata. Sono quindi gli interessi individuali derivanti dal vincolo familiare ad essere tutelati: stabilendo che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (art. 457, terzo comma, cod. civ.), il legislatore sembrerebbe aver individuato, nella tutela dei successori necessari, e non dei successori legittimi, l’unico limite all’autonomia testamentaria[52]. Entro questo limite, pertanto, il de cuius potrebbe sempre derogare alle norme della successione ex lege, esprimendo una valida volontà testamentaria, tanto di contenuto positivo quanto di contenuto negativo[53].
Secondo altri Autori, il preteso contrasto tra il superiore interesse della famiglia, che sarebbe alla base della successione legittima, e gli interessi individuali legati al regolamento testamentario sarebbe, inoltre, più apparente che reale: la successione, qualunque sia la fonte del suo regolamento, trova il suo presupposto nell’interesse, questo sì definibile superiore, che una successione si apra. In altri termini, non sarebbe possibile ragionare in termini di prevalenza di una piuttosto che dell’altra forma di successione: entrambe sarebbero previste a tutela dell’interesse sociale, e di ordine pubblico, che alla morte di un soggetto vi sia un successore, così evitando che i beni diventino res nullius[54]. La clausola di diseredazione, pertanto, non detterebbe disposizioni alternative a quelle della successione ab intestato e la sua funzione sarebbe quella, insieme alle disposizioni che regolano la successione legittima, di determinare le designazioni che, in concreto, regolano il fenomeno successorio[55].
È stata confutata anche l’argomentazione, secondo la quale la clausola di esclusione dalla successione sarebbe invalida in quanto essa si risolverebbe in una causa di indegnità per volontà del testatore, e come tale inammissibile. Tale argomentazione sarebbe viziata da un improprio accostamento tra gli istituti dell’indegnità e della diseredazione, i quali, seppure producano entrambi la perdita dei diritti successori, si differenziano sotto molteplici aspetti, come sopra brevemente analizzato[56].
L’asserita ammissibilità della clausola di diseredazione si basa, inoltre, sulla possibilità di ricomprendere la disposizione de qua nel contenuto del testamento, così come normativamente previsto. L’opinione esposta nel precedente paragrafo che ricostruisce il negozio testamentario con funzione meramente attributiva e che riconduce alle sole attribuzioni realizzate mediante l’istituzione di erede o di legato i possibili contenuti del testamento è apparsa dalla altra dottrina criticabile[57].
La diseredazione – se ammissibile – sarebbe una vera e propria disposizione testamentaria a carattere patrimoniale, attraverso la quale il testatore potrebbe regolamentare l’assetto del suo patrimonio, così modificando la disciplina della successione ab intestato, non soltanto con atti positivi di attribuzione, ma anche con una disposizione di contenuto negativo.
L’orientamento in esame si basa su un’interpretazione più ampia del termine “disporre” di cui all’art. 587, primo comma, cod. civ. In particolare, si ritiene che esso non andrebbe inteso in senso di “attribuire” ma quanto di “regolare”[58]. Il motivo per cui il concetto di “disposizione testamentaria”, secondo tale tesi, non può essere identificato con quello di “attribuzione”[59] sarebbe confermato dalla soppressione, nell’attuale art. 587, primo comma, cod. civ., dell’inciso “in favore di una o più persone”, con il quale si chiudeva il corrispondente art. 759 del Codice Civile del 1865, segnando così l’abbandono della tradizionale concezione attributiva del testamento[60]. La riprova della validità di tale lettura si troverebbe anche nel secondo comma del medesimo articolo, il quale, riferendosi alle “disposizioni di carattere non patrimoniale”, non si riferirebbe ad atti di disposizione di diritti in senso tecnico, bensì a “regole” e “precetti” negoziali[61]. D’altro canto il concetto di disposizione negli atti a causa di morte non può coincidere con il medesimo concetto utilizzato per gli atti tra vivi: in questi ultimi “disporre” significa trasmettere immediatamente il diritto oggetto dell’atto, mentre negli atti mortis causa il medesimo termine deve essere inteso come pianificazione su quella che sarà la situazione del patrimonio in occasione della futura successione[62].
I sostenitori di tale orientamento avvalorano la loro posizione, inoltre, osservando che numerose norme del codice civile contemplano disposizioni testamentarie le quali, pur avendo contenuto patrimoniale, non comportano un’attribuzione in senso tecnico e sono diverse dalle figure tipiche dell’istituzione di erede e del legato. Si riportano quali esempi la modifica dell’ordine di riduzione delle disposizioni testamentarie mediante la preferenza accordata a una di esse (art. 558, secondo comma, cod. civ.), il modus (art. 647 cod. civ.)[63], il divieto testamentario di divisione (art. 713, secondo e terzo comma, cod. civ.), le norme dettate dal testatore per la divisione (cosiddetto assegno divisionale semplice) (art. 733, primo comma, cod. civ.)[64], la dispensa dalla collazione (art. 737 cod. civ.), la deroga al principio della ripartizione dei debiti tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote (art. 752 cod. civ.), la disposizione contraria alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia (art. 1062, secondo comma, cod. civ.), la possibilità di escludere il trasferimento della ditta per i successori mortis causa dell’azienda (art. 2565, terzo comma, cod. civ.)[65].
Alla qualificazione, da parte dei fautori della tesi della inammissibilità della diseredazione, delle ipotesi sopra citate come disposizioni aventi carattere complementare ed accessorio rispetto alla disposizione (principale) attributiva[66], si replica che quest’ultima obiezione non coglie nel segno, in quanto le norme sopra citate hanno, invece, carattere autonomo e indipendente essendo idonee a regolare particolari aspetti della vicenda successoria, che prescinde dalla attribuzione di erede o legatario[67].
Sempre a sostegno di una lettura ampia dell’art. 588, primo comma, cod. civ., viene dedicata un’ulteriore riflessione: la norma, contemplando le disposizioni testamentarie indubbiamente più diffuse e più rilevanti, è nata dell’intento del legislatore di risolvere la questione della distinzione tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare. L’art. 588, primo comma, cod. civ., pertanto, avrebbe una funzione puramente accessoria rispetto alla definizione generale di testamento racchiusa nell’articolo precedente, conseguentemente rendendo tutte le disposizioni patrimoniali di ultima volontà, anche se non identificabili con l’istituzione di erede o con il legato, valido contenuto del testamento purché rispondano al requisito di liceità e di meritevolezza di tutela[68].
Per tale dottrina, state quanto esposto, si deve quindi evincere che il termine “disposizione” deve essere interpretato non nel senso restrittivo di manifestazione di volontà riguardante la disposizione di diritti, ma nel senso più ampio di manifestazione di volontà genericamente idonea a regolare post mortem la sorte del patrimonio. Nel potere di “disporre” dei propri beni per testamento rientrerebbe, pertanto, anche la disposizione con efficacia meramente negativa, quale è la diseredazione volta ad escludere dalla successione chi vi sarebbe altrimenti chiamato: tale disposizione avrà la conseguenza di restringere la chiamata ex lege limitando la cerchia delle persone che avranno diritto alla devoluzione del patrimonio e di rendere applicabili le regole della successione ab intestato come se il diseredato non fosse mai esistito[69].
A conclusione del discorso sul concetto di “disposizione”, si deve osservare infine che, anche qualora si volesse sostenere la funzione esclusivamente attributiva del testamento, la clausola di diseredazione potrebbe, comunque, essere letta come espressione della volontà di “non attribuire”[70]. Infatti è sufficiente che la volizione del testatore, in un atto che abbia forma testamentaria, sia diretta a produrre effetti successori, divenendo irrilevante che detti effetti derivino da un atto confezionato in termini di esclusione piuttosto che di designazione.
La tesi in esame, infine, ritiene ammissibili le disposizioni patrimoniali a carattere meramente negativo, anche sul rilievo che se la revoca espressa delle disposizioni testamentarie è valida anche se non accompagnata dalla manifestazione di una diversa volontà attributiva (art. 680 cod. civ.), conseguentemente, si deve ritenere ammissibile anche un atto di ultima volontà, che si limiti ad escludere un soggetto dalla successione, senza prevedere l’attribuzione di beni ad altri[71].
La maggiore critica a coloro che hanno negato validità alla clausola di diseredazione è riassumibile nella difficoltà di intendere come si possa invocare la pretesa contraddittorietà di carattere logico: sul piano logico, infatti, dispone dei propri beni tanto chi li attribuisce a qualcuno, quanto chi dichiara di non volerli attribuire ad alcuno. In entrambi i casi si tratta di atti di disposizione nascenti dalla manifestazione di volontà del testatore[72].
Accogliendo una nozione ampia di testamento, idonea a comprendere disposizioni dal contenuto più vario, fermo restando il rispetto di regole fondamentali del diritto successorio, prima fra tutte quella relativa all’intangibilità dei diritti dei legittimari (artt. 457, terzo comma, 536 ss. e 549 cod. civ.), l’unico limite all’autonomia testamentaria, libera e sovrana, sarebbe costituito dalla liceità dei motivi sottesi alle disposizioni inserite nella scheda[73]. La diseredazione altro non comporterebbe che consentire al testatore di avvantaggiare soggetti ai quali è affettivamente legato escludendo, al contempo, coloro che, pur essendo legati da un rapporto di parentela, fossero a lui sentimentalmente estranei[74].
Si conclude così per la meritevolezza della clausola di esclusione dalla successione e degli interessi ad essa sottesi[75]: la volontà del testatore potrebbe trovare giustificazione nell’intento di evitare al destinatario le conseguenze negative di una hereditas damnosa o di rendere più consistente l’acquisto dei beneficiari non diseredati[76]. Peraltro non è previsto nel nostro ordinamento, un sindacato sulla bontà dei sentimenti del testatore, cosicché un testamento dettato da sentimenti di collera o di odio è perfettamente valido, salvo che non si provi l’incapacità naturale dell’autore o si accerti l’esistenza di un motivo illecito determinante.
Infine, si deve ricordare la tesi di Corona il quale riconduce la clausola di esclusione dalla successione quale species dell’assegno divisionale semplice indiretto, di cui all’art. 733 del codice civile. Quest’ultima figura ricorre quando il de cuius, nel dettare le norme relative alla ripartizione del suo patrimonio, esclude un erede (testamentario o legittimo) dall’apporzionamento di determinati beni ereditari. Tuttavia, la diseredazione si differenzierebbe dall’assegno divisionale semplice indiretto sotto il profilo quantitativo poiché riguarderebbe non singoli beni ereditari, bensì l’intero patrimonio del disponente: nessun bene dovrebbe essere assegnato al successibile ab intestato indicato[77].
Si osservi che lo stesso Autore, artefice la tesi in esame, si è fatto carico di una critica significativa che potrebbe contestare l’identità tra le due figure: mentre la diseredazione escluderebbe il potenziale erede legittimo dall’intero fenomeno successorio, comprensivo dei rapporti attivi e passivi, l’assegno divisionale indiretto, invece, sembrerebbe incidere soltanto su quelli attivi, con l’assurda conseguenza che il successibile ab intestato, seppure escluso da qualsiasi apporzionamento, potrebbe essere destinatario della delazione ex lege, subentrando nei debiti facenti capo al defunto. L’Autore ritiene che tale obiezione possa essere superata, considerando l’assegno divisionale semplice indiretto come espressione della volontà di escludere tout court dalla propria successione quel determinato soggetto[78].
Per quanto affascinante, la tesi in esame presta il fianco ad un’altra obiezione: l’assegno divisionale semplice, il quale produce effetti meramente obbligatori, non impedisce l’instaurarsi della comunione ereditaria, anzi la presuppone, comunione alla quale non potrebbe, ovviamente, partecipare il diseredato. Inoltre, anche ammettendo che l’escluso partecipasse alla comunione ereditaria e, poi, alla divisione (restando insoddisfatto in sede di apporzionamento), si violerebbe il dettato di cui all’art. 733, primo, cod. civ., in quanto non si avrebbe coincidenza tra il valore dei beni, che nel caso di diseredazione sarebbe nullo, e la corrispondente quota astratta, nella quale dovrebbe ritenersi chiamato il diseredato[79].
Dal punto di vista redazionale, l’accoglimento della tesi dell’ammissibilità della diseredazione non richiede nessun particolare accorgimento: il testatore si limiterà ad effettuare un’autonoma disposizione a contenuto negativo, diretta ad escludere uno o più successibili ex lege dalla devoluzione dell’eredità[80].
2.3. La tesi della c.d. istituzione implicita
Le conclusioni drastiche della tesi che riconosce la natura di disposizione testamentaria alla sola attribuzione di beni, dichiarando inammissibile la clausola di diseredazione, ha spinto la giurisprudenza di legittimità, sulla base del favor testamenti, alla ricerca di una volontà positiva del testatore anche in caso di clausola di diseredazione. Secondo i giudici della Suprema Corte, l’esclusione dalla successione di alcuni chiamati ex lege (purché non legittimari) potrebbe essere interpretata come volontà (implicita) di disporre del patrimonio ereditario a favore degli altri eredi legittimi non diseredati: è la tesi c.d. “diseredazione indiretta”[81].
Secondo la fondamentale Cassazione del 1967 «ai sensi dell’art. 587, comma 1, cod. civ., il testatore può validamente escludere dall’eredità, in modo implicito o esplicito, un erede legittimo, purché non legittimario, a condizione, però, che la scheda testamentaria contenga anche disposizioni positive e cioè rivolte ad attribuire beni ereditari ad altri soggetti, nelle forme dell’istituzione di erede o del legato. È, quindi, nullo il testamento con il quale, senza altre disposizioni, si escluda il detto erede dalla successione, diseredandolo. Peraltro, qualora dall’interpretazione della scheda testamentaria risulti che il de cuius, nel manifestare espressamente la volontà di diseredare un successibile, abbia implicitamente inteso attribuire, nel contempo, le proprie sostanze ad altri soggetti, il testamento deve essere ritenuto valido, contenendo una vera e propria valida disposizione positiva dei beni ereditari, la quale è sufficiente ad attribuire efficacia anche alla disposizione negativa della diseredazione»[82].
L’orientamento giurisprudenziale citato, seguito anche da autorevole dottrina[83], non reputa, quindi, tout court inammissibile la disposizione mortis causa diretta ad escludere dalla successione il potenziale erede ab intestato, ma fonda la validità della disposizione medesima ravvisando nella volontà negativa l’implicita istituzione dei successibili ex lege non esclusi[84]. Per giungere a tale conclusione la Suprema Corte esamina due diverse opinioni contrapposte: la prima, derivante dalla dottrina francese e seguita da parte della dottrina italiana, applica il principio “exclure, c’est instituer” [85], il quale, attraverso il meccanismo della finzione, vede anche nella sola clausola formulata in modo negativo una disposizione positiva implicita a favore degli altri eredi successibili per legge; la seconda, propria della dottrina tradizionale, ritiene che in nessun caso dalla clausola meramente negativa di diseredazione possa trarsi una diposizione positiva in quanto l’elemento essenziale del testamento rappresentato dalla istituzione di erede non si è tradotto in una dichiarazione documentata nella forma testamentaria. Ad avviso dei giudici della Suprema Corte le due tesi esposte non possono accettarsi: non la prima, in quanto si risolve in un evidente artificio che trasforma la disposizione meramente negativa in diposizione positiva a favore di altri, nemmeno implicitamente o indirettamente nominati, ed in quanto è contro i principi fondamentali in materia di vocazione testamentaria parlare di volontà semplicemente presunta; non la seconda, in quanto contrasta con l’altro principio fondamentale, applicabile a tutto il diritto testamentario, secondo cui la formalità del testamento e delle disposizioni testamentarie non significa necessità di formule sacramentali, ma significa solo che la volontà del testatore deve risultare dal testamento sia in modo diretto ed esplicito, sia in modo indiretto ed implicito, nel senso che è sufficiente che, attraverso interpretazione secondo le normali regole ermeneutiche, dalla scheda risulti in modo inequivoco la sussistenza di una certa volontà del testatore in un determinato senso.
La Suprema Corte conclude così per una tesi intermedia secondo la quale tutto si risolve nell’interpretazione della volontà testamentaria: anche quando si è in presenza di una clausola di diseredazione, di per sé invalida, l’interprete deve, caso per caso, esaminare, in base alla comuni regole ermeneutiche, se da quella scheda possa risultare la inequivoca volontà del testatore, oltre che di diseredare un determinato successibile, di attribuire le proprie sostanze ad un altro soggetto determinato. In altri termini, in base al principio del favor testamenti, non si potrebbe prescindere dalla ricerca di soluzioni interpretative che tutelino la conservazione della volontà testamentaria: nel dubbio circa l’esistenza o l’inesistenza dell’implicita volontà positiva, il principio di conservazione imporrebbe la scelta della prima soluzione poiché solo questa consentirebbe di affermare la validità della clausola di diseredazione[86].
Pertanto, secondo i fautori dell’orientamento in esame, una clausola di questo tipo potrebbe avere un contenuto meramente negativo soltanto in apparenza, ma nella sostanza, invece, potrebbe avere carattere positivo; si raggiunge così il risultato di salvare la disposizione di diseredazione, senza sottoporre a revisione critica le affermazioni della dottrina tradizionale sul contento del testamento. In particolare, la tesi della istituzione implicita conclude per la validità di un testamento contenente la clausola di esclusione dalla successione, purché contempli al tempo stesso anche disposizioni di tipo attributivo. Il contenuto positivo dell’atto di ultima volontà, anche se non espresso, potendo essere ricavato dall’interprete attraverso un’operazione ermeneutica, sottintenderebbe un’indiretta volontà di istituire gli altri eredi legittimi non esclusi. Di conseguenza, sarebbe valida non soltanto la clausola di diseredazione che si accompagnasse a disposizioni aventi carattere attributivo, ma anche quella che si limitasse ad escludere un soggetto dalla devoluzione dei beni ereditari e che, al contempo, rendesse implicitamente operativa, per la devoluzione di quei beni ad altri, la successione ab intestato.
Poiché tutto si risolve nell’interpretazione della volontà del testatore[87], è necessario appurare se il de cuius, nel dettare l’esclusione di un successibile ex lege, intendesse determinare anche la devoluzione dei propri beni a favore di altri soggetti. La complessa operazione interpretativa deve essere condotta, secondo la giurisprudenza, facendo ricorso alle regole di cui agli artt. 1362 e 1367 cod. civ., dettate in materia di contratto, ma ritenute applicabili, seppure con gli opportuni adattamenti, anche al testamento[88]. Facendo buon uso di siffatti principi, «la volontà di diseredazione di alcuni successibili può valere quale riconoscimento della contestuale volontà di istituzione di tutti gli altri successibili non diseredati solo quando, dallo stesso tenore della manifestazione di volontà o dal tenore complessivo dell’atto che la contiene risulti la esistenza della anzidetta autonomia positiva del dichiarante, con la conseguenza che solo in tal caso è consentito ricercare anche attraverso elementi esterni e diversi dallo scritto contente la dichiarazione di diseredazione l’effettivo contenuto della volontà di istituzione»[89].
Così interpretata, l’esclusione dall’eredità di un successibile ex lege, stante il suo contenuto positivo implicito, verrebbe a configurarsi sia come dichiarazione tacita di volontà sia come dichiarazione per relationem: la designazione degli istituiti sarebbe determinata mediante il rinvio alla disciplina legale della successione legittima, escluso, ovviamente, il soggetto diseredato[90].
Per coloro che accolgono l’orientamento in esame, resta da chiarire se la relatio effettuata con la clausola di diseredazione sia formale oppure sostanziale[91], in quanto, mentre la relatio formale, a patto che rispetti il principio di certezza, è consentita, la relatio sostanziale, implicando un’attività volitiva da parte di un soggetto diverso dal testatore, non è ammessa, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge.
Un’ipotesi peculiare di relatio consiste nel rinvio, ad opera del testatore, alle norme della successione ab intestato per l’individuazione degli eredi o per la determinazione delle quote[92]. Nel caso di diseredazione, la clausola potrebbe quindi essere interpretata come implicita istituzione, mediante rinvio alla legge, dei soggetti non esclusi. Tuttavia solo se la volontà del testatore si formasse autonomamente e se egli fosse pienamente consapevole della disciplina della successione legittima oggetto di rinvio, si avrebbe una relatio formale[93]; si avrebbe, invece, una relatio sostanziale, con conseguenti dubbi di ammissibilità, nell’ipotesi in cui il disponente non conoscesse, al momento della redazione della clausola di diseredazione, il contenuto della disciplina legale richiamata implicitamente per relationem[94].
La tesi in esame ha suscitato numerosi dubbi e perplessità[95], in quanto l’orientamento della Suprema Corte presta il fianco a molteplici obiezioni, «la prima delle quali fondata sullo stesso ricorso alla finzione, di fronte all’infondatezza e all’artificiosità della presunzione di volontà positiva in rapporto all’atteggiamento psicologico concreto del testatore»[96]. Tuttavia non tutte le obiezioni sollevate sono meritevoli di accoglimento. In particolare, non appare decisiva quella che ritiene inefficace una disposizione testamentaria contenente solo un mero rinvio alla legge[97]. La legge, infatti, non richiede, ai fini della validità, che la disposizione testamentaria abbia contenuto diverso rispetto alla successione legittima: rientra tra i poteri del testatore quello di effettuare un rinvio all’ordinamento successorio legale per l’individuazione degli eredi o per la determinazione delle quote, restando in dubbio soltanto se si apra, in tal caso, la successione ab intestato o quella testamentaria[98].
Per quanto concerne le obiezioni più significative, si osserva in primo luogo che “trasformare” una clausola di esclusione meramente negativa in una disposizione positiva a favore di altri soggetti, i quali sono in alcun modo nominati, costituisce un artifizio logico ed interpretativo, contrario ai principi fondamentali in materia di vocazione testamentaria[99]. In altri termini la semplice volontà negativa espressa dal testatore non sottintende necessariamente una volontà positiva: le disposizioni testamentarie salvate dalla Cassazione altro non rilevavano che la sola intenzione di escludere un successibile, senza alcuna ulteriore volontà nascosta. La tesi della istituzione implicita conduce così inevitabilmente alla ricerca di una volontà positiva a tutti i costi, finendo, peraltro, con conformarsi all’orientamento interpretativo fondato sulla massima “exclure, c’est attribuer”, da sempre respinto dalla Suprema Corte sin dal suo più remoto precedente.
Ci si domanda, inoltre, come si possa ritenere valida ed efficace un’istituzione la quale, non risultando da una dichiarazione espressa di volontà, diventa una violazione del principio di cui all’art. 628 cod. civ., caratterizzandosi per un’insanabile incertezza sull’identità degli istituiti[100].
Peraltro, un’attività ermeneutica diretta alla ricerca di un’implicita volontà positiva si pone in contrasto con il normale e concreto atteggiamento psicologico del testatore, diretto esclusivamente a impedire la successione del soggetto diseredato[101], correndosi così il rischio di far discendere dal testamento conseguenze non volute dal testatore, il quale, limitandosi a formulare una disposizione meramente negativa, si è mostrato, verosimilmente, indifferente in ordine alla questione della propria successione, confidando nella legge per la distribuzione dei propri beni tra i soggetti non esclusi. Si deve, inoltre, osservare che, con ogni probabilità, neppure lo stesso disponente, al momento della redazione della scheda, aveva in mente l’identità dei presunti eredi. Vi sono poi dei casi in cui una volontà attributiva non può certamente sussistere: quello in cui il de cuius, dopo aver effettuato la diseredazione, si è riservato di formulare in un momento successivo le disposizioni attributive dei suoi beni; oppure quello in cui egli, dopo aver escluso taluno dalla successione, richiami le disposizioni positive contenute in precedenti testamenti, successivamente revocati o non rinvenuti al momento della sua morte[102].
Infine, occorre rilevare che, se si accogliesse la tesi in esame, gli effetti della clausola di diseredazione dovrebbero venir meno ogniqualvolta l’erede implicitamente istituito non potesse o non volesse accettare l’eredità. Si verificherebbe, in quest’ultimo caso, una situazione paradossale: l’attuazione concreta di una volontà esplicitamente manifestata dal testatore, ossia quella diretta a diseredare un successibile ex lege, sarebbe subordinata alla condizione che l’erede implicitamente istituito fosse in grado di succedere[103]. Quest’ultima obiezione può essere superata soltanto ammettendo che, nonostante il venir meno dell’istituzione implicita, la volontà testamentaria di diseredazione possa sopravvivere. È evidente, tuttavia, che una simile soluzione sarebbe contraddittoria e giuridicamente scorretta[104].
Dal punto di vista redazionale, al fine di eliminare il rischio che non si riesca a provare la volontà attributiva implicita, è consigliabile che il testatore manifesti espressamente la volontà di istituire eredi i soggetti non esclusi[105].
2.4. Il mutamento di opinione da parte della Cassazione sulla clausola di diseredazione meramente negativa
Costituisce sicuramente un importante punto di svolta alla definizione della problematica sin qui esaminata l’ultima sentenza della Corte di Cassazione[106], chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione, la quale, sulla spinta dell’opinione dottrinale da sempre favorevole all’ammissibilità di tale clausola, l’ha giudicata valida, ritenendo così di doversi discostare dal precedente orientamento del Supremo Collegio sul punto[107].
Il precedente indirizzo della Cassazione, come visto, riteneva che il testatore potesse validamente escludere dall’eredità, in modo implicito o esplicito, un erede legittimo, purché non legittimario, a condizione, però, che la scheda testamentaria contenesse disposizioni positive, anche implicite, rivolte ad attribuire beni ereditari ad altri soggetti. Il fondamento delle pronunce del 1967 e del 1994, che riposa su una lettura degli articoli 587 e 588 del codice civile fortemente aderente alla lettera delle norme, viene fortemente criticato dalla Cassazione in esame, la quale, ritenendo di non aderire all’orientamento dei precedenti richiamati, perviene ad una diversa lettura degli artt. 587 e 588 cod. civ., che «deve essere rivista e superata»[108], conformemente all’opinione che ammette la validità della clausola diseredativa meramente negativa.
In particolare, la pronuncia in esame ritiene contraddittorio il punto di arrivo delle precedenti sentenze. Se la clausola di diseredazione meramente negativa è invalida – precisa – non è possibile poi in via interpretativa giungere ad affermarne la salvezza attraverso una implicita istituzione di erede «in favore di soggetti non contemplati ma comunque implicitamente individuabili»[109]. In altri termini è incongruente sancire, da un lato, la validità della clausola di diseredazione, ma, dall’altro, condizionare tale validità, seppur in modo indiretto o implicito, all’esistenza di una volontà del testatore di attribuire le proprie sostanze a un determinato beneficiario.
Partendo da tale affermazione il Collegio, in primo luogo, accoglie la tesi della natura essenzialmente patrimoniale dell’atto di ultima volontà, invalidando la posizione della dottrina tradizionale secondo la quale la disposizione testamentaria tipica debba necessariamente risolversi in funzione attributiva. In secondo luogo, ritiene di contestare l’affermazione relativa alla presunta prevalenza della successione legittima su quella testamentaria, evidenziando che secondo il sistema delineato dal legislatore, l’attribuzione dei beni attribuiti per testamento convive con quella ab intestato, sicché il concorso tra la vocazione legittima e quella testamentaria va ricondotto ad un rapporto di «reciproca integrazione»[110].
Successivamente i giudici osservano che in assenza del dogma della tipicità del contenuto dispositivo-attributivo del testamento, la questione della validità della clausola diseredativa meramente negativa, non avrebbe neppure ragione di porsi[111]. Se è vero infatti che, in ossequio al principio della libertà testamentaria, deve riconoscersi al testatore la facoltà di disporre, in tutto o in parte, dei suoi beni – così escludendo, di fatto, in tutto o in parte, dalla propria successione i suoi eredi legittimi – non si vede quale ostacolo sussista a riconoscergli il potere di escludere, con un’espressa ed apposita dichiarazione in tal senso, uno o più dei suoi congiunti ai quali, nel silenzio, l’eredità sarebbe devoluta per legge[112].
Precisano i giudici di legittimità che escludere dalla successione «equivale non all’assenza di un’idonea manifestazione di volontà, ma ad una specifica manifestazione di volontà, nella quale, rispetto ad una dichiarazione di volere (positiva), muta il contenuto della dichiarazione stessa, che è negativa»[113]. Sulla scorta di queste premesse la Suprema Corte precisa, inoltre, che «la clausola di diseredazione integra un atto dispositivo delle sostanze del testatore, costituendo espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, che può includersi nel contenuto tipico del testamento: il testatore sottraendo dal quadro dei successibili ex lege il diseredato e restringendo la successione legittima ai non diseredati, indirizza la concreta destinazione post mortem del proprio patrimonio»[114].
Aderendo quindi al diverso significato che la dottrina sopra esaminata ha ritenuto di attribuire al termine “dispone” di cui all’art. 587 cod. civ. – da intendersi non già quale sinonimo di “attribuire” bensì di “regolare” – il nuovo indirizzo della Cassazione amplia il contenuto dell’atto di ultima volontà, non più quindi destinato ad accogliere solo una volontà attributiva ed istitutiva, ma destinato ad includere «anche una volontà ablativa e, più esattamente, destituiva»[115]. Per i giudici quindi ogni disposizione patrimoniale di ultima volontà (e la clausola di diseredazione è indubbiamente di tipo patrimoniale), anche se non attributiva e anche se non tipicamente prevista dalla legge può costituire un valido contenuto del negozio testamentario, purché lecito, meritevole di tutela e rispettoso dei diritti dei legittimari[116].
L’affermazione del principio di diritto a cui pervengono i giudici è quindi una inevitabile conseguenza del ragionamento condotto fino a questo punto. Se si riconosce che il contenuto del testamento è anche quello che può sostanziarsi in disposizioni meramente negative, volte ad impedire che vengano alla successione legittima determinati successibili ex lege, e restringendo la successione legittima solo a favore di alcuni di essi, si comprende perché sia «valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili»[117] (non legittimari).
In conclusione i giudici riconoscono, da un lato, che ogni disposizione patrimoniale di ultima volontà, anche se non attributiva e anche se non prevista espressamente dalla legge, può costituire un valido contenuto del testamento, purché rispettosa dei diritti dei legittimari e purché rispondente ai requisiti di liceità e meritevolezza, assolve alla funzione tipica del testamento e, dall’altro, che tale punto d’arrivo risulta essere in linea con l’ampio riconoscimento dato alla libertà e alla sovranità del legislatore.
3. Problemi interpretativi relativi alla clausola di “diseredazione” e disciplina applicabile
Una volta ammessa la validità della clausola di esclusione dalla successione di un potenziale erede ab intestato, si devono anche affrontare i delicati problemi di interpretazione e di disciplina che la medesima pone. La recente sentenza appena ricordata non affronta, infatti, tutta le serie di questioni connesse alla diseredazione.
Analizzando dapprima i problemi interpretativi, in primo luogo, può essere dubbia l’esistenza stessa della diseredazione. Ciò può avviene nel caso in cui si debba stabilire se la disposizione testamentaria negativa costituisca vera e propria esclusione della vocazione ex lege oppure sia meramente confermativa di una volontà di pretermissione. La qualificazione in termini di diseredazione o di pretermissione implica, come già esposto, differenti conseguenze sul piano pratico: mentre il soggetto diseredato è escluso, in ogni caso, dalla successione legittima, quello preterito, invece, conserva la capacità di succedere ab intestato, nell’ipotesi in cui, per una qualsiasi ragione, la delazione testamentaria prevista non vada a buon fine. Le espressioni usate in concreto dal de cuius possono essere interpretate, a seconda dei casi, come vere e proprie clausole di diseredazione oppure come disposizioni volte a rafforzare, in modo pleonastico, l’omessa chiamata ereditaria di determinati soggetti[118].
Altri problemi interpretativi possono nascere del fatto che la diseredazione non richiedendo formule sacramentali può risultare anche da una dichiarazione implicita. Due le ipotesi da tenere in considerazione: la disposizione condizionale e la revoca di una disposizione attributiva, qualora fatte a favore di un successibile ex lege [119]. Potrebbe ravvisarsi, infatti, un’implicita clausola di diseredazione, condizionata nel primo caso e pura nel secondo. In altri termini, si potrebbe avere diseredazione, nella prima ipotesi, nel caso di mancato avveramento della condizione sospensiva o di avveramento della condizione risolutiva e, nella seconda ipotesi, nel il caso di revoca della disposizione. È evidente che non si darebbe attuazione alla reale volontà del testatore, se il soggetto istituito sotto condizione (sospensiva o risolutiva) o con disposizione poi revocata succedesse ugualmente, in forza di legge. Tutto ciò, naturalmente, varrebbe soltanto se il soggetto interessato, istituito sotto condizione o con disposizione revocata, fosse il primo dell’ordine successorio legale. Qualora, invece, si trattasse di un successibile di grado ulteriore, la soluzione dipenderebbe dall’interpretazione della volontà del testatore. Quest’ultimo, infatti, potrebbe aver voluto, semplicemente, accordare al soggetto istituito sotto condizione sospensiva (o con disposizione poi revocata) la preferenza sui precedenti chiamati ex lege per l’eventualità del verificarsi della condizione, senza alcuna volontà di diseredarlo per il caso di mancato avveramento della condizione medesima o di successiva volontaria revoca.
Tra i problemi interpretativi connessi alla clausola di diseredazione merita di essere approfondito il caso alle disposizioni testamentarie, che attribuiscano a un successibile ex lege una parte soltanto del patrimonio ereditario, senza nulla prevedere relativamente ai beni residui[120]. La questione riguarda l’istituzione pro quota, l’institutio ex re certa ed il legato, occorrendo stabilire se il soggetto, il quale abbia ricevuto, per testamento, soltanto una parte dell’asse ereditario, possa beneficiare della parte restante in base alle regole della successione ab intestato[121]. In presenza di disposizioni di questo tipo, è necessario indagare, per quanto possibile, la reale volontà del testatore, sondando se le sue intenzioni possano permettere che il soggetto istituito possa ancora concorrere, con gli altri successibili, nella ripartizione del residuo o se, invece, egli debba rimanere escluso dalla parte di successione ab intestato. In ogni caso, ove tale indagine non risulti possibile, si deve concludere nel primo senso, in forza del principio di conservazione del negozio ex art. 1367 cod. civ., applicabile anche in materia testamentaria.
Poiché la diseredazione, come dimostrato, non contiene vocazione all’eredità (nemmeno per implicito), occorre risolvere l’ulteriore quesito relativo al titolo della successione, in forza del quale sarebbero chiamati i soggetti non diseredati. A fronte di chi ritiene che si aprirebbe la successione ab intestato[122], vi è chi sostiene, invece, che opererebbe la delazione testamentaria[123].
La clausola di esclusione di alcuni successibili, senza alcun elemento che possa far pensare ad una qualsiasi considerazione degli altri da parte del testatore, il quale anzi potrebbe essere del tutto disinteressato a qualsiasi ulteriore conseguenza oltre quella della esclusione dalla sua successione di determinati soggetti, dovrebbe portare a concludere per la devoluzione secondo la successione legittima. Questa conseguenza è, tuttavia, contrasta da parte della dottrina[124] la quale ha obiettato che, la diseredazione quale atto di disposizione patrimoniale, avrebbe efficacia relativamente all’intero patrimonio, valendo così come esclusione dalla totalità dei beni, così che, avendo il testatore disposto negativamente di tutti i suoi beni, non vi sarebbe spazio per la successione legittima, la quale presuppone che il testatore non ne abbia disposto in tutto o in parte.
È tuttavia facile ribattere che tale obiezione è frutto di quella impostazione che vede il testamento come un atto meramente attributivo di beni e non come un atto di regolamentazione del proprio patrimonio nel momento in cui si è cessato di vivere. Appare così preferibile la tesi di chi sostiene che in caso di testamento avente contenuto meramente negativo, si faccia luogo alla successione legittima; più in particolare, mentre per il diseredato la sua posizione deriva dal testamento, per coloro pervengono alla successione la vocazione avviene per legge, in mancanza di una esplicita manifestazione di volontà del testatore. Soluzione, peraltro, coerente con il sistema vigente nel nostro ordinamento che ammette la coesistenza delle due forme di delazione: si ricorre alla successione legittima tutte le volte che manchi, in tutto o in parte, quella testamentaria e quindi, come nel caso di diseredazione, quando attraverso il testamento non si arrivi a realizzare la completa distribuzione dell’asse ereditario[125].
La differenza tra le due posizioni non è solo teorica ma ha rilevanza pratica, nel caso, magari raro, in cui tra la redazione del testamento e la morte del disponente si verifichi un mutamento del regime legale: se si ritiene che si apra la successione legittima, si applicheranno le nuove norme vigenti al momento dell’apertura della successione; se si ritiene che il titolo della successione sia costituito dal testamento, invece, sarà necessario interpretare la volontà del de cuius, al fine di stabilire se egli intendesse fare riferimento alla normativa in vigore al momento della redazione del testamento (rinvio formale) oppure alla legge vigente al momento della sua morte (rinvio sostanziale). Nel dubbio, sempre in ossequio al principio di conservazione, occorre scegliere l’interpretazione che consenta il raggiungimento del miglior risultato utile, ossia quella che determini l’applicazione della disciplina in vigore al momento dell’apertura della successione[126].
Ritenuta valida la diseredazione, si deve, conseguentemente, applicare ad essa la disciplina delle disposizioni testamentarie in senso proprio[127]; in particolare saranno applicabili norme quali quelle in materia di violenza, dolo ed errore (artt. 624 e 625 cod. civ.), di motivo illecito (art. 626 cod. civ.) e di revocazione (artt. 679 ss. cod. civ.).
Inoltre, sarà possibile effettuare una diseredazione parziale oppure una diseredazione condizionata[128]. Per quanto concerne la disciplina delle condizioni illecite e impossibili (art. 634 cod. civ.), è discusso se essa trovi applicazione anche nel caso in esame: parte della dottrina dà al quesito risposta negativa, affermando che la cosiddetta regola sabiniana, ai sensi della quale la condizione illecita o impossibile si considera come non apposta (vitiatur sed non vitiat), si riferirebbe esclusivamente alle disposizioni attributive di beni[129]. Anche alla luce della recente Cassazione, è preferibile la tesi positiva, poiché non vi sarebbe ragione di escludere che la ratio sottesa all’art. 634 cod. civ., consistente, nell’esigenza di salvaguardare la volontà (irripetibile) del testatore, sia applicabile anche l’ipotesi della diseredazione.
Relativamente alle disposizioni relative all’incapacità di ricevere per testamento (artt. 596 – 599 cod. civ.), è discusso se esse si applichino anche alla clausola di esclusione dalla successione. Più precisamente, ci si domanda se le previsioni codicistiche in esame si riferiscano esclusivamente alle disposizioni aventi contenuto positivo o anche a quelle di contenuto negativo. Se si accogliesse un’interpretazione restrittiva, si potrebbe al testatore la possibilità di aggirare il divieto legale: si disereda un soggetto allo scopo di avvantaggiare, indirettamente, uno dei soggetti incapaci di ricevere. Qualora, invece, si adottasse una lettura estensiva, si dovrebbe concludere, in ogni caso, per l’invalidità della disposizione negativa, a prescindere dall’effettiva intenzione del disponente di beneficiare un incapace di ricevere. È preferibile la tesi intermedia, la quale propone di indagare, caso per caso, l’effettiva volontà del testatore, al fine di stabilire se la clausola di esclusione dalla successione abbia costituito o meno lo strumento per eludere l’applicazione della norma imperativa[130].
Inoltre, la diseredazione può essere impiegata come clausola penale testamentaria, vale a dire come strumento di pressione psicologica per indurre il successibile ex lege all’adempimento di un’obbligazione testamentaria (modus o legato obbligatorio)[131]. La diseredazione può essere utilizzata, infine, come clausola di decadenza, per il caso in cui l’erede o il legatario non accetti, metta in discussione o impugni le diposizioni testamentarie. Al riguardo, occorre rilevare che la diseredazione sarà soggetta agli stessi limiti di validità previsti per la clausola di decadenza in generale: sarà ammissibile se volta a soddisfare interessi meramente privati; sarà da considerarsi invalida qualora leda interessi di ordine pubblico[132].
3.1. La questione dell’operatività della rappresentazione a favore dei discendenti dell’escluso
Altra importante questione, che ha suscitato accesi contrasti in dottrina e in giurisprudenza, è quella relativa all’operatività della rappresentazione a favore dei discendenti del diseredato[133].
La rappresentazione, derogando al principio generale secondo il quale gli effetti della successione si producono soltanto a favore del chiamato, consente che un soggetto (cosiddetto rappresentante), al verificarsi di determinati eventi che impediscono al suo ascendente (c.d. rappresentato) di succedere, subentra, in luogo di quest’ultimo, nella successione ereditaria o nell’acquisto del legato[134].
Secondo una prima tesi, la rappresentazione non opererebbe e, conseguentemente, l’eredità non potrebbe essere devoluta ai discendenti del diseredato. La ragione risiederebbe, da un lato, nel carattere eccezionale della disciplina della rappresentazione e dall’altro nella mancanza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell’operatività della rappresentazione. Quest’ultima, infatti, presuppone una designazione, legittima o testamentaria, di colui che la legge considera rappresentabile, designazione che proprio la clausola di diseredazione farebbe venir meno: se la designazione testamentaria positiva ha efficacia per stirpi, la designazione testamentaria negativa non può che produrre il medesimo effetto in senso opposto, cosicché la mancata designazione si ripercuote su tutto il fenomeno successorio. In altri termini, la diseredazione agirebbe sulla designazione ex lege del successibile diseredato, annullandola: venuto meno il titolo della designazione dell’ascendente escluso, sarebbe inammissibile una successione per rappresentazione del suo discendente[135].
Appare preferibile il diverso orientamento, sostenuto sia in dottrina[136] che in giurisprudenza[137], ai sensi del quale la diseredazione non impedirebbe ai discendenti dell’escluso di succedere per rappresentazione. Si deve osservare, in primo luogo, che l’istituto della rappresentazione si ha allorquando la persona designata (dalla legge o dal testamento) non è in grado di conseguirla o perché tale designazione non si può concretizzare per impossibilità (premorienza o situazioni equiparabili) o per un ostacolo imposto dalla legge (indegnità) o per volontà dello stesso rinunciante. Nel caso di diseredazione, come peraltro avviene per l’indegnità, quello che viene impedito non è la designazione ma la delazione (o chiamata ereditaria). In altri termini l’operatività del meccanismo della rappresentazione si spiega in ragione del fatto che la diseredazione non annulla la designazione, ma si limita a porre un ostacolo all’attuazione concreta del regime legale di successione: la disposizione di carattere negativo, volta ad escludere dalla successione un determinato soggetto, lascia in vita la designazione, ma ne impedisce l’attuarsi pratico[138].
Inoltre, poiché l’art. 467, primo comma, cod. civ. non distingue tra le varie cause di impossibilità di accettazione dell’eredità, non si comprende per quale ragione i discendenti del diseredato non dovrebbero essere chiamati a succedere per rappresentazione, considerato che ciò è pacificamente ammesso per i discendenti dell’indegno[139]. Infine, sotto un profilo generale, va rilevato che la volontà insita nella clausola di diseredazione è riferibile unicamente alla persona che il testatore vuole esclusa dalla successione. Sarebbe privo di qualunque fondamento logico una presunzione che facesse discendere dalla volontà di diseredare anche una volontà implicita di escludere la rappresentazione per i discendenti del diseredato. Solo una espressa volontà in tal senso da parte del de cuius potrebbe escludere l’applicazione dell’istituto della rappresentazione.
Si è però obiettato che, ammettendo la rappresentazione, si finirebbe per ricondurre alla diseredazione conseguenze meno gravi di quelle che comporta la preterizione[140]. Come ha rilevato autorevole dottrina, anche ammettendo che tale obiezione fosse fondata, si potrebbe ribattere che, negando l’operatività della rappresentazione, si finirebbe per ricollegare alla diseredazione conseguenze assai più gravi di quelle che, sotto questo profilo, determina l’indegnità[141].
La diseredazione, pertanto, al pari dell’indegnità, colpisce soltanto il soggetto cui è rivolta e non produce effetti nei confronti dei discendenti del medesimo, i quali possono, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge e in mancanza di una sostituzione disposta dal testatore, succedere per rappresentazione[142]. Il rappresentante, infatti, succedendo iure proprio, è titolare di una posizione autonoma e originaria: su di essa non possono influire le ragioni che hanno reso impossibile la delazione a favore del rappresentato, mancando un vero subingresso nella sua posizione. Il rappresentato, fuori dal fenomeno successorio, è solo da considerarsi un parametro ai fini della determinazione dei diritti spettanti al rappresentante[143]. Così opinando, le ragioni che hanno indotto il de cuius a escludere dalla successione il rappresentato non possono trasmettersi ed influire sulla posizione del rappresentante.
In ogni caso, come sempre, la soluzione migliore è quella che si basa sull’indagine dell’effettiva volontà del testatore e che mira a verificare se questi, nell’escludere taluno dalla successione, abbia avuto o meno l’intenzione di escludere anche i discendenti del diseredato[144]; restando comunque possibile per il testatore escludere espressamente dalla successione anche tutti i discendenti del diseredato[145].
4. La diseredazione dei legittimari
Secondo la dottrina più tradizionale, stante il radicato principio dell’intangibilità della legittima ex art. 457, terzo comma, cod. civ., la diseredazione di un legittimario sarebbe ontologicamente impossibile, giacché in palese contrasto con lo stesso. Occorre quindi domandarsi quale sia la sorte di una clausola testamentaria che diseredi espressamente un legittimario[146].
Secondo una prima tesi la diseredazione dei legittimari sarebbe giuridicamente irrilevante e, di conseguenza, non inficerebbe la validità dell’intera scheda testamentaria, dovrebbe considerarsi come non apposta, in base a un’interpretazione secondo buona fede oggettiva ex art. 1366 cod. civ. Essendo fortemente discussa l’applicabilità, in materia testamentaria, del canone ermeneutico di buona fede, la tesi appena esposta risulta pienamente convincente[147].
Secondo altra parte della dottrina, la posizione del legittimario sarebbe salvaguardata dalla sanzione della nullità. All’interno di quest’ultimo orientamento, gli Autori percorrono due strade differenti: per alcuni si tratta di nullità ex art. 1418, primo comma, cod. civ. (c.d. nullità virtuale) per violazione dei principi fondamentali del diritto positivo, stante il carattere inderogabile della successione testamentaria[148]; per altri la nullità nasce dalla violazione del disposto di cui all’art. 549 cod. civ., che vieta al testatore l’imposizione di pesi e condizioni sulla quota spettante ai legittimari[149].
Ragionando sulle argomentazioni delle tesi che sostengono la nullità della clausola, nessuna delle due ricostruzioni sembra convincere appieno. Rispetto alla sostenuta nullità per violazione del divieto di imporre pesi e/o condizioni sulla quota di legittima, si esprimono non poche perplessità: non si vede come l’esclusione di un legittimario possa essere assimilato a un peso ai sensi dell’art. 549 cod. civ., norma che per la sua applicazione, peraltro, presuppone delle attribuzioni positive[150].
D’altro canto, l’orientamento che sostiene la nullità virtuale parte da un assunto non del tutto pacifico: la cogenza delle norme relative alla successione necessaria[151]. Inoltre, anche ammessa la natura imperativa di dette norme, come peraltro evidenziato già da autorevole dottrina, dalla diseredazione dei legittimari non deriverebbe necessariamente la nullità della disposizione, in quanto l’art. 1418, primo comma, cod. civ. prescrive la nullità, salvo che la legge non disponga diversamente: e proprio il principio di cui all’ art. 457, secondo comma, cod. civ., secondo cui non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria, sostituirebbe la nullità con la sanzione minore di «una semplice impugnativa negoziale»[152]. L’inderogabilità delle norme a tutela dei legittimari, infatti, non è assoluta, bensì relativa: sia perché il successore necessario, potendo decidere se impugnare o meno le disposizioni lesive, può rinunciare a quelle regole sia perché il legislatore colpisce la violazione delle regole medesime non con la nullità, bensì con la sanzione minore della riducibilità.
In virtù di quanto detto, l’inammissibilità della diseredazione del legittimario pare debba intendersi in termini di riducibilità, ex art. 554 cod. civ., della clausola di diseredazione[153]. In altri termini, soprattutto alla luce della recente giurisprudenza e dottrina che riconoscono la legittimità di tale istituto, non vi sarebbe nullità della clausola, ma validità, fintanto che la stessa non venga ridotta[154].
Degna di nota è la conclusione di alcuni Autori, alla quale si aderisce, i quali compiono un ulteriore passo: la validità della diseredazione del legittimario[155]. Osservando che la diseredazione, al pari della preterizione, è soggetta a riduzione e che non vi sono norme che impediscono la pretermissione del legittimario ottenendo di fatto una diseredazione implicita, non vi sarebbe alcun motivo per negare di fare altrettanto in via esplicita, in ossequio anche, al più volte citato, principio di autonomia testamentaria.
Le diverse qualificazioni prospettate non hanno un valore puramente teorico, ma soprattutto pratico, rispetto alla concreta tutela del legittimario diseredato: qualora si propendesse per la nullità (per contrarietà a norme imperative o per violazione del divieto di pesi o condizioni) si giungerebbe all’«assurda conseguenza che il legittimario preterito potrebbe solo agire in riduzione ed ottenere la quota di riserva nella successione necessaria, mentre il legittimario totalmente diseredato potrebbe ottenere la declaratoria di nullità della clausola, limitatamente alla riserva, nullità come tale imprescrittibile e rilevabile anche d’ufficio dal giudice»[156]. Inoltre, sostando la tesi della nullità, stante l’imprescrittibilità di tale azione ex art. 1244 cod. civ., si avrebbe una notevole incertezza nei rapporti giuridici successivi; invece, aderendo alla tesi più condivisibile della riducibilità, la disposizione testamentaria diseredativa resterebbe valida ed efficace, almeno fino all’intervenuta impugnazione dal legittimario con l’azione di riduzione, soggetta al termine di prescrizione decennale.
5. Riflessioni conclusive
Alla luce di quanto osservato si ritiene logica e condivisibile la soluzione adottata dalla Corte di Cassazione nel 2012, sia perché ha risolto il contrasto interpretativo, sia perché ha riconosciuto un diverso e più ampio potere al de cuius. Relativamente a questo secondo aspetto, la verità è che la sostanza del testamento è data dalla libera espressione della volontà del suo autore di dare l’assetto desiderato alla propria successione. Una volta rispettata quella che è la funzione del testamento, la volizione è libera e può manifestarsi anche in clausole dal contenuto meramente negativo.
Gli unici limiti alla autonomia testamentaria consisterebbero nella possibilità di individuare comunque un erede o un legatario e nel rispetto dei diritti dei riservatari; non vi è ragione di individuarne altri. Nei limiti della disponibile deve pertanto ritenersi che il de cuius sia pienamente autonomo e possa disporre come meglio creda, sia indicando i destinatari della delazione sia depennando un soggetto. Quel che conta è che il negozio sia conforme alla funzione regolatrice: sia che la volizione attenga alla disciplina dei destinatari, sia che attenga all’assetto del fenomeno successorio, essa può senz’altro costituire contenuto del testamento e l’atto sarà pertanto riconducibile al modello. In altri termini, è sufficiente che la volizione (sempre che sia espressa in una forma testamentaria valida) raccolga disposizioni dirette a produrre effetti successori. Rispettati questi requisiti è irrilevante che i detti effetti derivino da un atto confezionato in termini di attribuzione o in termini di esclusione.
Se ciò che conta è solo la conformità della disposizione successoria alla funzione sopra indicata, nel diseredare alcuni o tutti i propri parenti il testatore non viola alcun principio di ordine pubblico e, quindi, di meritevolezza.
Resta da fare un ulteriore breve accenno alla potenziale ammissibilità della diseredazione dei legittimari. Su tale aspetto pare criticabile la posizione della Cassazione, indice di un atteggiamento negazionista, che persevera nell’idea dell’ammissibilità della sola diseredazione dei successibili ex lege, e non anche dei legittimari. Al principio dell’intangibilità della quota di legittima, ex art. 457, terzo, cod. civ. e ex art. 549 cod. civ., vi sono già delle deroghe espresse[157]. In particolare, attraverso il legato in sostituzione di legittima, ex art. 551 cod. civ., il testatore priva della qualità di erede il legittimario: in sostanza, lo disereda. Orbene, se è possibile negare a un legittimario la qualità di erede e se è possibile diseredare un legittimario in forma implicita attraverso la pretermissione, per quale motivo non sarebbe possibile farlo anche in forma esplicita?
Poiché le norme relative alla successione necessaria non sarebbero, per la dottrina prevalente, cogenti, non si ravvisa alcun elemento ostativo a considerare ammissibile anche la diseredazione esplicita di un legittimario. La differenza tra la diseredazione del successibile e del legittimario sta unicamente nella possibile reazione da parte di tali soggetti: il primo, una volta diseredato, non ha più alcuno strumento per potersi tutelare; il secondo, invece, può usufruire dei mezzi a lui messi a disposizione dall’ordinamento (azione di riduzione, nullità della divisione, etc.). Gli stessi strumenti che consentono al legittimario di reagire alla diseredazione fatta dal testatore in via indiretta. Pertanto, si ripete, non si ravvisa alcuna ragione per negarne la diseredazione esplicita.
Un ulteriore argomento si può aggiungere a tale tesi: il legislatore, recentemente, ha ammesso un’ipotesi eccezionale di diseredazione di legittimario e più nello specifico del genitore (ascendente). Ci si riferisce alla introduzione dell’art. 448-bis cod. civ., tramite la legge n. 219 del 2012, che consente al figlio di escludere dalla propria successione (quindi di diseredare) il genitore, decaduto dalla responsabilità genitoriale, che si sia reso responsabile di fatti che non integrino casi di indegnità ex art. 463 cod. civ.; la novità normativa è significativa sotto un duplice profilo: da un lato riconosce l’istituto della diseredazione quale clausola meramente negativa, valida anche in assenza di attribuzioni positive; dall’altro consente la diseredazione nei confronti di un soggetto che potrebbe essere un legittimario[158].
Alla luce dei nuovi orientamenti in tema di successione, conformemente a quanto già sostenuto da autorevole dottrina[159], sembra che possa essere giunta a maturità una revisione la successione dei legittimari che permetta una maggiore esplicazione dell’autonomia testamentaria, anche attraverso la previsione normativa espressa della desiderazione, non circoscrivendola ai soli pronunciati giurisprudenziali.
[1] Cass., 25 maggio 2012, n. 8352 in Giust. civ. 2012, I, p. 1164, con nota di L. Ciafardini, Cambio di rotta della Cassazione sulla clausola di diseredazione; si può leggere anche in Fam. Pers. Succ., 2012, 11, p. 763 nota di V. Barba, La disposizione testamentaria di diseredazione; in Nuova giur. civ., 2012, I, p. 991 nota di R. Pacia, Principio di autonomia e validità del testamento contente solo una clausola di diseredazione; in Vita not.., 2012, 2, p. 665 nota di D. Pastore, La Cassazione ammette la diseredazione; in Corriere Giur., 2013, 5, p. 614 nota di B. Caliendo, La diseredazione: “(non) vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole..”; in Fam. dir., 2013, p. 146 con nota di G. BELLAVIA, La Cassazione ammette la clausola di diseredazione esplicita meramente negativa; in Notariato, 2013, p. 24 con nota di R. Cimmino, Diseredazione e ricostruzione causale del negozio testamentario.
Si rinvia anche al commento di C. Bruno, Liceità della diseredazione esplicita, in Giust. civ., 2013, I, p. 1473; V. Occorsio, «Escludo da ogni avere i miei cugini»: la Cassazione alla svolta in tema d diseredazione, in Giust. civ., 2013, I, p. 685; R. Pacia, Validità del testamento di contenuto meramente diserdativo, in Riv. dir. civ., 2014, p. 307; M. Fusco, È valida la clausola di diseredazione meramente negativa, in Giur. it., 2013, p. 315; G. Torregrossa, Nota in tema di diseredazione, in Giur. it., 2012, p. 2506.
[2] Numerosi sono gli Autori che si sono occupati del tema della diseredazione. Tra i numerosi contributi dottrinali in materia di diseredazione, si annoverano i seguenti: G. Andreoli, Vocazioni isolate e concorrenti a titolo di erede, in Riv. dir. civ., 1941, p. 329; L. Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1944, p. 254 ss.; L. Ferri, L’esclusione testamentaria di eredi, in Riv. dir. civ., 1941, p. 228 ss.; Id., Se debba riconoscersi efficacia a una volontà testamentaria di diseredazione, in Foro pad., 1955, I, c. 47 ss.; A. Trabucchi, Esclusione testamentaria degli eredi e diritto di rappresentazione, in Giur. it., 1955, I, 2, c. 749 ss.; Id., L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, in Riv. dir. civ., 1970, I, p. 39 ss.; A. Cicu, Diseredazione e rappresentazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1956, I, p. 385 e ss.; G. Notari, Volontà testamentaria e diseredazione, in Riv. not., 1957, p. 109 ss.; A. Torrente, voce: “Diseredazione, c) diritto vigente”, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, p. 102 ss.; A.C. Jemolo, La diseredazione, in Riv. dir. civ., 1965, II, p. 504 ss.; R. Odorisio, Sulla cosiddetta diseredazione, in Temi, 1965, p. 190; M. Bin, La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento, Torino, 1966; G. Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, p. 1182 ss.; P. Rescigno, Recensione a M. BIN, La diseredazione – Contributo allo studio del contenuto del testamento, in Riv. dir. civ., 1969, I, p. 95 ss.; A. Burdese, in G. Grosso - A. Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., dir. da F. Vassalli, Torino, s. d., ma 1977, p. 83 ss.; E. Ondei, Le disposizioni testamentarie negative, in Foro pad., 1977, I, c. 301 ss.; F. Miriello, In margine alla clausola di diseredazione: la tematica della c.d. volontà meramente negativa, in Riv. not., 1981, p. 744 ss.; L. Di Lalla, nota a Cass., 23 novembre 1982, n. 6339, in Foro. it., 1983, I, 2, c. 1652 ss.; C. Saggio, Diseredazione e rappresentazione, in Vita not., 1983, II, p. 1788 ss.; F.M. Bandiera, Sulla validità della diseredazione, in Riv. giur. sarda, 1991, p. 402 ss.; M. Corona, Funzione del testamento e riconducibilità della disposizione di esclusione del successibile ex lege (non legittimario) all’assegno divisionale semplice c.d. indiretto, in Riv. giur. sarda, 1992, p. 27 ss.; Id., La c.d. diseredazione: riflessioni sulla disposizione testamentaria di esclusione, in Riv. not., 1992, p. 505 ss.; F. Gazzoni, È forse ammessa la diseredazione occulta dei legittimari?, in Giust. civ., 1993, I, p. 2522 ss.; L. Bigliazzi Geri, Delle successioni testamentarie, in Comm. cod. civ. a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro secondo: Successioni. Artt. 587 – 600, Bologna – Roma, 1993, p. 1 ss., p. 95 ss.; Id., Il testamento, in Tratt. dir. priv. diretto da P. Rescigno, Volume 6, Tomo II, Successioni, Torino, 1997, p. 136 ss.; Id., Il testamento, I) Profilo negoziale dell’atto: appunti delle lezioni, Milano, 1976; F. Bartolozzi, La c.d. clausola di diseredazione, in Notariato, 1995, p. 14 ss.; S.T. Masucci, Non è ammessa la diseredazione occulta dei legittimari: brevi cenni sull’usucapione a domino, in Giur. it., 1995, I, 1, c. 917 ss.; D. Onano, Diseredazione: istituzione implicita anche nel caso di dubbio sulla effettiva esistenza della volontà istitutiva, in Riv. giur. sarda, 1995, p. 586 ss.; F. Corsini, Appunti sulla diseredazione, in Riv. not., 1996, p. 1093 ss.; M. Ieva, Manuale di tecnica testamentaria, Padova, 1996, p. 27 ss.; A. Pinna Vistoso, Diseredazione, istituzione implicita e riabilitazione del diseredato: un nuovo caso giurisprudenziale sulla volontà testamentaria di esclusione, in Riv. giur. sarda, 1998, p. 6 ss.; D. Russo, La diseredazione, Torino, 1998; L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima, , in Tratt. dir. civ. e comm. già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Volume XLIII, Tomo 1, Milano, 1999, p. 22 ss.; E. Bergamo, Brevi cenni su un’ipotesi di diseredazione anomala implicita, in Giur. it., 2000, c. 1801 ss.; A. Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir. priv., a cura di G. Iudica e P. Zatti, t. II, Milano, 2000, II ed., p. 639 ss.; G. Pfnister, La clausola di diseredazione, in Riv. not., 2000, II, p. 913 ss.; E. Bergamo, Brevi note sulla diseredazione, in Giur. it., 2001, c. 70 ss.; L. Cavandoli, Clausola di diseredazione e testamento, in Vita not., 2001, I, p. 694 ss.; C. Grassi, Validità del testamento di contenuto meramente diseredativo, in Familia, 2001, p. 1210 ss.; D. Morello Di Giovanni, Clausola di diseredazione e autonomia negoziale del disponente, in Giur. merito, 2001, I, p. 938 ss.; G. Porcelli, Autonomia testamentaria ed esclusione di eredi, in Notariato, 2002, p. 49 ss.; M. Comporti, Riflessioni in tema di autonomia testamentaria, tutela dei legittimari, indegnità a succedere e diseredazione, in Familia, 2003, I, p. 27 ss.; C. Ungari-Trasatti, Rassegna di dottrina e giurisprudenza in tema di diseredazione, in Riv. not., 2003, p. 1320 ss.; C.M. Bianca, Diritto civile, 2. La famiglia – Le successioni, Milano, 2005, IV ed., p. 739 ss.; G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, s. d., ma 2006, IV ed., p. 98; Id., Disposizione di diseredazione accompagnata da disposizione modale, in Famiglia, persone e successioni, 2007, p. 715 M. Moretti, Le disposizioni testamentarie. La diseredazione, in Tratt. dir. succ. e donaz. diretto da G. Bonilini, Volume II: la successione testamentaria, Milano, 2009, p. 263 ss.; D. Pastore, Riflessioni sulla diseredazione, in Vita not., 2011, p. 1181.
[3] Sul significato del termine “diseredare” nell’attuale ordinamento giuridico si rinvia a D. Russo, La diseredazione, cit., p. 4 ss.
[4] A. Burdese, Manuale di diritto privato romano, Torino, 1964, p. 777, a proposito di diseredazione sottolinea: «è riconosciuto dal ius civile un limite alla libertà di testare, che si sintetizza nella formula “sui heredes instituendi sunt vel exheredandi”: i sui devono cioè essere menzionati nel testamento per essere istituiti eredi o diseredati, non potendo esservi omessi (preteriti), sotto sanzione di invalidità, totale o parziale del testamento stesso; la institutio del suus non fa che confermargli la qualifica legale di heres, […] mentre la exheredatio toglie al suus tale qualifica, con disposizione considerata tanto grave da non potere essere in alcun modo favorita dal diritto».
Dello stesso principio tratta anche V. Arangio Ruiz, Istituzioni di diritto romano, Napoli, 1966, p. 545, evidenziando che la exheredatio fu dapprima «un atto solenne a autonomo di spossessamento della qualità di erede, compiuto dal padre in punizione del figlio indegno e come necessaria preparazione all’adozione di un estraneo: ma divenne poi, col separarsi delle due idee di fiulius e di heres, una semplice dichiarazione testamentaria che escludeva certi discendenti dall’eredità. Sorse così il principio “sui aut instituendi aux exhereditandi”, che impose al testatore l’obbligo alternativo d’istituire i discendenti immediati in potestà, […] oppure di far seguire alla nomina degli eredi l’espressa diseredazione dei discendenti esclusi: restò, invece, vietato di passare i sui sotto silenzio (preterizione)».
Per un’approfondita analisi dell’evoluzione storico-dottrinale dell’istituto si rinvia inoltre anche a G. Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1189 ss.; A. Burdese, voce Diseredazione (Diritto romano), in Noviss. dig. it., vol. V, Torino, 1960, p. 1113; F. Cancelli, voce Diseredazione (Diritto romano), in Enc. dir., vol. XXIII, Milano, 1964, p. 95; D. Russo, La diseredazione, cit., p. 4 ss., ove interessanti considerazioni sul rapporto tra l’attuale diseredazione e l’antica exheredatio del diritto romano.
[5] Per sinteticità, ma puntuale ricostruzione storica dell’istituto, si veda: D. Pastore, Riflessioni sulla diseredazione, cit., p. 1182 e ss.; L. Cavandoli, Clausola di diseredazione e testamento, cit., p. 695 e ss.; V. Porrello, La clausola di diseredazione, in Dir. fam., 2008, p. 980 e G. Pfnister, La clausola di diseredazione, cit., p. 913 e ss.; C. Ungari-Trasatti, Rassegna di dottrina e giurisprudenza in tema di diseredazione, cit., p. 1312 ss..
[6] Tra i codici civili che prevedono e disciplinano la diseredazione troviamo:
a) il codice civile austriaco (A.B.G.B.), il quale prevede l’indegnità al § 540 e la diseredazione al § 768;
b) il codice civile tedesco (BGB) prevede l’indegnità al § 2339 e la diseredazione al § 2333;
c) il codice civile spagnolo prevede l’indegnità all’art. 756 e la diseredazione all’art. 849;
d) il codice civile svizzero prevede all’art. 540 l’indegnità a succedere all’art. 447 la diseredazione;
e) il codice civile greco prevede l’indegnità all’art.1860 e la diseredazione all’art. 1840;
f) il codice civile portoghese prevede l’indegnità all’art. 2034 e la diseredazione all’art. 2166;
g) relativamente all’America Latina, prevedono tanto l’indegnità quanto la diseredazione il codice civile argentino, il codice civile colombiano, il codice civile brasiliano, nonché il moderno codice civile peruviano.
[7] Va, peraltro, avvertito che l’omessa regolamentazione dell’istituto va letta soltanto come una vicenda dell’evoluzione del sistema di tutela dei legittimari e non come un indice a conforto della tesi dell’inammissibilità della figura. In tal senso in dottrina già L. Salis, La successione necessaria nel diritto civile italiano, Padova, 1929, pp. 12 ss. e, in giurisprudenza, Trib. Lucca 6 novembre 1953, in Giur. tosc., 1954, pp. 209 ss., che spiega ampiamente, sulla scorta della Relazione Pisanelli al progetto del codice civile, le ragioni della soppressione dell’istituto nel codice del 1865, la quale va letta soltanto come una vicenda dell’evoluzione del sistema di tutela dei legittimari e non come un indice a conforto della tesi dell’inammissibilità della figura.
[8] A. Torrente, voce: “Diseredazione, c) diritto vigente”, cit., p. 102; M. Moretti, Le disposizioni testamentarie. La diseredazione, cit., p. 264, la quale sottolinea che «controverso è, infatti, se l’autonomia testamentaria possa riconoscersi a tal punto da consentire al testatore di compiere un atto diretto al solo fine di privare qualcuno della successione, ossia di dichiarare che non può essere suo erede».
[9] Sul significato del termine “diseredazione”, v. M. Bin, op. ult. cit., p. 9 ss.; A. Cicu, Diseredazione e rappresentazione, cit., p. 385; F. Miriello, In margine alla clausola di diseredazione: la tematica della c.d. volontà meramente negativa, cit., p. 747.
[10] Sul punto C. Ungari-Trasatti, Rassegna di dottrina e giurisprudenza in tema di diseredazione, cit., p. 1320 ss.; L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, in Tratt. dir. civ. e comm. già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Volume XLIII, Tomo 1, Milano, 2000, p. 80 ss. nota 95 e p. 114; L. Ferri, L’esclusione testamentaria di eredi, cit., p. 228 ss.
[11] Cfr. G. Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1197 ss.; Id., Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p. 35, nota n. 1.
[12] Altra dottrina ritiene che non vi sarebbero valide ragioni per escludere la diseredazione di un legittimario una volta ammessa la validità della clausola. Sul punto si veda D. Pastore, Riflessioni sulla diseredazione, cit., p. 1185 e ss. Si rinvia anche al § 4 del presente lavoro.
[13] Così G. Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1197 ss., il quale ammette la volontà meramente negativa, diretta ad escludere dalla successione gli eredi ab intestato.
[14] Cfr. F.M. Bandiera, Sulla validità della diseredazione, cit., p. 403; G, Bonilini, Disposizione di diseredazione accompagnata da disposizione modale, cit., p. 717; G. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2009, p. 200; M. Corona, La c.d. diseredazione: riflessioni sulla disposizione testamentaria di esclusione, cit., p. 506; L. Ferri, Se debba riconoscersi efficacia a una volontà testamentaria di diseredazione, cit., c. 50; L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima, Successioni per causa di morte., cit., p. 22, nota n. 59; E. Ondei, Le disposizioni testamentarie negative, cit., c. 303.; P. Rescigno, Recensione a M. Bin, La diseredazione – Contributo allo studio del contenuto del testamento, cit., p. 95; D. Russo, La diseredazione, cit., p. 11. Secondo Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, in Foro it., 1968, I, I, 574 ss. (si può leggere anche in Giust. civ., 1967, I, p. 2032 ss.), il testatore potrebbe esercitare il potere di diseredazione soltanto nei limiti della intangibilità della quota di legittima; A. Torrente, voce: “Diseredazione, c) diritto vigente”, cit., p. 102. V. anche Trib. Catania, 28 marzo 2000, in Giust. civ., 2001, I, p. 1110.
[15] Sul punto L. Ferri, Se debba riconoscersi efficacia a una volontà testamentaria di diseredazione, cit. c. 48, per il quale «diseredare significa dichiarare espressamente che alcuno, che potrebbe essere chiamato dalla legge, non debba essere erede». D. Russo, La diseredazione, cit., p. 18; L. Cavandoli, Clausola di diseredazione e testamento, cit., p.701.
[16] Sul punto, F. Corsini, Appunti sulla diseredazione, cit., p. 1120, nota n. 67. In giurisprudenza, v. Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, cit.; App. Catania, 28 maggio 2003, in Giur. di merito, 2004, I, p. 15, con nota di L. Barreca, Ancora sulla diseredazione, in Giur. di merito, I, 2005, p. 274 e ss..
[17] L. Ferri, L’esclusione testamentaria di eredi, cit., p. 228 ss., il quale è tra i primi ad aver posto tale quesito.
[18] Cfr. F. Corsini, Appunti sulla diseredazione, cit., p. 1094 ss.; D. Pastore, Riflessioni sulla diseredazione, cit., p. 1181; F.M. Bandiera, Sulla validità della diseredazione, cit., p. 403; Cass., 5 aprile 1975, n. 1217, in Foro it., Rep., 1975, voce: “Successione ereditaria”, n. 50; App. Catania, 28 maggio 2003, cit., p. 16 e Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, cit.;
[19] Proprio in ragione di ciò è opportuno evidenziare fin da subito la netta differenza tra “diseredazione” e “pretermissione”, poiché, capita spesso ed erroneamente, che i due termini vengano utilizzati, nel linguaggio comune, quali sinonimi. Cfr. L. Genghini, Ammissibilità della mera diseredazione testamentaria, in Riv. not., 2013, p. 4 ss., secondo cui «la diseredazione, per definizione, elimina la designazione ex lege. La preterizione, ove il testatore abbia disposto di tutti i suoi beni, non ha la stessa efficacia giacche è sufficiente che uno dei designati non accetti l’eredità, che su quella quota (in mancanza di sostituzione, rappresentazione o accrescimento), si aprirà la successione legittima, alla quale avrà delazione ex legge anche il preterito. Non così per la diseredazione (se ritenuta valida): la quota non accettata o i beni sopravvenuti si accresceranno agli eredi designati, o chiamati ex lege, con esclusione del diseredato. Inoltre nella preterizione l’esclusione è solo indiretta, in quanto consegue all’attribuzione di tutti i beni dell’asse ereditario ad altri soggetti, nella diseredazione, invece, l’esclusione dalla successione discende direttamente dall’esplicita volontà del testatore. Infine, secondo una tesi la diseredazione ha carattere assoluto e vale anche per eventuali precedenti disposizioni testamentarie e per i legati: si esclude tutto, ogni possibilità derivante, vuoi dal titolo legale, vuoi da altro titolo testamentario e in quest’ultimo caso si cancella anche quanto fosse già stato previsto a titolo di legato».
[20] Sul punto, M. Ieva, Manuale di tecnica testamentaria, cit., p. 31
[21] Cfr. L. Ferri, L’esclusione testamentaria di eredi, cit., p. 232; Id., Se debba riconoscersi efficacia ad una volontà testamentaria di diseredazione, cit., c. 49. In senso conforme A. Cicu, Diseredazione e rappresentazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1956, p. 386; R. Odorisio, op. cit., p. 183; A. Trabucchi, L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative cit.,p. 49; C. Saggio, op. cit., p. 1791; D. Russo, La diseredazione, cit., pp. 14-15. In senso contrario E. Ondei, Le disposizioni testamentarie negative, cit., c. 303.
[22] Per fare un esempio, nel caso un testatore che lasci solo tre fratelli potrebbe redigere diposizioni di tal tipo: “nomino eredi dei miei tre fratelli solo Tizio e Caio” oppure “nomino eredi di tutto il mio patrimonio solo Tizio e Caio, non volendo attribuire nulla a Sempronio” ed infine “nomino eredi coloro che saranno chiamati come tali dalla legge al momento della apertura della mia successione, escludendovi Sempronio”.
[23] Così Cass., 5 aprile 1975, n. 1217, cit.. Nell’ipotesi considerata, la clausola di diseredazione sarebbe sostanzialmente inutile, dal momento che il testatore conseguirebbe ugualmente il risultato di devolvere l’eredità al soggetto positivamente menzionato. Cfr. anche Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, cit.
Secondo G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., p. 221 ss., in presenza di disposizioni testamentarie attributive, l’aggiunta di una clausola di diseredazione potrebbe spiegarsi con l’intento di offendere il soggetto diseredato.
[24] Ad esempio, riprendendo il caso precedente: “dei miei tre fratelli escluso solo Sempronio”. Sul punto si tornerà più avanti.
[25] Ad es. “diseredo mio fratello Sempronio”; “escludo dalla mia successione mio fratello Sempronio”; “voglio che Sempronio non riceva nulla dalla mia successione”, senza altro aggiungere.
[26] Così G. Andreoli, Vocazioni isolate e concorrenti a titolo di erede, cit., p. 329; L. Barassi, Le successioni per causa di morte, cit., p. 303 ss., p. 392; G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., p. 201; A. Cicu, Diseredazione e rappresentazione, cit., p. 385 ss.; L. Ferri, L’esclusione testamentaria di eredi, cit., p. 228 ss.; Id., Se debba riconoscersi efficacia a una volontà testamentaria di diseredazione, cit., c. 47 ss. e, soprattutto, c. 52; A.C. Jemolo, La diseredazione, cit., p. 505; L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima, cit., p. 23; F. Miriello, In margine alla clausola di diseredazione: la tematica della c.d. volontà meramente negativa, cit., p. 747; R. Odorisio, op. cit., p. 190; F. Santoro – Passarelli, Vocazione legale e vocazione testamentaria, in Riv. dir. civ., 1942, p. 200 A. Torrente, voce: “Diseredazione, c) diritto vigente”, cit., p. 102 ss.
[27] Cfr., per tutte, Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, cit.
[28] In tal senso, G. Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1182 ss.; F.M. Bandiera, Sulla validità della diseredazione, cit., p. 408; C.M. Bianca, Diritto civile, 2. La famiglia – Le successioni, cit., p. 739; L. Bigliazzi Geri, Delle successioni testamentarie, cit., p. 95 ss.; Id., Il testamento, cit., p. 136 ss.; Id., Il testamento, I) Profilo negoziale dell’atto: appunti delle lezioni, cit., p. 274 ss.; M. Bin, La diseredazione, cit., p. 1 ss.; M. Corona, Funzione del testamento e riconducibilità della disposizione di esclusione del successibile ex lege (non legittimario) all’assegno divisionale semplice c.d. indiretto, cit., p. 27 ss.; Id., La c.d. diseredazione: riflessioni sulla disposizione testamentaria di esclusione, cit., p. 505 ss.; P. Rescigno, Recensione a M. Bin, La diseredazione – Contributo allo studio del contenuto del testamento, cit., p. 95 ss.; C. Saggio, op. cit., p. 1788 ss.; A. Trabucchi, Esclusione testamentaria degli eredi e diritto di rappresentazione, cit., c. 749 ss.; Id., L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, cit., p. 39 ss.
[29] Cfr. Trib. Parma, 3 maggio 1977, n. 227, in Riv. not., 1977, p. 689 ss. (si può leggere anche in Foro pad., 1977, I, c. 302 ss. con nota di E. Ondei); Trib. Nuoro, 15 settembre 1989, n. 359, in Riv. Giur. sarda, 1991, p. 389 ss., con nota di F.M. Bandiera; Trib. Catania, 21 febbraio 2000, in Giur. it., 2001, c. 70 ss., con nota di E. Bergamo; Trib. Catania, 28 marzo 2000, in Familia, 2001, p. 1210, con nota di C. Grassi (si può leggere anche in Giust. civ., cit..); App. Firenze, 9 settembre 1954, in Foro pad., 1955, I, p. 47 ss., con nota di L. Ferri (si può leggere anche in Giur. it., 1955, I, 2, c. 749 ss., con nota di A. Trabucchi); App. Napoli, 21 maggio 1961, in Foro pad., 1962, I, c. 939 ss.; App. Genova, 16 giugno 2000, in Giur. merito, 2001, I, p. 937, con nota di D. Morello Di Giovanni. Contra, invece, Trib. S. Maria Capua Vetere, 25 maggio 1960, in Foro pad., 1961, I, c. 369 ss.
[30] In tal senso, Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2000, in Vita not., 2001, I, p. 694 ss., con nota di L. Cavandoli (si può leggere anche in Notariato, 2002, p. 47 ss., con nota di G. Porcelli); App. Cagliari, 5 dicembre 1990, n. 302, in Riv. giur. sarda, 1991, p. 389 ss., con nota di F.M. Bandiera; App. Cagliari, 12 gennaio 1996, in Riv. giur. sarda, 1998, p. 1 ss., con nota di A. Pinna Vistoso; Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, cit.; Cass., 23 novembre 1982, n. 6339, in Foro it., 1983, I, 2, c. 1652 ss., con nota di L. Di Lalla; Cass., 18 giugno 1994, n. 5895, in Riv. giur. sarda, 1995, p. 579 ss., con nota di D. Onano (si può leggere anche in Giur. it., 1995, I, 1, c. 1564 ss. con nota di C. Cecere, Brevi note sulla diseredazione, e in Notariato, 1995, p. 11 ss., con nota di F. Bartolozzi).
[31] Occorre domandarsi se il testatore, senza contestuale positiva attribuzione dei propri beni, possa escludere dalla successione uno o più soggetti, i quali vi sarebbero chiamati in base alle regole della successione legittima. Più precisamente, il problema è quello di stabilire se l’autonomia testamentaria possa manifestarsi, oltre che con disposizioni positive (es.: istituisco erede Tizio), anche con disposizioni negative del seguente tenore: “escludo dalla successione mio fratello Sempronio”; “diseredo mio fratello Sempronio”; “non voglio che mio fratello Sempronio riceva nulla dalla mia eredità”, “escludo Mevio, mio legittimario, dalla porzione disponibile”. Per quanto concerne l’ultima formula utilizzata, relativa all’esclusione di un successore necessario dalla quota disponibile, si osservi che il testatore può ottenere il medesimo risultato mediante un’istituzione di erede nella sola quota di riserva.
[32] Sul punto, G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., p. 201; A. Cicu, Diseredazione e rappresentazione, cit., p. 385 ss.; L. Ferri, L’esclusione testamentaria di eredi, cit., p. 228 ss.; Id., Se debba riconoscersi efficacia a una volontà testamentaria di diseredazione, cit., c. 47 ss. e, soprattutto, c. 52; Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, Napoli, 1977, p. 156 ss.; G. Criscuoli, Testamento (voce), in Enc. giur., XXXI, Roma, 1994, p. 19 ss.; L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima, cit., p. 23; F. Miriello, In margine alla clausola di diseredazione: la tematica della c.d. volontà meramente negativa, cit., p. 747; A. Torrente, voce: “Diseredazione, c) diritto vigente”, cit., p. 102 ss. Cfr. anche F. Santoro – Passarelli, Vocazione legale e vocazione testamentaria, cit., p. 200, il quale, tuttavia, nella nota n. 27, ammette l’efficacia della clausola di diseredazione facendo ricorso alla formula dell’istituzione implicita.
[33] Cfr., per tutte, Cass. civ,, 20 giugno 1967, n. 1458, cit.
[34] Secondo i fautori dell’orientamento in esame, la volontà di escludere dalla successione un potenziale erede legittimo sarebbe ammissibile soltanto se accompagnata da disposizioni di tipo attributivo: la diseredazione sarebbe solo rafforzativa della volontà di attribuire ad altri il proprio patrimonio. Resta ferma, naturalmente, la possibilità di ricorrere allo strumento della pretermissione, ossia la possibilità di effettuare disposizioni attributive, le quali esauriscano in tutto o in parte il patrimonio ereditario, realizzando, così, un’esclusione indiretta dei successibili non menzionati.
[35] La tesi de qua si basa sulla presunta prevalenza della successione ab intestato su quella testamentaria: l’interesse del gruppo familiare sarebbe preminente rispetto alle esigenze di carattere individuale sottese al regolamento testamentario.
[36] Cfr. L. Barassi, Le successioni per causa di morte, cit., p. 52 ss.; A. Cicu, Diseredazione e rappresentazione, cit., p. 388 secondo il quale «vedere nella diseredazione una disposizione negativa, non solo non ha senso, ma non è possibile trasformarla in una disposizione positiva di esclusione, perché ciò implicherebbe modificare o sopprimere la vocazione di legge: riconoscere al privato il potere di sovrapporsi o sostituirsi alla volontà della legge, dettate per la tutela di un interesse superiore»; Id., Successione legittima e deli legittimari, Milano, 1943, pp. 3 e 144 ss.; F. Santoro – Passarelli, Vocazione legale e vocazione testamentaria, cit., p. 199; Id., Saggi di diritto civile, Napoli, 1961, p. 591; G. Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1195, il quale individua la successione ab intestato nell’esigenza sociale di assicurare al deceduto un continuatore e un sostituto nella titolarità dei rapporti giuridici che facevano a lui capo, salvo poi concludere per la funzione suppletiva della successione ex lege.
[37] App. Catania, 28 maggio 2003, cit., p. 19.
[38] Secondo L. Ferri, L’esclusione testamentaria di eredi, cit., p. 241 e 242, consentire al testatore di diseredare un successibile ab intestato significherebbe riconoscere arbitrariamente ai privati «la possibilità di creare nuovi casi di indegnità all’infuori di quelli tassativamente previsti dalla legge». Cfr. anche F. Massineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. VI, Milano 1962, p. 154 e G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., p. 201 e Trib. S. Maria Capua Vetere, 25 maggio 1960, cit., c. 370.
[39] Così A. Cicu, Diseredazione e rappresentazione, cit., p. 385 e L. FERRI, L’esclusione testamentaria di eredi, cit., p. 232 ss.; v. anche App. Catania, 28 maggio 2003, cit., p. 19, il quale conclude per la nullità della diseredazione per illiceità della causa e per non perseguire interessi meritevoli di tutela.
[40] Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, cit.
[41] L. Ferri, Se debba riconoscersi efficacia a una volontà testamentaria di diseredazione, cit., c. 52 per il quale la diseredazione non è un atto di disposizione patrimoniale e quindi ess non è ammissibile in quanto non rientra fra le disposizioni di carattere non patrimoniale che la legge consente che siano incluse nel testamento.
[42] Cfr. F. Carresi, Autonomia privata nei contratti e negli altri atti giuridici, in Riv. dir. civ., 1957, p. 272, secondo il quale i privati, al fine di regolare post mortem la sorte dei propri rapporti giuridici, non soltanto potrebbero utilizzare un unico atto, il testamento, ma dovrebbero ricorrere esclusivamente, per determinare il contenuto del medesimo, ai due schemi dell’istituzione di erede e del legato. Nello stesso senso, G. Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell’atto di ultima volontà, Milano, 1954, pp. 317 e 326.
[43] In tal senso Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, cit., la quale si sofferma su alcune disposizioni legislative per avvalorare tale tesi. Sul punto si rinvia a M. Corona, La c.d. diseredazione: riflessioni sulla disposizione testamentaria di esclusione, cit., p. 513 ss., il quale ricostruisce il percorso argomentativo della sentenza citata. Cfr. anche F. Massineo, Manuale di diritto civile e commerciale, cit., p. 154; A. Torrente, voce: “Diseredazione, c) diritto vigente”, cit., p. 103; G. Criscuoli, Testamento (voce), cit., p. 19; G. Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1184, il quale ripercorrendo il pensiero della Cassazione osserva che «è da escludere che possa in quell’atto di disposizione comprendersi anche un atto di rinuncia abdicativa con il quale è pure possibile disporre dei propri beni facendoli dismettere dal proprio patrimonio pur senza attribuirli positivamente ad altro soggetto». Riallacciandosi al dogma della preminenza della successione legittima, i fautori della tesi in esame affermano che soltanto vere e proprie disposizioni testamentarie potrebbero modificare le regole della successione ab intestato. In altri termini, il potere del testatore di modificare il regolamento legale di successione potrebbe essere esercitato soltanto attraverso le disposizioni che, a norma dell’art. 588, primo comma, cod. civ., possono considerarsi testamentarie: la diseredazione, stante il suo contenuto meramente negativo, non rientrerebbe tra quelle disposizioni ma di «disposizione nei riguardi della disposizione che la legge fa dei beni propri». V. A. Cicu, Diseredazione e rappresentazione, cit., p. 391.
[44] C.M. Bianca, Diritto civile, 2. La famiglia – Le successioni, cit., p. 740, afferma che la nullità della clausola in esame discenderebbe dalla mancanza di meritevolezza della causa che la sorregge. Cfr. anche L. Ferri, L’esclusione testamentaria di eredi, cit., p. 249, il quale, in termini ancora più drastici, descrive la diseredazione come una “ferita morale”, che comporta “un grave disonore per il diseredato”. Infine si rinvia a A.C. Jemolo, La diseredazione, cit., p. 504 s., secondo cui «... c’è un’istanza di pietà cristiana che si ribella all’istituto della diseredazione. Al momento in cui si dettano le ultime volontà ogni rumore deve essere spento ...il testamento deve essere usato per beneficare, non come mezzo di rivincita per il male ricevuto». Per l’orientamento che sostiene la sindacabilità della volontà testamentaria negativa in base al parametro della meritevolezza sociale cfr., invece, V. Scalisi, Persona umana e successioni. Itinerari di un confronto ancora aperto, in La civilistica italiana dagli anni ‘50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative, Venezia, 1991, p. 414 e spec. n. 100.
[45] In tal senso, G. Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1182 ss.; F.M. Bandiera, Sulla validità della diseredazione, cit., p. 408; G. Notari, op. cit., p. 109; C.M. Bianca, Diritto civile, 2. La famiglia – Le successioni, cit., p. 739; L. Bigliazzi Geri, Delle successioni testamentarie, cit., p. 95 ss.; Id., Il testamento, cit., p. 136 ss.; Id., Il testamento, I) Profilo negoziale dell’atto: appunti delle lezioni, cit., p. 274 ss.; M. Bin, op.cit., p. 254 ss.; M. Corona, Funzione del testamento e riconducibilità della disposizione di esclusione del successibile ex lege (non legittimario) all’assegno divisionale semplice c.d. indiretto, cit., p. 27 ss.; Id., La c.d. diseredazione: riflessioni sulla disposizione testamentaria di esclusione, cit., p. 505 ss.; N. Lipari, Autonomia privata e testamento, cit., p. 564; P. Rescigno, Recensione a M. Bin, La diseredazione – Contributo allo studio del contenuto del testamento, cit., p. 95 ss.; C. Saggio, op. cit., p. 1788 ss.; A. Trabucchi, Esclusione testamentaria degli eredi e diritto di rappresentazione, cit., c. 749 ss.; Id., L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, cit., p. 39 ss.; D. Pastore, Riflessioni sulla diseredazione, cit., p. 1196 e ss.
[46] Cfr. Trib. Parma, 3 maggio 1977, n. 227, cit.; Trib. Nuoro, 15 settembre 1989, n. 359, cit.; Trib. Catania, 21 febbraio 2000, cit.; Trib. Catania, 28 marzo 2000, cit.; App. Firenze, 9 settembre 1954, cit.; App. Napoli, 21 maggio 1961, cit.; App. Genova, 16 giugno 2000, cit., «la clausola di diseredazione contenuta in un testamento è una disposizione negativa di contenuto atipico rispetto all’istituzione di erede o di legato, espressione della più generale autonomia negoziale del de cuius. Se è sicura la validità della clausola quando contenga un’esplicita istituzione di erede, proprio dal riferimento all’autonomia negoziale del testatore discende l’affermazione di validità della clausola stessa, anche quando nella scheda testamentaria non sia contenuta alcuna disposizione positiva, non sussistendo alcun contrasto con il comma 1 dell’art. 587 c.c., per cui il testamento è l’atto con cui il soggetto dispone di tutte o di parte delle sue sostanze.». Contra, invece, Trib. S. Maria Capua Vetere, 25 maggio 1960, cit.
[47] Interessante è il contributo di M. Bin, op. ult. cit., p. 1 ss., in cui l’Autore rivede pazientemente tutti i dogmi sui quali si fonda la teoria dell’invalidità della diseredazione.
[48] Cfr. L. Bigliazzi Geri, Il testamento, cit., p. 140; M. Bin, op. ult. cit., p. 214 ss.; G. Pfnister, La clausola di diseredazione, cit., p. 918; Trib. Catania, 28 marzo 2000, cit., p. 1114; App. Firenze, 9 settembre 1954, cit., c. 52.
[49] In tal senso, M. Bin, op. ult. cit., p. 218.
[50] In passato, un’ulteriore argomentazione era costituita dalla fissazione della capacità di testare al compimento del diciottesimo anno di età (art. 591, comma 2, n. 1, cod. civ.), in deroga alla regola generale, in forza della quale la capacità di agire si acquistava al raggiungimento del ventunesimo anno. Si osservi che, oggi, a seguito della modifica dell’art. 2 cod. civ., le due forme di capacità vengono a coincidere.
[51] L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima, cit., p. 6, spiega che le norme sulla successione legittima hanno carattere suppletivo, in quanto presuppongono l’assenza di un negozio testamentario; dal punto di vista dei poteri riconosciuti all’autonomia privata, invece, esse si qualificano come dispositive, essendo suscettibili di essere derogate. Cfr. anche G. Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1195; D. Pastore, Riflessioni sulla diseredazione, cit., p. 1204 e ss. e Trib. Catania, 28 marzo 2000, cit., p. 1114.
[52] Sul punto, M. Bin, op. ult. cit., p. 101 ss.; G. Porcelli, Autonomia testamentaria ed esclusione di eredi, cit., p. 53.
Si osservi, infine, che quello di “famiglia” è un concetto storicamente relativo, percepito dalla coscienza comune in modo differente a seconda delle epoche storiche e condizionato dalle variabili economiche, sociali e politiche di un dato ambiente sociale. È a tutti evidente come, a seguito delle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato gli ultimi due secoli, la vecchia famiglia patriarcale sia stata sostituita da un nucleo familiare più ristretto, composto, essenzialmente, da genitori e figli.
[53] Per il superamento del dogma della preminenza della successione legittima, v. L. Bigliazzi Geri, Il testamento, cit., p. 17 ss.; M. Bin, op. ult. cit., p. 88 ss.; G. Cattaneo, La vocazione necessaria e la vocazione legittima, cit., p. 487 ss.; L. Ferri, Successioni in generale, in Comm. cod. civ. a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Libro secondo: Successioni. Artt. 456 – 511, Bologna – Roma, 1980, p. 79 ss.; E. Perego, Favor legis e testamento, Milano, 1970, p. 92 ss; L. Carraro, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, p. 27.
[54] Cfr. L. Bigliazzi Geri, Delle successioni testamentarie, cit., p. 13. Secondo G. Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1195, la finalità della successione ab intestato sarebbe quella di assicurare l’esistenza di un continuatore della personalità del defunto e, quindi, l’esistenza di un erede. Sul punto anche D. Pastore, Riflessioni sulla diseredazione, cit., p. 1204 per il quale ritiene conforme a logica «ritenere che, “se la legge permette con un testamento sia possibile impedire in tutto o in parte l’apertura della successione legittima (art. 457, comma 2, c.c.), a maggior ragione sia consentito limitarsi con un testamento ad espungere un soggetto dal novero dei successibili”, rappresentando ciò un minus»; D. Russo, La diseredazione, cit., p. 40, il quale individua il fondamento della successione intestata nel comune sentimento derivante dalla valutazione di quali successibili sono solitamente chiamati. Secondo Russo «la determinazione dei successibili ex lege si ispira, dunque a ad un “criterio di normalità”, ad una sorta di valutazione statistica»; M. Allara, La successione familiare suppletiva, Torino, 1954, p. 57.
[55] G. Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1194 ss., afferma che, con la diseredazione, si avrebbe un vero e proprio concorso tra la successione testamentaria e la successione legittima: la prima determinerebbe l’esclusione di un successibile ex lege; la seconda regolerebbe, per tutto il resto, il fenomeno successorio.
[56] Cfr. V. Porrello, op. cit., p. 980 ss.; F.M. Bandiera, Sulla validità della diseredazione, cit., p. 407, il quale osserva che, oltretutto, l’indegnità colpisce anche i legittimari, mentre la clausola di diseredazione non può mai incidere negativamente sulla quota di legittima; G, Bonilini, Disposizione di diseredazione accompagnata da disposizione modale, cit., p. 718; App. Firenze, 9 settembre 1954, cit., c. 54-55, secondo il quale: «l’indegnità non è in funzione di una limitazione di poteri del testatore, ma risponde ad una esigenza di pubblico interesse a che sia escluso dalla successione chi ha commesso determinati fatti delittuosi moralmente riprovevoli; quindi non si può dire che fra indegnità e facoltà di diseredare vi sia una incompatibilità, né dal punto di vista logico né da quello giuridico. Tanto più che la legge attribuisce alla persona della cui successione si tratta il potere di riabilitare l’indegno, onde, in definitiva anche in materia la volontà del disponente è destinata ad avere la prevalenza».
[57] Ex multis M. Bin, La diseredazione, cit., p. 222 ss.; L. Bigliazzi Geri, Il testamento, I) Profilo negoziale dell’atto: appunti delle lezioni, cit., p. 269 ss.; Id., Il testamento, cit., p. 115 ss.
In particolare secondo il Trib. Parma, 3 maggio 1977, cit. p. 691, secondo il quale il problema della validità e degli effetti delle disposizioni testamentarie puramente negative «che appare a prima vista tanto importante e che ha dato adito a contributi tanto ingegnosi ed eleganti, è, in realtà, sia dal punto di vista logico che da quello più tecnicamente giuridico, il più vuoto e inconsistente di tutti i problemi».
[58] Per il concetto di disposizione, v. L. Mengoni - F. Realmonte, voce “Disposizione, I) Atto di disposizione”, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, p. 189 ss; F. Santoro – Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p. 220. Si osserva che nel testamento, in primo luogo, manca un elemento essenziale dell’atto di disposizione in senso tecnico, ossia la diminuzione patrimoniale per il disponente: il testamento produce effetti solo al momento della morte del suo autore. A ciò si aggiunga che, mentre il concetto di atto di disposizione è nato per indicare una categoria di negozi che si contrappone a quella dei negozi obbligatori, il negozio testamentario non ha soltanto la funzione di regolare post mortem la sorte dei rapporti del suo autore, ma produce anche effetti obbligatori, come confermato dalla previsione e dalla disciplina del modus (art. 647 ss. cod. civ.). Come osserva M. Bin, op. ult. cit., p. 226, «definire come atto di disposizione in senso tecnico un negozio i cui effetti possono essere meramente obbligatori equivarrebbe a cadere in una stridente contraddizione in termini».
[59] Sul concetto di attribuzione, v. R. Nicolò, voce “Attribuzione patrimoniale”, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 283 ss.
[60] Cfr. M. Bin, op. ult. cit., p. 237; Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1199. Anche G. Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 317, ammette che, con l’eliminazione dell’inciso in questione, “potrebbe apparire legittima la conclusione che tutte le disposizioni di carattere patrimoniale, qualunque ne sia la natura e il contenuto, come quelle che valgono appunto a dare fisionomia propria all’atto testamentario, rientrino nel concetto di testamento in senso sostanziale”. Sul punto anche Trib. Nuoro, 15 settembre 1989, n. 359, cit., p. 392.
[61] Così M. Bin, op. ult. cit., p. 241, il quale osserva come il binomio disposizioni patrimoniali – disposizioni non patrimoniali, contemplato nell’art. 587 cod. civ., presenti caratteristiche omogenee, con la conseguenza che, in entrambi i campi, al termine “disposizione” dovrebbe essere attribuito il medesimo significato.
[62] Trib. Catania, 28 marzo 2000, cit., p. 1114.
[63] Accanto alla teoria tradizionale dell’onere come elemento accessorio e accidentale del negozio giuridico, si è sviluppata la tesi moderna del modus come negozio autonomo. Quest’ultimo orientamento sarebbe confermato dalle previsioni legislative dalle quali risulta la cosiddetta ambulatorietà dell’onere (artt. 676, comma 2, 677, commi 2 e 3, cod. civ.). Sul punto, G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., p. 899 ss.; M. Garutti, Il modus testamentario, Napoli, 1990, p. 1 ss.; M. Giorgianni, Il “modus” testamentario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, II, p. 889 ss.
[64] Numerosi interpreti, al fine di restare fedeli alla tradizionale concezione attributiva del testamento, hanno ricondotto la figura dell’assegno divisionale semplice entro lo schema del legato obbligatorio. Altri, invece, hanno preferito ricorrere allo schema del modus. Sul punto, G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., p. 1444.
[65] Per un esame delle disposizioni citate, v. M. Bin, op. ult. cit., p. 227 ss.; M. Corona, Funzione del testamento e riconducibilità della disposizione di esclusione del successibile ex lege (non legittimario) all’assegno divisionale semplice c.d. indiretto, cit., p. 35 ss.; Id., La c.d. diseredazione: riflessioni sulla disposizione testamentaria di esclusione, cit., p. 520 ss.; D. Pastore, Riflessioni sulla diseredazione, cit., p. 1196.
[66] In tal senso, Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, cit. Cfr. anche G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., p. 746, che le definisce come disposizioni complementari, aventi carattere accessorio rispetto all’istituzione di erede e al legato.
[67] F.M. Bandiera, Sulla validità della diseredazione, cit., p. 406; A. Pinna Vistoso, cit., p. 14.
[68] Così M. Bin, op. ult. cit., p. 243 ss. D’altro canto, se ci si limitasse a un’interpretazione puramente letterale del combinato disposto degli artt. 587, primo comma, e 588, primo comma, cod. civ., si perverrebbe all’assurda conclusione di includere nel contenuto del testamento il solo legato ad effetti reali, il quale ha ad oggetto diritti del testatore, e di escludere il cosiddetto legato obbligatorio, ossia il legato che pone a carico dell’onerato un’obbligazione e che fa sorgere a favore del legatario il diritto (di credito) di esigere la prestazione.
[69] Cfr. M. Bin, op. ult. cit., pp. 238 e 239; A. Burdese, Le successioni. Parte generale, cit., p. 83 G. Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1198, secondo il quale «la esclusione può anche attuarsi ove il testatore si limiti a dire che a favore di quel soggetto determinato non debba avere luogo alcuna devoluzione. E sarà questa, ovviamente, ove così contenuta una disposizione che si limiterà a restringere le persone che possono aver diritto alla devoluzione della successione, senza fare anche concretamente attribuzione dei bei dell’asse ereditario; e all’attribuzione, mancando quella testamentaria, provvederà la legge con le norme della devoluzione ab intestato, eliminandosi dai destinatari dell’asse quelli esclusi dal de cuius».
[70] Secondo L. Bigliazzi Geri, Il testamento, cit., pp. 138 e 139, l’autonomia testamentaria potrebbe manifestarsi anche nel non voler disporre a favore di una determinata persona. Pertanto, anche nella clausola di diseredazione sarebbe ravvisabile una precisa volontà, con la peculiarità che si tratterebbe di una dichiarazione avente contenuto non positivo, bensì negativo.
[71] Come osserva G. Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., pp. 1200 e 1201, se si negasse efficacia alla clausola di diseredazione, si dovrebbe, coerentemente, ritenere non valido un testamento, il quale, senza contenere disposizioni attributive, si limitasse a revocare le disposizioni testamentarie anteriori. Cfr. anche D. Pastore, Riflessioni sulla diseredazione, cit., p. 1200, E. Ondei, Le disposizioni testamentarie negative, cit., c. 303 e Trib. Catania, 28 marzo 2000, cit., p. 1115.
[72] Sul punto Trib. Parma, 3 maggio 1977, n. 227, cit., pp. 691 e 692, il quale osserva che «la volontà vuole tanto quanto non vuole; che mai si dispone con tanta partecipazione, con tanta penetrazione e caparbietà proprio come quando si dispone negativamente nei confronti di qualcuno».
[73] Così G. Bonilini, Autonomia negoziale e diritto ereditario, cit., p. 789 ss.; A. Trabucchi, L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, cit., p. 48; G. Pfnister, La clausola di diseredazione, cit., p. 918.
[74] In tal senso, D. Morello Di Giovanni, Clausola di diseredazione e autonomia negoziale del disponente, cit., p. 938.
[75] Sul concetto di meritevolezza dell’interesse perseguito, in relazione alla problematica della diseredazione, v. M. Bin, op. ult. cit., p. 204 ss. V. anche Trib. Catania, 28 marzo 2000, cit., p. 1114.
Osserva G. Porcelli, Autonomia testamentaria ed esclusione di eredi, cit., p. 59 che un altro rilievo sembra ancor più decisivo: «è noto che nel diritto successorio si ammette pacificamente – salvo ovviamente il caso che la relativa clausola non si risolva in una condizione impossibile o illecita – la disposizione con cui il testatore ponga a titolo di “pena” a carico dell’erede o del legatario inadempienti una certa prestazione a favore di un determinato soggetto o, addirittura, preveda a carico del trasgressore, per l’ipotesi di comportamento difforme da quello previsto, una riduzione del lascito e persino la decadenza integrale dallo stesso. Non si vede, quindi, perché tale finalità sanzionatoria non possa esser perseguita attraverso una disposizione negativa, cioè non attributiva di beni».
[76] Sul punto F. Corsini, Appunti sulla diseredazione, cit., p. 1107, nota n. 33.
[77] M. Corona, Funzione del testamento e riconducibilità della disposizione di esclusione del successibile ex lege (non legittimario) all’assegno divisionale semplice c.d. indiretto, cit., p. 53 ss.; Id., La c.d. diseredazione: riflessioni sulla disposizione testamentaria di esclusione, cit., p. 532 ss. L’Autore precisa che la diseredazione e l’assegno divisionale semplice indiretto potrebbero anche coincidere sul piano concreto, nell’ipotesi in cui, al momento dell’apertura della successione, il patrimonio ereditario fosse costituito esclusivamente dai cespiti contemplati nell’assegno.
[78] Così M. Corona, Funzione del testamento e riconducibilità della disposizione di esclusione del successibile ex lege (non legittimario) all’assegno divisionale semplice c.d. indiretto, cit., p. 54.; Id., La c.d. diseredazione: riflessioni sulla disposizione testamentaria di esclusione, cit., p. 534.
[79] In proposito, F. Corsini, Appunti sulla diseredazione, cit., p. 1112, nota n. 47. Cfr. anche D. Russo, La diseredazione, cit., p. 173, nota n. 168, il quale osserva che, mentre la diseredazione implica l’esclusione dalla successione, l’assegno divisionale negativo, invece, determina l’esclusione relativamente a singoli beni ereditari.
[80] Così M. Ieva, Manuale di tecnica testamentaria, cit., p. 32.
[81] Cfr. Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, cit.; Cass., 23 novembre 1982, n. 6339, cit.; App. Cagliari, 5 dicembre 1990, n. 302, cit.; Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2000, cit.; App. Catania, 28 maggio 2003, cit., così massimato «ai sensi dell’art. 587 comma 1, c.c., il testatore può validamente escludere dall’eredità, in modo implicito o esplicito, un erede legittimo, purché non legittimario, a condizione però che la scheda testamentaria contenga anche disposizioni positive, rivolte cioè ad attribuire beni ereditari ad altri soggetti, nella forma dell’istituzione di erede o del legato. È, quindi, nullo per illecita della causa il testamento con il quale il de cuius diseredi tutti i suoi parenti (non legittimari) di ogni ordine e grado, qualora dall’interpretazione della scheda testamentaria non risulti che il testatore, nel manifestare espressamente la volontà di diseredare i suoi successibili, abbia inteso – anche implicitamente – attribuire, al contempo, le proprie sostanze allo Stato»; Cass., 18 giugno 1994, n. 5895, cit., secondo la quale «la volontà di diseredazione di alcuni successibili può valere a far riconoscere una contestuale volontà di istituzione di tutti gli altri successibili non diseredati solo quando, dallo stesso tenore della manifestazione di volontà o dal tenore complessivo dell’atto che la contiene, risulti la effettiva esistenza della anzidetta autonoma positiva volontà del dichiarante, con la conseguenza che solo in tal caso è consentito ricercare, anche attraverso elementi esterni e diversi dallo scritto contenente la dichiarazione di diseredazione, l’effettivo contenuto della volontà di istituzione».
[82] Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, più volte citata. Il fatto originario è la scheda testamentaria olografa del seguente contenuto: «nelle mie piene facoltà mentali e in perfetta salute dichiaro, qualora io dovessi mancare, di escludere dalla mia eredità, e cioè da tutto quello che io posseggo, le mie due nipoti [...], per il loro indegno comportamento verso di me e dei miei fratelli». Nel caso di specie la scheda testamentaria fu impugnata per errore sul motivo del comportamento indegno. Nel corso del giudizio di primo grado il tribunale, come si evince leggendo il testo di tale sentenza, affrontò la questione preliminare del valore della scheda come vero e proprio testamento e concluse che essa aveva le forme del testamento olografo ma non poteva considerarsi tale in quanto esso conteneva la sola diseredazione e non disposizioni di carattere attributivo. Conseguentemente, si concluse per l’apertura della successione ex lege in quanto la scheda testamentaria, mancante di una espressa istituzione di erede, era inidonea a realizzare lo scopo proprio della successione previsto dall’art. 537 del codice civile.
La Corte di Appello di Torino, invece, riforma non solo le conclusioni del giudice di primo grado ma ribalta il ragionamento logico-giuridico espresso in tale sentenza. La corte conclude per una chiamata a favore dei soli fratelli con esclusione delle nipoti ex fratre.
[83] Sul punto, F. Santoro – Passarelli, Vocazione legale e vocazione testamentaria, cit., p. 200, nota n. 27; A. Torrente, voce: “Diseredazione, c) diritto vigente”, cit., p. 102 e 103; A.C. Jemolo, La diseredazione, cit., p. 505; F. Miriello, In margine alla clausola di diseredazione: la tematica della c.d. volontà meramente negativa, cit., p. 744.
[84] Qualche esempio può essere utile al fine di comprendere la tesi in esame. Se il testatore scrivesse “dei miei tre fratelli escludo solo Sempronio”, la clausola sarebbe valida. Si avrebbe, infatti, una disposizione negativa dalla quale potrebbe oggettivamente dedursi un’implicita volontà del testatore di istituire eredi gli altri soggetti. In altri termini, il testatore effettuerebbe un’istituzione positiva implicita, la quale troverebbe una chiara base testuale nella dichiarazione di esclusione.
A diversa conclusione si dovrebbe pervenire qualora la scheda testamentaria contenesse le espressioni di cui si è già fatto cenno del tipo “diseredo mio fratello Sempronio”, “escludo Sempronio dalla mia successione”, “voglio che Sempronio nulla riceva dalla mia eredità”. In tal caso, infatti, dal testamento risulterebbe soltanto la volontà di escludere un successibile ab intestato e non vi sarebbe alcun appiglio testuale per giustificare un’attribuzione positiva a favore di altri soggetti.
[85] Per un esame della tesi de qua, v. M. Bin, op. ult. cit., p. 16 ss, secondo il quale la congettura per la quale ogni disposizione d’esclusione sottintende sempre una volontà d’istituzione implicita e per relationem presenta limiti insormontabili, non tanto sotto il profilo della sua o validità quanto per l’assorbente considerazione che l’unico intento del testatore è d’impedire la vocazione del diseredato, essendogli indifferente chi succederà al suo posto. Inoltre, se si ammettesse l’istituzione implicita, si compirebbe «un vero attentato alla volontà testamentaria», ove si ponga mente al fatto che, in tal modo, l’efficacia della clausola diseredativa sarebbe condizionata alla persistenza ed attuazione dell’istituzione ad essa compenetrata, con l’ulteriore conseguenza che in qualsiasi caso di caducità dell’implicita chiamata, l’intera disposizione dovrebbe perdere effetto, onde, a seguito dell’apertura della successione legittima, anche l’escluso possa sulla base della vocazione ex lege concorrere all’eredità.
[86] D. Morello Di Giovanni, Brevi cenni sul tema della diseredazione, in Vita not., 1999, II, p. 1093, mette in luce le differenze tra Cass., 20 giugno 1967, n. 1458 e Cass., 18 giugno 1994, n. 5895: nella prima sentenza, la Cassazione ha sancito la necessità di una valutazione caso per caso, volta a verificare la sussistenza di un’implicita volontà di istituire i soggetti non esclusi; nella seconda, invece, la Suprema Corte, in base al principio di conservazione del negozio ex art. 1367 cod. civ., ha riconosciuto, comunque, la validità della scheda testamentaria, anche qualora sia dubbia l’effettiva volontà del de cuius.
[87] Sull’interpretazione della volontà testamentaria, G. Azzariti, Le successioni e le donazioni, cit., p. 427 ss.; G. Baldisserotto – G. P. Belloni Peressutti – U. Giacomelli – M. Magagna – U. Vincenti – G. Zanon, La ricostruzione della volontà testamentaria. Il contenuto, i vizi, la simulazione, l’interpretazione, a cura di U. Vincenti, Padova, 2005, p. 399 ss.; E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, (Ristampa corretta della II edizione), Napoli, 1994, p. 356 ss.; L. Bigliazzi Geri, Il testamento, cit., p. 77 ss.; Id., Il testamento, I) Profilo negoziale dell’atto: appunti delle lezioni, cit., p. 168 ss.; G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., p. 217 ss.; Id., Nozioni di diritto ereditario, Torino, 1993, p. 131 ss.; G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., p. 758 ss.; R. Carleo, L’interpretazione del testamento, in Tratt. dir. succ. e donaz. diretto da G. Bonilini, Volume II: la successione testamentaria, Milano, 2009, p. 1473 ss.; P. Rescigno, Interpretazione del testamento, Napoli, 1952, p. 1 ss.; G. Tamburrino, voce: “Testamento, b) Diritto privato”, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, p. 476 ss.
[88] Cfr. Cass., 21 febbraio 2007, n. 4022, in Notariato, 2007, p. 497 ss., secondo la quale, nell’interpretazione del testamento, il giudice deve accertare, secondo il principio ermeneutico di cui all’art. 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del defunto. A tal fine, l’interprete deve considerare, congiuntamente e in modo coordinato, l’elemento letterale e quello logico, salvaguardando il rispetto del principio di conservazione della volontà testamentaria.
Ai sensi della prima disposizione citata, l’interprete deve verificare quale sia stata l’intenzione dell’ereditando, senza limitarsi al senso letterale delle sue parole, valutando il suo comportamento complessivo, anche posteriore all’atto di ultima volontà. Al riguardo, l’interprete, qualora dal tenore letterale del testamento non sia ricostruibile in modo certo la volontà del de cuius, può utilizzare non soltanto elementi intrinseci alla scheda, ma anche elementi estrinseci; tuttavia considerata la pretesa irrilevanza delle manifestazioni non formali della volontà testamentaria, è discusso se sia ammissibile l’utilizzo di elementi interpretativi estrinseci alla scheda. Certamente, è possibile fare ricorso a questi ultimi qualora essi valgano a chiarire la volontà espressa nell’atto di ultima volontà. Non è altrettanto certo, invece, se l’interprete possa ricorrere agli elementi estranei, anche nel caso in cui il testo della scheda risulti già chiaro.
Già in precedenza (tra le altre: Cass., 30 maggio 1987, n. 4814 in Mass. Giur. it., 1987; Cass., 21 gennaio 1985, n. 207, in Giur. it., Rep., 1985, voce «Successione legittima e testamentaria», n. 71; Cass., 28 agosto 1986, n. 5278, in Mass. Giur. it., 1986; Cass., 28 febbraio 1972, n. 595, in Giur. it., 1973, I, p. 954; Cass., 28 marzo 1962, n. 628, in Giust. civ., 1962, p. 1736) la Suprema Corte si era espressa nel senso dell’applicabilità all’atto di ultima volontà dell’art. 1367 c. c. (contra Trib. Napoli, 14 marzo 1958, in Dir. e Giur., 1958, p.798), sottolineando, tuttavia, da un lato la sussidiarietà del principio che opera solo quando non sia chiaramente identificabile la volontà del de cuius (così Cass., 5 febbraio 1969, n. 368, in Mass. Giur. it., 1969); dall’altro, l’impossibilità di farvi ricorso per sanare una disposizione nulla (Cass., 19 febbraio 1962, n. 391, in Giust. civ., 1962, I, p. 631; Cass., 17 maggio 1969, n. 1701, in Giur. it., 1970, I, c. 748; Cass., 10 aprile 1969, n. 1160, Giur. it., 1970, I, 1, c. 1251 con nota di E. Perego, Principio di conservazione e «favor testamenti»), atteso che, in tal caso, sarebbe tutelata non tanto la volontà del testatore quanto operata una frode alla legge (Cass., 7 ottobre 1974, n. 2632, in Giust. civ., 1975, I, p. 46). In senso affermativo anche la prevalente dottrina: P. Rescigno, Interpretazione del testamento, cit., passim; A. De Cupis, Il principio di conservazione nell’interpretazione dei testamenti, in Dir. e giur., 1947, p. 81; R. Triola, L’interpretazione dei testamenti, in Vita not., 1977,1008; E. Perego, Interpretazione del testamento e norme sull’interpretazione sui contratti, in Foro pad., 1970, I, 547-48, p. 547; Id., Principio di conservazione e «favor testamenti», cit., in cui, peraltro, l’A., pur riconoscendo l’operatività del principio di conservazione in materia testamentaria, esclude che esso costituisca applicazione del favor testamenti, ritenendolo, invece, espressione di «un’esigenza di economia giuridica, per la quale magis valeat, quam pereat; sull’argomento, amplius, Id., Favor legis e testamento, cit., p. 74 e ss. Contra: G. Gallo, Limiti all’applicabilità al testamento delle norme di ermeneutica riguardanti il contratto, in Giur. compl. Cass. Civ., 1950, III, p. 544; A. Cicu, Il testamento, Milano, 1951, p. 120, per il quale il principio di conservazione è incompatibile con la volontà testamentaria, perché fondato sull’affidamento pacificamente estraneo ai contratti; G. Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961, p. 37, a parere del quale «il principio di conservazione in materia testamentaria contrasta con la circostanza che oggi non vale più il principio per cui non si può morire intestati e con l’altra circostanza che la mancanza di una disposizione del de cuius apre la via alla successione legittima».
Sul punto anche, C.M. Bianca, Diritto civile, 2. La famiglia – Le successioni, cit., p. 742; M. Quargnolo, Pluralità di testamenti, revoca per incompatibilità e interpretazione, in Riv. dir. civ., 2004, I, p. 913 ss.; P. Trimarchi, Interpretazione del testamento mediante elementi a esso estranei, in Giur. it., 1956, I, 1, c. 445 ss.
[89] Cass., 18 giugno 1994, n. 5895, cit.; sul punto anche Cass., 23 novembre 1982, n. 6339, cit.
[90] Cfr. M. Bin, op. ult. cit., p. 18; L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima, cit., p. 25; D. Russo, La diseredazione, cit., p. 24 e ss.
[91] Sul concetto di relatio formale e sostanziale, v. G. Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 87 ss. Con l’espressione “relatio formale”, si allude all’ipotesi in cui la volontà negoziale del testatore sia compiutamente individuata in tutti i suoi principali elementi e l’autore rinvii a una fonte esterna per la determinazione dell’oggetto o del soggetto della successione. Più precisamente, l’ereditando effettua, attraverso la disposizione per relationem puramente formale, un rinvio a fatti e circostanze, i quali richiedono una mera attività di accertamento. Sul punto M. Allara, Il testamento, Padova, 1936, p. 2525 e G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., p. 721 ss..
Con la formula “relatio sostanziale”, invece, si intende il caso in cui il testatore rimetta alla volontà altrui la determinazione del soggetto o dell’oggetto della vicenda successoria. Si tratta, in altri termini, dell’ipotesi in cui la stessa determinazione volitiva del disponente, relativa all’individuazione dell’oggetto del lascito o della persona del beneficiario, sia rimessa alla volontà di un soggetto estraneo. G. Capozzi, op. ult. cit., p. 722.
[92] Si pensi a espressioni del tipo “dispongo delle mie sostanze come per legge” o “voglio che dei miei beni si faccia la ripartizione come per legge”. È discusso se, nel caso considerato, si apra la successione testamentaria o quella legittima. Il problema della coincidenza della vocazione testamentaria con quella legittima è affrontato da L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima, cit., p. 26 ss. L’Autore tiene distinta l’ipotesi del rinvio all’intero regolamento legale della successione (es.: “dispongo delle mie sostanze come per legge”) da quella in cui il testatore istituisca gli stessi successibili ex lege in quote corrispondenti a quelle intestate (es.: il testatore, privo di coniuge, nomina eredi i propri figli in parti uguali).
[93] Ciò si verificherebbe qualora la volontà del testatore fosse diretta a istituire come suoi eredi legittimi persone da lui conosciute al momento della redazione dell’atto. L’onere di provare la mancata conoscenza, da parte del testatore, della disciplina legale oggetto di rinvio graverebbe sul soggetto interessato a far valere l’inefficacia della diseredazione. Cfr. M. Bin, op. ult. cit., p. 22, nota n. 30, il quale sottolinea l’estrema difficoltà pratica di tale prova.
[94] Cfr. M. Bin, op. ult. cit., p. 20 ss.
[95] La tesi dell’istituzione implicita è stata considerata “ibrida e inappagante”. Così, testualmente, L. Bigliazzi Geri, Delle successioni testamentarie, cit., p. 96; Id., Il testamento, cit., pp. 137 e 138; Id., Il testamento, I) Profilo negoziale dell’atto: appunti delle lezioni, cit., p. 275. Per la critica alla teoria in esame, cfr. anche M. Bin, op. ult. cit., p. 18 ss.; L. Ferri, L’esclusione testamentaria di eredi, cit., p. 244 ss.; Id., Se debba riconoscersi efficacia a una volontà testamentaria di diseredazione, cit., c. 52 ss.
[96] F. Corsini, Appunti sulla diseredazione, cit., p. 1103.
[97] Secondo parte della dottrina, una clausola del tipo “Dispongo delle mie sostanze come per legge” sarebbe inutile. Mancando una particolare volontà testamentaria, tale disposizione sarebbe priva di rilevanza giuridica. Così R. Nicolò, La vocazione ereditaria diretta e indiretta, in Raccolta di scritti, Tomo I, Milano, 1980, pp. 23 e 24, e F. Santoro – Passarelli, Vocazione legale e vocazione testamentaria, cit., p. 202.
[98] Come osserva M. Bin, op. ult. cit., p. 19, nota n. 22, la disposizione di esclusione dalla successione non può essere considerata inutile e priva di rilevanza pratica.
[99] Cfr. M. Bin, op. ult. cit., p. 23; G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., p. 202; L. Ferri, L’esclusione testamentaria di eredi, cit., p. 244 ss.
[100] Così M. Bin, op. ult. cit., p. 27 e, in particolare, nota n. 41. V. anche V. anche Trib. Catania, 28 marzo 2000, cit., p. 1113.
[101] In tal senso, F. Corsini, Appunti sulla diseredazione, cit., p. 1103; C. Saggio, op. cit., p. 1791; G. Porcelli, Autonomia testamentaria ed esclusione di eredi, cit., p. 55, il quale osserva che la presenza di una clausola di diseredazione, soprattutto nel caso in cui esaurisca il contenuto del testamento, precluderebbe al giudice di spingersi oltre l’unico effetto che mira a produrre.
[102] L’osservazione è di M. Bin, op. ult. cit., p. 25. V. anche G. Porcelli, Autonomia testamentaria ed esclusione di eredi, cit., p. 56 e App. Firenze, 9 settembre 1954, cit., c. 53.
[103] M. Bin, op. ult. cit., p. 28 e 29, afferma quanto segue: «se, in altre parole, la disposizione d’esclusione fosse puramente implicita istituzione, l’efficacia della clausola diseredativa sarebbe ovviamente condizionata alla persistenza e attuazione dell’istituzione ad essa compenetrata; e, date le premesse, in qualsiasi caso di “caducità” dell’implicita chiamata, l’intera disposizione dovrebbe perdere effetto».
[104] Sul punto, M. Bin, op. ult. cit., p. 29. Cfr. anche L. Ferri, L’esclusione testamentaria di eredi, cit., pp. 244 e 245, secondo il quale, «se si ammette che la volontà di escludere viva di per se stessa come volontà separata e indipendente dalla volontà di istituire, allora non si può più dire che l’esclusione costituisce un’ istituzione implicita».
[105] Così M. Ieva, Manuale di tecnica testamentaria, cit., p. 32.
[106] Cass., 25 maggio 2012, n. 8352, cit., secondo la quale «È valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la volontà destituiva che può includersi nel “disporre”, di cui all’art. 587, comma 1, c.c. diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni dei successibili e a restringerla così ai non diseredati, costituendo detta clausola di diseredazione espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell’atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione post mortem delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere a una positiva attribuzione di bene, né occorra prova di un’implicita istituzione» (Cassa App. Genova 12 marzo 2007 n. 271).
[107] La fattispecie sulla quale è stata emessa la pronuncia segnalata riguardava una clausola testamentaria nella quale il de cuius aveva escluso dalla propria successione due cugini, senza che nel testamento olografo fossero inserite altre disposizioni. La questione decisa, quindi, riguardava la diseredazione di soggetti a favore dei quali si sarebbe aperta – in assenza di testamento – la successione ab intestato. La Corte pertanto non si è pronunciata in relazione alla successione necessaria.
[108] Cass., 25 maggio 2012, n. 8352, cit., p. 1168, in motivazione.
[109] Cass., 25 maggio 2012, n. 8352, cit., p. 1167, sempre in motivazione.
[110] Cass., 25 maggio 2012, n. 8352, cit., 1168, che in motivazione precisa che «l’articolato sistema delineato dal legislatore permette che il fenomeno devolutivo dei beni e l’individuazione degli eredi e dei legatari possano trovare indistintamente fondamento sia nella legge che nella volontà del testatore. Nel nostro ordinamento, la possibilità di un’attribuzione di beni per testamento, che genera un fenomeno vocativo legale, convive con quella, inversa, di un’istituzione per testamento di eredi, che genera la devoluzione legale dell’asse (o di una sua quota). Una simile convivenza, poi, non può che essere confermata dall’art. 457 c.c., che riconosce farsi luogo alla successione legittima, quando manca in tutto o in parte quella testamentaria, smentendosi dunque una gerarchia di valore tra le due forme del regolamento successorio, e dovendosi invece ricondurre il concorso tra le due vocazioni ad un rapporto di reciproca integrazione».
[111] Allude infatti ad uno “pseudo problema” Trib. Parma 3 maggio 1977, n. 227, cit., p. 692.
[112] I questi termini G. Porcelli, Autonomia testamentaria ed esclusione di eredi, cit., p. 52.
[113] Cass., 25 maggio 2012, n. 8352, cit., p. 1168, sempre nella motivazione.
[114] Cass., 25 maggio 2012, n. 8352, cit., p. 1168, sempre nella motivazione.
[115] Cass., 25 maggio 2012, n. 8352, cit., p. 1168, sempre nella motivazione.
[116] A sostegno della soluzione accolta, anche nella sentenza in commento si osserva che «altre volte, d’altronde, il nostro legislatore ha concepito disposizioni di contenuto certamente patrimoniale, che non implicano attribuzioni in senso tecnico e che possono genericamente farsi rientrare nella nozione di “atto dispositivo” del proprio patrimonio ex art. 587 c.c., comma 1, avendo utilizzato il termine “disposizione” nel senso riferito in questa sede (in materia di dispensa da collazione, di assegno divisionale semplice, di onere testamentario, di ripartizione dei debiti ereditari, di disposizione contraria alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, di disposizione a favore dell’anima e di divieti testamentari di divisione)», Cass., 25 maggio 2012, n. 8352, cit., p. 1168, sempre nella motivazione.
[117] Cass., 25 maggio 2012, n. 8352, cit., p. 1169, sempre nella motivazione.
[118] Cfr. App Firenze, 9 settembre 1954, cit., che affrontò la questione di una scheda testamentaria contenente l’espressione “non posso, mio malgrado, lasciare nulla di ciò che posseggo a mia nipote”. Peraltro, si osservi che, nella controversia in esame, il testatore non aveva neppure disposto di tutti i propri beni, ma aveva soltanto effettuato alcuni legati. I giudici di merito ricostruirono la clausola testamentaria non come mera preterizione, ma come espressa volontà che l’interessata fosse, in ogni caso, esclusa dalla successione legittima. Sul punto si veda anche L. Cavandoli, Clausola di diseredazione e testamento, cit., p. 707 e ss.
[119] Sul punto, M. Bin, op. ult. cit., p. 263 ss.; A. Trabucchi, L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, cit., p. 60 ss.
[120] Cfr. M. Bin, op. ult. cit., p. 266 ss.
[121] Le considerazioni appena effettuate possono essere applicate anche all’istituzione di erede nella quota di legittima. In caso di istituzione nella sola quota di riserva, è necessario stabilire se il disponente abbia inteso, altresì, escludere il legittimario dalla successione ex lege relativa alla porzione disponibile.
Nel caso, invece, di testamento contenente soltanto un legato a favore di un legittimario, secondo la dottrina maggioritaria, il legato, nell’ipotesi considerata, deve intendersi come legato in conto di legittima, con la conseguenza che il legatario potrà concorrere, insieme ad altri eventuali coeredi, nella successione ex lege.
Naturalmente, non vi è margine di dubbio nel caso in cui, dopo aver effettuato un’attribuzione parziale del suo patrimonio a favore di un determinato soggetto, il testatore lo escluda espressamente dalla vocazione ex lege relativa ai beni residui oppure lo pretermetta attraverso l’attribuzione del residuo ad altri soggetti, accompagnata da una serie di sostituzioni a catena.
[122] Così L. Bigliazzi Geri, Delle successioni testamentarie, cit., p. 98; N. Lipari, Autonomia privata e testamento, Milano, 1970, p. 239. Cfr. anche L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima, cit., p. 29, secondo il quale si aprirebbe la successione legittima poiché la disposizione «non si limita a indicare nella legge una fonte estrinseca cui sia affidato solo il compito di designare i termini dell’attribuzione, bensì contiene un rinvio all’intero regolamento legale della successione». In giurisprudenza, v. Trib. Nuoro, 15 settembre 1989, n. 359, cit.; Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2000, cit.; App. Firenze, 9 settembre 1954, cit., c. 53.
[123] Così M. Bin, op. ult. cit., p. 27 e, in particolare, nota n. 41 e p. 135. Secondo Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, cit., un testamento contenente un rinvio alla legge sarebbe valido, integrando un’ipotesi di mera relatio formale. Il testatore, rinviando alla disciplina della successione ex lege, non si affiderebbe a una volontà altrui, ma a fatti e circostanze, costituenti criteri di determinazione dei beneficiari e delle loro quote. Cfr. anche F. Corsini, Appunti sulla diseredazione, cit., p. 1105 e D. Onano, op. cit., p. 590, i quali rilevano la contraddittorietà della sentenza Cass., 18 giugno 1994, n. 5895, cit., che, pur individuando nella clausola di diseredazione un’implicita volontà istitutiva, dichiara aperta la successione legittima anziché quella testamentaria.
[124] V. L. Ferri, Se debba riconoscersi efficacia a una volontà testamentaria di diseredazione, cit., c. 53, per il quale se i non esclusi succedono per legge, non vi sarebbe spazio per una concorrente successione testamentaria: «per poter parlare di concorso di successione legittima e testamentaria occorre che, accanto a chi succede per legge, vi sia qualcuno che succede per testamento e non qualcuno che non succede a causa di testamento».
[125] In dottrina Sul punto v. M. Bin, La diseredazione, cit., p. 255; A. Trabucchi, L’autonomia testamentaria e la disposizione negativa, cit., pp. 49 ss. G. Porcelli, Autonomia testamentaria ed esclusione di eredi, cit., p. 60 e, in particolare, G. Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1202. In giurisprudenza si pronunciano espressamente per l’apertura della successione legittima App. Firenze 9 settembre 1954, cit.; Cass. 14 ottobre 1955, n. 3518, in Giust. civ., 1956, I, p. 252 ss. e Trib. Parma 3 maggio 1977, cit.
[126] Così G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., p. 723.
[127] In ordine alla disciplina applicabile alla diseredazione, v. M. Bin, op. ult. cit., p. 255 ss.
[128] F. Corsini, Appunti sulla diseredazione, cit., p. 1117, nota n. 61, osserva che l’apposizione di una condizione alla diseredazione può condurre al medesimo risultato di un’istituzione sottoposta alla condizione inversa purché vi si ravvisi una diseredazione implicita.
[129] Così G. Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 155.
[130] M. Bin, op. ult. cit., p. 261, accoglie la soluzione in esame per il caso di incapacità del tutore o del protutore (art. 596 cod. civ.), mentre propone una lettura differente per le ipotesi di cui agli artt. 597 e 598 cod. civ., le quali rappresentano una deroga a una serie di disposizioni della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile).
[131] Sul punto, A.D. Candian, La funzione sanzionatoria nel testamento, Milano, 1988, p. 1 ss.
[132] Sull’impiego della diseredazione come clausola penale testamentaria e come clausola di decadenza, v. M. Bin, op. ult. cit., p. 275 ss. In generale, per un esame delle clausole di decadenza, v. G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., p. 866.
[133] Per un approfondito esame della problematica in oggetto, v. A. Cicu, Diseredazione e rappresentazione, cit., p. 385 ss.; C. Saggio, op. cit., p. 1788 ss.; A. Torrente, voce: “Diseredazione, c) diritto vigente”, cit., p. 103; V. Barba, La disposizione testamentaria di diseredazione, cit., p. 785.
[134] Sulla rappresentazione, G. Azzariti, Le successioni e le donazioni, cit., p. 60 ss.; L. Barassi, Le successioni per causa di morte, cit., p. 69 ss.; C. M. Bianca, Diritto civile, 2. La famiglia – Le successioni, cit., p. 587 ss.; G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., p. 63 ss.; Id., Nozioni di diritto ereditario, cit., p. 42 ss.; G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., p. 207 ss.; A. Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell’eredità, Milano, 1954, p. 104 ss.; L. Ferri, Successioni in generale, cit., p. 196 ss.; M. Meloni, Voce: “Rappresentazione”, in Enc. giur. Treccani, XXV, Roma, 1991, p. 1 ss.; E. Moscati, voce: “Rappresentazione, I) Rappresentazione (successione per): c) Diritto privato”, in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, p. 646 ss.; E. Perego, La rappresentazione, in Tratt. dir. priv. diretto da P. Rescigno, Volume 5, Tomo I, Successioni, Torino, 1997, p. 117 ss.; C. Storti Storchi, voce: “Rappresentazione, I) Rappresentazione (successione per): b) Diritto intermedio”, in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, p. 631 ss.; M. G. Zoz, voce: “Rappresentazione, I) Rappresentazione (successione per): a) Diritto romano”, in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, p. 627 ss
[135] Così C. Saggio, op. cit., p. 1792. L’Autore osserva che, con la diseredazione, si ha vera e propria mancanza di designazione, con la conseguente impossibilità di applicare gli artt. 467 ss. cod. civ. Cfr. anche G. Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1203; A. Trabucchi, Esclusione testamentaria degli eredi e diritto di rappresentazione, cit., c. 749 ss.; Id., L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, cit., p. 50 ss.
Cfr. anche D. Russo, La diseredazione, cit., p. 189.
[136] In dottrina, v. L. Bigliazzi Geri, Il testamento, cit., p. 141; M. Bin, op. ult. cit., p. 272 ss; G. Porcelli, Autonomia testamentaria ed esclusione di eredi, cit., p. 61. Si deve osservare, peraltro, che coloro che sostengono l’inammissibilità della clausola di diseredazione propendono per l’operatività della rappresentazione; sul punto L. Ferri, Se debba riconoscersi l’efficacia ad una volontà di diseredazione, cit., p. 47; A. Cicu, Diseredazione e rappresentazione, cit., p. 392; A. Torrente, voce: “Diseredazione, c) diritto vigente”, cit.,p. 103
[137] Così Cass., 14 ottobre 1955, n. 3158, in Giur. it., 1956, p. 138: «quando non sussista un’esplicita manifestazione di volontà contraria, la diseredazione non esclude dall’eredità i successibili del diseredato per rappresentazione»; Cass., 23 novembre 1982, n. 6339, cit.; Cass., 14 dicembre 1996, n. 11195, in Mass. Giust. civ., 1996, p. 1748; App. Firenze, 9 settembre 1954, cit., c. 55; Trib. Parma 3 maggio 1977, n. 227, cit., p. 701.
[138] La diseredazione costituisce un mero ostacolo all’attuazione concreta del regime legale di successione nei confronti del diseredato, rendendo inefficace nei suoi confronti una situazione che, altrimenti, spiegherebbe i suoi effetti. M. Bin, op. ult. cit., p. 273, afferma che la diseredazione «impedisce la vocazione dell’escluso, ma non può eliminare l’astratta designazione contenuta nella legge».
[139] Anche ritenendo che l’istituto della rappresentazione abbia carattere eccezionale, per applicarne la disciplina alla diseredazione non sarebbe necessario ricorrere all’analogia, in quanto l’esclusione dalla successione rientrerebbe nella generica e astratta previsione dell’ascendente che “non può” accettare l’eredità.
Cfr. anche Cass., 23 novembre 1982, n. 6339, cit., che estende alla diseredazione, in via di interpretazione estensiva e non analogica, la disciplina legale dell’indegnità, ai fini della rappresentazione.
[140] Questa obiezione è sollevata da A. Trabucchi, L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, cit., p. 51. È evidente che, per la pretermissione, avendo il testatore attribuito tutti i suoi beni a favore di altri, non si pone nemmeno un problema di rappresentazione (a favore dei discendenti della persona non menzionata).
[141] Il rilievo è di L. Bigliazzi Geri, Il testamento, cit., p. 141, nota n. 62.
[142] Come osserva efficacemente A. Torrente, voce: “Diseredazione, c) diritto vigente”, cit., p. 103, «non si vuole che le colpe degli ascendenti ricadano sui discendenti. Perché mai dovrebbero non la colpa, ma il mero rancore e la semplice antipatia verso l’ascendente, che ben possono costituire il motivo della diseredazione, ripercuotersi sul discendente?».
[143] F. Corsini, Appunti sulla diseredazione, cit., p. 1119.
[144] Così E. Ondei, Le disposizioni testamentarie negative, cit., c. 304. Cfr. anche C. Saggio, op. cit., p. 1795, il quale osserva che la volontà di includere nella successione i discendenti del diseredato non può sic et simpliciter desumersi dalla stessa clausola di diseredazione, ma deve potersi ricavare da qualche indicazione contenuta nella scheda testamentaria e deve essere riconducibile ad un autonomo e cosciente atto di volontà del disponente. Sul punto, v. anche A. Torrente, voce: “Diseredazione, c) diritto vigente”, cit., p. 104, il quale spiega che «occorrerebbe che, nel singolo caso concreto, si dimostrasse la sussistenza di una volontà con un siffatto contenuto, espressione di un animo così esacerbato del de cuius che lo indurrebbe ad estendere la sua avversione non soltanto al soggetto colpito dalla diseredazione, ma anche alla sua stirpe».
[145] C. Ungari-Trasatti, Rassegna di dottrina e giurisprudenza in tema di diseredazione, cit., p. 1329; G. Pfnister, La clausola di diseredazione, cit., p. 928; M. Bin, op. cit., p. 273.
[146] Sul tema, v. E. BERGAMO, Brevi cenni su un’ipotesi di diseredazione anomala implicita, cit., c. 1801 ss.; M. COMPORTI, op. cit., p. 27 ss.; M. QUARGNOLO, Il problema della diseredazione tra autonomia testamentaria e tutela del legittimario, cit., p. 299 ss.
Relativamente a una peculiare ipotesi di diseredazione indiretta di un successore necessario, v. F. GAZZONI, op cit., p. 2522 ss. e S.T. MASUCCI, op. cit., cit., c. 917 ss. Sul punto, v. anche Cass., 19 ottobre 1993, n. 10333, in Giur. it., 1995, I, 1, c. 918 ss., con nota di S. T. MASUCCI, nella quale si afferma che l’azione di riduzione spettante al legittimario non può essere paralizzata dall’eccezione di maturata usucapione ventennale del bene, opposta dal convenuto.
[147] Cfr. Cass., 29 gennaio 2007, n. 1789, in Riv. not., 2008, p. 453 ss., secondo la quale all’interpretazione del testamento, volta a identificare l’effettiva volontà del defunto, si applicano le norme di ermeneutica dettate in materia di contratti, in quanto norme comuni per l’interpretazione dei negozi giuridici, con gli opportuni adattamenti e con esclusione di quelle (artt. 1366, 1368 e 1370 c.c.) incompatibili con la natura di negozio mortis causa propria del testamento medesimo.
Sul punto, v. L. BIGLIAZZI GERI, A proposito di diseredazione, in Corr. giur. 1994, p. 1503; ID, Delle successioni testamentarie, cit., p. 124 ss.; ID, Il testamento, cit., p. 136 ss.; M. QUARGNOLO, Il problema della diseredazione tra autonomia testamentaria e tutela del legittimario, cit., p. 301.
[148] L. Bigliazzi Geri, A proposito di diseredazione, cit.,p. 1503 ss.; C. Cecere, op. cit., p. 1568; A. Torrente, voce: “Diseredazione, c) diritto vigente”, cit., p. 102; D. Russo, La diseredazione, cit., p. 202; R. Cimmino, op. cit., 29; P. Laghi, La clausola di diseredazione: da disposizione «afflittiva» a strumento regolativo della devoluzione ereditaria, Napoli, 2013, p. 128 ss., il quale riconduce la nullità al contrasto con le norme imperative poste a presidio della successione necessaria e, quindi, all’art. 1322, secondo comma, cod. civ., che subordina la validità del negozio giuridico alla meritevolezza degli interessi perseguiti; M. Quargnolo, Il problema della diseredazione tra autonomia testamentaria e tutela del legittimario, cit., p. 302. In giurisprudenza Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, cit.,
[149] L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima, cit., p. 22, nota n. 59; F. Miriello, op. cit., p. 746 ss.
[150] C. Ungari-Trasatti, Rassegna di dottrina e giurisprudenza in tema di diseredazione, cit., p. 1318; . Porrello, op. cit., p. 985; D. Pastore, Riflessioni sulla diseredazione, cit., p. 1188; D. Russo, La diseredazione, cit., p. 198; M. Bin, op. cit., p. 257.
[151] L. Carraro, op. cit., p. 28.
[152] L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima, cit., p. 9. Cfr. C. Ungari-Trasatti, Rassegna di dottrina e giurisprudenza in tema di diseredazione, cit., p. 1318; V. Porrello, op. cit., p. 984;R. Pacia, Validità del testamento di contenuto meramente diserdativo, cit., p. 317.
[153]Cfr. F. Corsini, Appunti sulla diseredazione, cit., p. 1120. Cfr. M. Bin, op. cit., p. 257, secondo cui «per la disposizione di esclusione dalla legittima, i dubbi sono a prima vista autorizzati dal fatto che il nostro legislatore sembra individuare nella riducibilità, e non nella nullità, la sanzione tipica contro le disposizioni testamentarie lesive della porzione di legittima».
In tal senso, G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., p. 201; F. Miriello, op. cit., p. 746; G. Pfnister, La clausola di diseredazione, cit., p. 915; C. Saggio, op. cit., p. 1789.
[154] C. Ungari-Trasatti, Rassegna di dottrina e giurisprudenza in tema di diseredazione, cit., p. 1319; V. Porrello, op. cit., p. 985; R. Pacia, Validità del testamento di contenuto meramente diserdativo, cit., p. 320; V. Occorsio, op. cit., p. 690.
[155]Cfr. M. Di Fabio, In tema di diseredazione (anche) del legittimario, in Riv. not., 2012, p. 1228 ss.; C. Ungari-Trasatti, Rassegna di dottrina e giurisprudenza in tema di diseredazione, cit., p. 1319; G. Pfnister, La clausola di diseredazione, cit., pp. 915-916; F. Corsini, Appunti sulla diseredazione, cit., pp. 1120-1121; C. Saggio, op. cit., p. 1789; G. Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1197. In giurisprudenza, App. Napoli, 21 maggio 1961, cit.; Trib. Nuoro, 15 settembre 1989, n. 359, cit., che osserva che la diseredazione di un legittimario non contrasta con norme imperative, con l’ordine pubblico o il buon costume e la equipara, sotto questo profilo, alla preterizione.
[156]Cfr. D. Pastore, Riflessioni sula diseredazione, cit., p. 1189 ss.
[157] Cfr. G. Capozzi, op. cit., p. 480, secondo cui le eccezioni al principio d’intangibilità della legittima sono: ex art. 713, secondo comma, cod. civ. il testatore può disporre che la divisone di tutta l’eredità (compresa quindi anche la legittima) non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente i cinque anni; ex artt. 733 e 734 cod. civ. è consentito al testatore, rispettivamente di dettare regole per la divisione o di dividere egli stesso i suoi beni tra gli eredi; la c.d. cautela sociniana ex art. 550 cod. civ.; il legato ex art. 551 cod. civ.; il prelegato ex lege del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite, che grava sulla porzione disponibile e qualora non sia sufficiente, per il rimanente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli; la sostituzione fedecommissaria, ex art. 692 cod. civ., che può avere ad oggetto anche beni che costituiscono la legittima dell’istituito; l’istitutio ex re certa ex art. 588, secondo comma, cod. civ. secondo cui è possibile istituire il legittimario erede di beni determinati.
[158] Cfr. R. Senigaglia, Profili funzionali della nuova disciplina della filiazione nel sistema del diritto di famiglia, in Riv. Ephemerides iuris canonici, 2013, p. 79 ss., secondo cui «il profilo di sicura novità introdotto dalla riforma della filiazione sta nel fatto che mentre la diseredazione ammessa dalla Cassazione è quella relativa agli eredi legittimi, escludendo taluno dall’ordine dei chiamati per legge, quella consentita dall’art. 448 bis c.c. opera anche nei riguardi della successione necessaria: il genitore viene escluso non soltanto dalla successione relativa alla quota disponibile, ma pure da quella della quota di riserva. L’esaltazione dell’interesse del figlio trapela dal fatto che il potere di diseredazione per condotte pregiudizievoli tenute nei riguardi del de cuius è riconosciuto dalla legge soltanto al figlio nei confronti del genitore e non viceversa. Il potere di diseredare il genitore resosi responsabile di comportamenti pregiudizievoli si atteggia, quindi, come dicevamo, non soltanto in termini di strumento punitivo di cui dispone il figlio per poter reagire alle condotte del genitore, ma anche come strumento per prevenire la consumazione di fatti pregiudizievoli. Ebbene, ragionando in termini funzionali, il punto debole della previsione di cui all’art. 448 bis c.c., a nostro parere, sta nel fatto che il livello di effettività della funzione punitiva/preventiva rischia di rivelarsi “proporzionale” alla rilevanza del patrimonio del figlio. In altri termini, in presenza di un figlio “povero”, vittima di condotte pregiudizievoli dei genitori, non è ravvisabile in capo agli stessi alcun interesse patrimoniale che possa essere sacrificato con un atto di diseredazione del figlio. Esso, in sostanza, non esplicherà alcuna funzione, né punitiva né preventiva. Viceversa, la previsione normativa funzionerà rispetto al “figlio ricco”, ferma restando la considerazione del dato statistico di morte dei figli prima dei genitori. L’esito è sorprendentemente paradossale giacché la tutela accordata dalla norma diviene in tal modo effettiva in contesti familiari in cui solitamente vige una situazione di agio e non di disagio.
Essa rischia, pertanto, di conoscere pochi momenti di applicazione. In ogni caso, nonostante l’evidente intento del legislatore di voler perseguire la tutela effettiva dell’interesse del figlio, in un’ottica relazionale di giusto bilanciamento degli interessi in gioco riteniamo, de iure condendo, che sarebbe ragionevole consentire anche al genitore che dovesse risultare vittima di comportamenti pregiudizievoli da parte del figlio, di escluderlo dalla propria successione anche relativamente alla quota necessaria».
Cfr. anche ; R. Pacia, Validità del testamento di contenuto meramente diserdativo, in Riv. dir. civ., 2014, p. 322
[159] Cfr. fra tutti: V. Porrello, op. cit., p. 993.
Scarica Articolo PDF