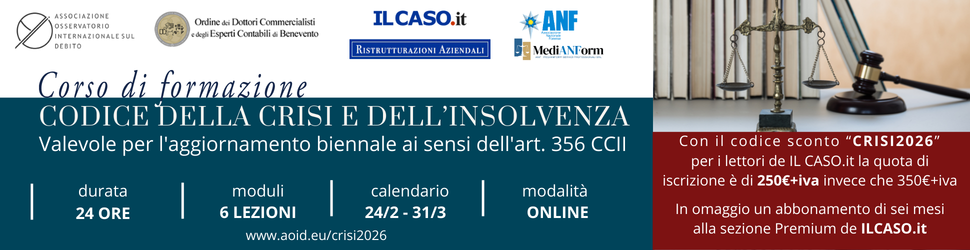Civile
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 28/05/2015 Scarica PDF
Vincoli di destinazione ed interessi meritevoli: dieci anni di confronto ed una soluzione ancora lontana
Luca Vitale, NotaioSommario: 1. Premessa. - 2. Gli orientamenti della dottrina: la tesi estensiva. - 3. segue: la tesi pubblicistica. - 4. segue: la tesi relazionale. - 5. Gli orientamenti della giurisprudenza. - 6. Conclusioni.
1. A distanza di un decennio dalla sua introduzione, la disciplina degli atti di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c. appare un’opera incompiuta e dai contorni ancora incerti.
I problemi che la norma solleva sono ancora molti, legati soprattutto alle divergenti ricostruzioni elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza sulle questioni fondamentali. La sintetica formulazione della disciplina, racchiusa in un unico articolo collocato nel libro VI, costituisce invero la ragione principale dei problemi oggetto del dibattito, legittimando interpretazioni molto diverse.
Tra le questioni sollevate ve n’è una in particolare, dalla quale dipende la portata applicativa della norma, che ancora non trova una soluzione condivisa: la definizione del concetto di meritevolezza.
Tale elemento rappresenta il perno attorno al quale ruota l’intera disciplina, di talché dalla sua esatta qualificazione discende anche l’esatta delimitazione del perimetro normativo. L’art. 2645ter c.c. consente infatti la creazione di un patrimonio separato a condizione che i beni considerati siano destinati esclusivamente al perseguimento di uno scopo “meritevole”.
L’unica indicazione fornita dalla norma per definire tale concetto è rappresentata dal riferimento all’art. 1322 c.c., relativo ai contratti atipici, e sul quale vi è una consolidata interpretazione giurisprudenziale che identifica la meritevolezza con la non illiceità. Di fronte ad un dato testuale incontrovertibile, ci si è interrogati sul valore da attribuire a tale riferimento.
La questione riporta inevitabilmente alla ribalta l’ampio dibattito sull’interpretazione dell’art. 1322 c.c., ed in particolare sul valore della meritevolezza nei contratti atipici e sul rapporto con la causa. Il risultato di tali elaborazioni, frutto di decenni di dibatto, da un lato influenza il giudizio sull’art. 2645 ter c.c., ma dall’altro viene esso stesso influenzato.
Senza addentrarsi nel merito di tali aspetti, occorre segnalare che il percorso interpretativo sviluppato a partire dall’introduzione del nuovo Codice Civile, risulta segnato dal progressivo mutamento del contesto socio-economico. Detta contingenza ha ispirato in maniera chiara le elaborazioni sui concetti di causa del contratto e di meritevolezza degli interessi, come risulta dagli scritti di un illustre autore, nei quali traspare evidente l’influenza dei principi di matrice fascista[1]. Secondo il pensiero espresso da tale Autore, l’autonomia privata avrebbe dovuto esprimersi non solo nel rispetto dei limiti negativi (non contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume), ma anche di quelli positivi, cristallizzati nel riconoscimento del superiore interesse collettivo, espresso, tra gli altri, dal parametro dell’utilità sociale. Al di fuori di detta cornice di valori l’autonomia privata non dovrebbe trovare tutela da parte dell’ordinamento[2].
Detto connotato viene ancora oggi ritenuto da illustri autori elemento qualificante della meritevolezza, che ravvisa l’esigenza di conformare l’autonomia ad un interesse superiore, rispetto al quale mai può porsi in contrasto.[3]
Questa prima opzione ermeneutica, che sembra aver influenzato il Codice attuale, è stata negli anni oggetto di revisione, nonostante un rinnovato interesse da parte di alcuni autori.
Si è assistito in particolare ad un processo di depotenziamento del concetto di meritevolezza, non più legato ad un’esigenza di indirizzo dell’attività privata verso un superiore interesse statale, ma animato da nuove idee “liberal-democratiche”[4]. Tale opera di ridimensionamento ha condotto ad una sostanziale identificazione con i requisiti di liceità[5].
Nel medesimo percorso di revisione si inserisce anche la posizione di altra dottrina che riconosce alla meritevolezza la funzione di soglia di rilevanza e di idoneità dell’atto a vincolare le parti[6].
A conclusioni analoghe perviene anche la giurisprudenza pressoché unanime, sovrapponendo i giudizi di liceità e di meritevolezza, e relegando ad un’ipotesi di scuola a configurabilità di un contratto lecito ma immeritevole[7].
Dette elaborazioni costituiscono il terreno su cui poggia il dibattito relativo all’art. 2645 ter c.c., il quale dispone che «gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo. »
La norma, ad una prima lettura, sembra imporre una selezione delle finalità idonee a legittimare l’effetto di segregazione patrimoniale, in ragione del sacrificio degli speculari interessi dei terzi, pregiudicati dalla diminuita garanzia offerta del debitore-disponente (titolare del patrimonio separato). Appare pertanto opportuna una cernita degli scopi, ancor più in considerazione della specifica tutela che l’ordinamento riconosce proprio ai creditori con l’art. 2740 c.c., espressione del principio di responsabilità patrimoniale illimitata. Tale rilievo è stato enfatizzato da una parte degli interpreti che hanno ritenuto imprescindibile, ai fini di un giudizio di meritevolezza, una rigorosa e stringente valutazione degli interessi.
La pratica applicativa ha confermato l’importanza assunta da dette questioni, tornate nuovamente all’attenzione del dibattito anche a seguito di recenti arresti giurisprudenziali. Tuttavia, sia in dottrina che in giurisprudenza, si registra una notevole incertezza interpretativa, ed allo stato attuale non può dirsi sussistere un orientamento prevalente.
Ciò premesso, con il presente lavoro si tenterà di ricostruire il quadro delle soluzioni proposte ed individuare, nei limiti del possibile, quelle che appaiono maggiormente condivisibili.
2. Nel rinnovato dibatto sulla destinazione patrimoniale la definizione del concetto di meritevolezza ha assunto un ruolo centrale, e le ricostruzioni interpretative elaborate dalla dottrina si possono sinteticamente enucleare in due gruppi: da un lato vi sono quelle cd. estensive, per le quali ogni interesse lecito giustificherebbe una separazione patrimoniale; dall’altro quelle cd. restrittive, secondo cui sarebbe invece necessario un quid pluris.
La distinzione tra queste categorie è certamente quella di maggior rilievo, ma non è la sola. L’ambito delle teorie restrittive comprende infatti ricostruzioni dagli esiti più sfumati, divergenti in punto di determinazione circa l’elemento ulteriore. In quest’ultimo gruppo ricomprendiamo le tesi cd. pubblicistiche e quelle cd. relazionali[8].
Il primo elemento sul quale si è posta l’attenzione degli interpreti è il rinvio all’art. 1322 c.c. operato dalla norma, ponendo l’interrogativo se, in ragione di tale dato testuale, gli atti di destinazione dovessero connotarsi negativamente, per l’assenza di profili di illiceità, ovvero positivamente, attraverso la necessaria la presenza di un elemento che li rendesse socialmente meritevoli, riproponendo l’antico dibattito emerso in occasione della codificazione.
La risposta a tale quesito è strettamente legata anche alla soluzione che si da all’ulteriore interrogativo circa l’esistenza, nel nostro ordinamento, di una categoria negoziale caratterizzata da un grado di meritevolezza più intenso di quello previsto in generale per i negozi atipici.
Orbene, secondo parte della dottrina[9], ai fini della presente indagine non potrebbe prescindersi dall’interpretazione di tale art. 1322 c.c. fornita della giurisprudenza di Cassazione, secondo cui la meritevolezza assume il significato di non illiceità, ossia di non contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico ovvero al buon costume[10].
Il valore di tale rinvio emerge anche dal contenuto del parere espresso dalla Commissione Permanente di Giustizia che ha preceduto l’adozione del decreto legge 273/2005[11], nel quale si da conto dell’inequivoca posizione della giurisprudenza sul punto. Dunque il riferimento non sarebbe casuale, ma avrebbe un preciso significato, esprimendo la chiara volontà di impiegare il filtro di liceità anche in questo ambito, senza che ne venga ridotta la portata dell’art. 2645ter c.c.[12].
Ulteriormente, ragionando a contrario, ci si è chiesti, qualora gli si assegnasse un significato più ampio del riferimento alla mera liceità, chi fosse deputato ad effettuare il relativo controllo. Sia che si demandi al giudice o al notaio tale compito la norma verrebbe snaturata, poiché si attribuirebbe ad un soggetto il compito di effettuare una valutazione comparatistica (come sostenuto da altra dottrina) che, invece, dovrebbe esprimersi semplicemente in termini di liceità[13].
Gli unici parametri a cui ci si dovrebbe attenere sarebbero pertanto il rispetto delle norme inderogabili, dei principi di ordine pubblico e del buon costume. Il controllo di essi consumerebbe in toto la valutazione relativa alla meritevolezza.
Detta soluzione viene suffragata dal rilievo che l’atto di destinazione ad uno scopo rappresenterebbe di per se un tipo legale[14], pertanto sarebbe ingiustificata una diversa applicazione rispetto all’art. 1322 c.c..
Focalizzando invece l’attenzione sulle categorie soggettive, al quale l’interesse deve riferirsi, un Autore ha rilevato come l’erronea convinzione della necessaria connotazione solidaristica, proposta dai primi commentatori, dipenda proprio da ciò[15]. Infatti, si adduce, l’elemento tipizzante è sempre l’interesse dell’autore della destinazione e mai quello soddisfatto dal beneficiario attraverso la destinazione, per cui deve ritenersi priva di fondamento una ricostruzione che tenti di legare lo scopo con il particolare interesse di un soggetto disabile. Quest’ultimo può costituire soltanto il motivo per cui il conferente decide di realizzare la destinazione, ma non si identifica con lo scopo perseguito dall’autore, il quale non deve caratterizzarsi per particolari profili di utilità sociale. A dimostrazione di ciò si osserva che il Legislatore ha previsto, oltre alla categoria dei disabili e delle pubbliche amministrazioni, anche quella generiche degli “enti o persone fisiche”, quali che esse siano, a prescindere dalle relative situazioni o condizioni soggettive.
L’equivoco generato da una discutibile indicazione delle categorie soggettive è stato evidenziato anche da altri autori che ne hanno tuttavia circoscritto la rilevanza, ribadendo la primazia dello scopo rispetto ai soggetti. Da tale premessa si è giunti finanche ad affermare la legittimità di una destinazione a beneficio dello stesso conferente, non essendo escluso da alcuna disposizione[16].
Ogni tentativo di restringere l’ambito della norma si scontrerebbe inoltre con il principio di libertà negoziale ribadito attraverso il richiamo all’art. 1322 c.c.[17], per cui, secondo la tesi esposta, non si può condividere la pretesa graduazione degli interessi, onde poterne valutare la prevalenza rispetto a quello dei creditori o alla libera circolazione dei beni[18]. In altri termini, il Legislatore avrebbe già effettuato detta comparazione prevedendo il sacrificio degli interessi da ultimi menzionati.
Non è priva di rilievo l’ulteriore considerazione di ordine sistematico per cui le medesime finalità perseguibili attraverso l’art. 2645 ter c.c. possono essere raggiunte anche attraverso l’istituto del trust, il cui limite è rappresentato esclusivamente dalla non contrarietà all’ordine pubblico. Riconoscere ai vincoli di destinazione requisiti più stringenti per la loro efficacia apparirebbe incongruo.[19]
Tuttavia, se da un lato si respinge con fermezza ogni tentativo di comprimere concetto di meritevolezza, intesa come liceità, dall’altro lato emergono ugualmente sfumature in ordine alla possibilità di individuare soglie di rilevanza dell’interesse più qualificate. Ed è così che, accanto alla liceità dell’interesse, si affianca anche il parametro della ragionevolezza della destinazione[20], ovvero della prevalenza sull’interesse economico generale[21].
3. La tesi ora esposta è stata oggetto di varie critiche, la più calzante delle quali ha evidenziato che in tal modo si consentirebbe una deroga al principio di responsabilità patrimoniale, consacrato dall’art. 2740 c.c., anche per il perseguimento di interessi meramente futili, stravaganti o vani, di talché la norma risulterebbe sospettabile di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost..[22]
Forse proprio il timore di un’incontrollabile apertura all’uso (ed abuso) della norma, in virtù di una lettura estensiva, ha spinto una parte della dottrina ad interpretare la disposizione in maniera più restrittiva, convinta che un interesse semplicemente non illecito non possa prevalere un interesse di rilievo costituzionale.[23] All’interno di questa categoria possono ascriversi tutte quelle interpretazioni secondo le quali l’interesse ammesso dovrebbe avere un quid pluris, tale da giustificare il sacrificio dei creditori, connotato da pubblica rilevanza.[24]
Secondo un primo orientamento, il riferimento all’art. 1322 c.c. andrebbe interpretato adeguandolo alla specifica norma cui si riferisce. In tal senso, pur rilevando che l’indicazione dei soggetti così com’è non consente di circoscrivere l’ambito degli interessi entro confini determinati, sono stati ritenuti meritevoli solo quelli connotati da pubblica utilità[25], analogamente a quanto richiesto per la costituzione di una fondazione. Sul piano funzionale l’atto di destinazione sarebbe dunque da accostare all’atto di fondazione[26], in relazione al quale il notaio viene già investito dell’importante compito di filtro degli interessi. Una simile soluzione godrebbe inoltre del vantaggio di ancorare il giudizio di meritevolezza su criteri noti e conoscibili in anticipo, riducendo l’inconveniente (ed il limite) di una destinazione i cui effetti sono incerti e precari, sottoposti all’esito di un eventuale giudizio in sede contenziosa.
Dall’ambito così delineato resterebbero escluse le destinazioni realizzate mediante un contratto oneroso, in quanto animate da un interesse lucrativo, così come lo sarebbero quelle con causa solutoria, mentre ben potrebbe rientrarvi un contratto a favore di terzo. Tale principio si estende fino ad estromettere anche le ipotesi in cui il conferente, pur non conseguendo un corrispettivo immediato, persegue comunque lo scopo di ottenere un vantaggio indiretto dall’attribuzione patrimoniale, in modo da bilanciare il depauperamento.[27]
Detta tesi viene suffragata anche sulla base di ulteriori ed autorevoli considerazioni.
In primo luogo si evidenzia che la durata del vincolo, potendosi estendere fino a novanta anni, suggerisce la riferibilità della destinazione all’interesse di terzi diversi dal conferente[28]. Il beneficio a questi rivolto si pone dunque quale strumento per soddisfare uno scopo superiore, che trascende la persona, e solo in tal modo trova tutela da parte dell’ordinamento.
In secondo luogo, facendo leva su un argomento di carattere sistematico, si sottolinea che già altrove il requisito di pubblica utilità viene impiegato per giustificare la compressione di diritti di rango superiore, legittimando limitazioni di responsabilità o deroghe a divieti espressione del principio di libera circolazione[29].
In terzo luogo, differentemente da altre fattispecie destinatorie ove i creditori sono muniti di strumenti di tutela, nell’ambito dell’art. 2645ter c.c. la rigorosa selezione degli interessi costituirebbe l’unico mezzo a difesa delle proprie ragioni.[30]
Tuttavia l’orientamento testé esposto si espone inevitabilmente ad alcune calzanti osservazioni critiche, la prima delle quali rileva l’assenza di dati testuali dai quali desumere l’identità del concetto di meritevolezza con quello di pubblica utilità[31]. Se da un lato appare fondata l’esigenza di selezionare gli interessi rilevanti, meno lo è il risultato a cui giungerebbe tale ricostruzione.
Si obietta inoltre che il riferimento alle fondazioni, quale paradigma principale, sarebbe in contrasto con l’attuale disciplina relativa al riconoscimento giuridico delle stesse (art. 1 D.p.r. 361/2000), ove è richiesto esclusivamente la “liceità dello scopo” e “l’adeguatezza patrimoniale”[32]. Infatti quest’ultime possono perseguire interessi privi del connotato pubblicistico, e di ciò sarebbe prova il proliferare di fondazioni con scopi ben lontani da quelli originariamente immaginati dal Legislatore[33].
Nonostante le perplessità enunciate, la tesi esposta viene ribadita anche da altri autori che alzano ulteriormente la soglia della meritevolezza, esaltando il profilo soggettivistico della norma, sino ad affermare l’essenzialità di talune categorie di soggetti considerate (disabili e pubbliche amministrazioni), tanto da permeare l’intera disciplina.[34]
In linea con tale posizione si pone quella dottrina che interpreta la meritevolezza alla stregua della solidarietà sociale, il cui ambito deve ritenersi maggiormente circoscritto e connotato dal particolare rilievo che assume la menzione dei soggetti disabili[35]. Il perimetro così risultante può essere determinato avvalendosi, piuttosto che del collegamento con la fondazione, delle finalità tipiche dell’impresa sociale[36]. Gli esiti di questa tesi appaiono non dissimili rispetto a quanto sostenuto in precedenza poiché il D. Lgs. 155/2006 contempla attività di assistenza sociale, assistenza sanitaria, socio-sanitaria, educazione, istruzione, formazione, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione extrascolastica, nonché attività dirette a favorire l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili.
Se il rinvio all’impresa sociale rappresenta il riferimento normativo di questa ricostruzione, nell’ambito della medesima prospettiva vi è chi sostiene che il terreno elettivo della solidarietà sociale sia un altro, quella della famiglia, considerata nelle sue varie manifestazioni. Pertanto sarebbe pienamente legittima una destinazione finalizzata al soddisfacimento degli obblighi contributivi familiari[37], anche nella fase patologica, per le esigenze di mantenimento dell’ex coniuge e della prole[38], sia nella famiglia legittima che in quella di fatto.
A favore di queste conclusioni sembrerebbero deporre anche i precedenti lavori parlamentari, con cui si era tentato di introdurre il negozio di destinazione, e nel quale si faceva esplicito riferimento alla tutela dell’autosufficienza economica dei soggetti portatori di handicap, nonché al mantenimento, all’istruzione ed al sostegno economico di discendenti.[39]
Tuttavia, tali esiti meritano alcune precisazioni. Da un lato si è affermato che nel concetto di solidarietà può e deve ricomprendersi anche l’ambito familiare, ed in tal senso sembra esprimersi anche un precedente lavoro parlamentare (Atto n. 5414), ma dall’altro va segnalato come la giurisprudenza interpreti il concetto di “bisogni familiari” ricomprendendovi non soltanto quelli essenziali (ad esempio gli alimenti), ma anche «le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi»[40]. Pertanto, difficilmente tutti gli interessi sussumibili nel concetto di “bisogni familiari” avranno il crisma della pubblica utilità, cosicché, se potenzialmente la meritevolezza sembrerebbe abbracciare l’ambito familiare complessivamente considerato, una concreta valutazione condurrebbe a selezionarne solo alcuni aspetti[41].
Nel medesimo filone interpretativo va collocata anche la tesi (precedente l’introduzione dell’art. 2645 ter c.c.) secondo cui gli interessi creditori andrebbero valutati alla stregua dei principi di rango costituzionale. Tale rilevanza condurrebbe inevitabilmente a ritenerli sacrificabili solo a vantaggio di altri interessi di medesima rilevanza[42].
In conclusione, con una formula ampia, può dirsi che, secondo l’orientamento esposto, l’art. 2645 ter c.c. si riferisce a tutti gli «interessi non lucrativi, che assumono rilevanza sul piano della morale o sono socialmente utili, in attuazione di principi solidaristici»[43], costituendo una strumento al servizio «dell’autonomia privata della solidarietà»[44].
4. Altri autori, ripercorrendo l’evoluzione del fenomeno destinatorio, hanno rilevato che nel nostro ordinamento i fenomeni di separazione patrimoniale per uno scopo soffrono di una rigida tipizzazione ad opera del Legislatore, che seleziona a monte le ipotesi ammesse, sulla base di un giudizio di prevalenza degli interessi perseguiti. La medesima valutazione comparativa, secondo i sostenitori di questa tesi[45], dovrebbe essere alla base del giudizio di meritevolezza ai sensi dell’art. 2645 ter c.c.. Tale giudizio si risolverebbe pertanto in un confronto tra il valore del fine destinatorio e l’interesse sacrificato, generalmente quello dei creditori o aventi causa del conferente[46]. La meritevolezza assume pertanto un valore relazionale, mutevole da caso a caso, che funge da ago della bilancia ed al quale viene affidato «il compito di comporre il delicato equilibrio tra autonomia negoziale e tutela del credito»[47].
L’unico filtro per l’ingresso nel nostro ordinamento di vincoli di destinazione sarebbe rappresentato dal confronto tra interessi, purché leciti. Secondo un Autore andrebbe infatti rifiutata la concezione etica o solidaristica dello scopo, non essendo questi i termini del giudizio. Ne consegue che lo specifico interesse del creditore potrebbe essere sacrificato anche a vantaggio di uno egoistico, a patto che non sia futile o capriccioso.[48] Altra dottrina, in maniera più equilibrata, raccogliendo le istanze avanzate dalla maggioranza degli interpreti, ritiene invece che gli interessi ammessi, sebbene la meritevolezza sia un concetto relazionale, debbano comunque avere un carattere super-individuale o profili di utilità sociale.[49]
Tuttavia l’esigenza di certezza dei traffici economici mal si concilierebbe con l’incertezza di un siffatto giudizio, connotato da valutazioni contingenti e mutevoli, e rinviato ad un eventuale successiva fase patologica[50]. Pertanto, nel tentativo di dare una cornice più sicura alla norma, si è predicata la meritevolezza di quegli interessi sui quali il Legislatore abbia già espresso una propria valutazione favorevole, attraverso un positivo riconoscimento. Tali sarebbero, ai sensi delle norme del codice civile e di leggi speciali, quelli finalizzati al soddisfacimento di interessi attinenti ai bisogni della famiglia, all’avviamento di una professione o un’arte e ai premi di nuzialità, ai fini previdenziali o assistenziali in ambito lavorativo, all’attività di impresa, all’educazione, istruzione ed avviamento al lavoro, all’assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitario, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla valorizzazione del patrimonio culturale, al turismo sociale, alla formazione universitaria e post universitaria, alla ricerca ed erogazione di servizi culturali, alla promozione di sport dilettantistico, alla tutela di diritti civili e della ricerca scientifica. Accanto questa elencazione vanno ricomprese con sicurezza quelle destinazioni che, riferite a soggetti in particolari condizioni, devono ritenersi di per sé connotate da meritevolezza, ed in specie quelle relative a persone svantaggiate fisicamente, psichicamente, socialmente o economicamente, componenti di comunità non integrate, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure alternative ecc.[51]
Oltre dette ipotesi, si reputano comunque ammesse anche quelle finalità che, al di là dell’interesse immediato del singolo beneficiario, intercettano un interesse mediato della comunità, prendendo in considerazione tutte le istanze e le esigenze.[52]
Diversamente, pur riconoscendo il valore relazionale della meritevolezza, si è tentato di riempire il relativo giudizio di valutazioni attinenti non solo alla pregnanza degli interessi, ma anche alla congruità del contenuto della destinazione rispetto agli scopi, espressione del principio di ragionevolezza[53].
5. Si dibatte sul ruolo del notaio, sul rapporto con quello del giudice del contenzioso e sui relativi compiti di controllo, e se da una parte si tenta di attribuire al notaio la funzione di arbitro degli interessi meritevoli, sembra prevalere l’orientamento che esclude tale conclusione[54]. Anche se un eccessiva concentrazione di potere in capo all’autorità giudiziaria suscita giustificate preoccupazioni, è fuori dubbio che il giudizio più rilevante viene effettuato proprio da tale organo, pertanto non si può prescindere da una sommaria ricostruzione degli orientamenti espressi in questo primo decennio di vita.[55]
La prima decisione che ha toccato la questione degli interessi, emessa dal Tribunale di Trieste[56], riguarda la trascrizione di un trust alla luce del nuovo articolo 2645 ter c.c.. Facendo riferimento ad un precedente pronunciamento, il Tribunale ha definito il concetto di meritevolezza attribuendovi il significato che generalmente allo stesso viene riconosciuto: non illiceità. Detto collegio esclude qualunque connotazione ulteriore della meritevolezza e ribadisce l’archiviazione della tesi dell’utilità sociale, che aveva ispirato storicamente la sua introduzione nel Codice Civile. Alla medesima conclusione giungono anche il Tribunale di Reggio Emilia che il Tribunale di Lecco[57], aditi rispettivamente in materia familiare ed in materia di concordato preventivo, affermando che il giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti col negozio atipico si riduce, in realtà, ad una valutazione di non illiceità, in cui l'interprete deve limitarsi all'esame della non contrarietà del negozio alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume.
Si esprimono in termini analoghi altri due pronunciamenti da parte delle Corti di merito, in cui, pur non avallandosi espressamente l’orientamento estensivo, si esclude la riconducibilità del concetto di meritevolezza a quello di solidarietà sociale[58], rilevandosi altresì la potenziale “eversività” di una tale impostazione qualora fosse priva di ulteriori correttivi[59].
A diversa conclusione pervengono invece altre Corti territoriali, che accolgono l’orientamento più restrittivo, cd. “pubblicistico”, secondo cui l’interesse tutelato dalla norma dovrebbe necessariamente connotarsi in termini di utilità sociale, solidarietà, o comunque da una rilevanza super individuale che non si esaurisca nella semplice liceità. In tal senso si esprime chiaramente il Tribunale di Roma[60], che, senza argomentare, afferma con semplicità la necessarietà di profili etici o solidaristici della destinazione. Con analoga sintesi, anche il Tribunale di Vicenza[61] ritiene ammessi soltanto gli interessi attinenti alla solidarietà, gli unici in grado di giustificare un deroga al principio della responsabilità patrimoniale al di fuori di ipotesi tipizzate.
In termini meno perentori, ma ugualmente conformi a questo orientamento, si esprimono altri due arresti, con cui, da un lato, viene ribadita l’essenzialità di un interesse superiore riferito a particolari soggetti[62], mentre dall’altro si sottolinea la diversità del giudizio di liceità rispetto a quello di meritevolezza[63].
Aderiscono invece al terzo orientamento, cd. “comparativo”, due recenti pronunce che hanno enfatizzato la centralità di una concreta valutazione degli interessi contrapposti[64], da condurre sulla base delle specifiche istanze perseguite dal conferente rispetto al controinteresse sacrificato. In forza di detta adesione, la Corte si attribuisce un penetrante controllo sull’interesse destinatorio, riqualificandolo (rispetto a quello indicato in atto), per giungere conseguentemente ad un pronuncia negativa. Se da un lato appare opportuna la tutela garantita da un processo valutativo così specifico e non astratto, non può negarsi la conseguente incertezza derivante dall’esercizio di un potere arbitrario così ampio, non circoscritto da quelle opportuna cornice di riferimenti normativi (che esprimono un giudizio di prevalenza già operato da legislatore), ed al quale anche il giudice adito dovrebbe attenersi.
Le più recenti pronunce sull’art. 2645 ter c.c., pur non esprimendosi in punto di meritevolezza degli interessi, forniscono ugualmente preziose indicazioni[65]. Infatti, sebbene formalmente non vi sia una presa di posizione, le Corti, adite in materia di concordato preventivo, ritengono ammessa anche in tale ambito l’applicazione dell’istituto in questione. Da ciò può pacificamente desumersi che è stata ripudiata la pretesa di profili solidaristici, o di utilità sociale, poiché l’interesse dei creditori concorsuali non può ascriversi a tali categorie. Non è consentito tuttavia giungere a conclusioni ulteriori ed affermare l’adesione all’orientamento estensivo o comparatistico, ad eccezione del rilievo che la materia concordataria costituisce il terreno di maggior applicazione dell’art. 2645 ter c.c.. Questo forse è il dato più inaspettato, che testimonia la volontà di garantire alla norma spazi di operatività ben più ampi di quelli in cui parte della dottrina intende confinarla.
L’ultimo arresto in ordine di tempo proviene dal medesimo Giudice che per primo è stato investito della questione, chiudendo questa decade di applicazione proprio come la si era aperta. Si potrebbe dire che il tempo non ha cambiato quasi nulla, tanto che valgono le medesime conclusioni allora riportate. Infatti la Corte, ripudiando nella maniera più netta ogni concezione metaindividuale e corporativistica della meritevolezza, ne afferma la rilevanza esclusivamente in termini di liceità[66]. Tuttavia, si precisa, ciò non basterebbe di per se a legittimare una separazione patrimoniale qualora fosse giustificazione di se stessa, ma abbisognerebbe comunque di un programma destinatorio, effettivo e ragionevole, in grado di perseguire le finalità proposte.
6. In conclusione, il quadro degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali evidenzia le difficoltà interpretative dell’art. 2645 ter c.c., con all’orizzonte poche prospettive, almeno fino a che la Suprema Corte non interverrà a mettere termine a tali annose questioni. L’assenza di un’adeguata disciplina, nonché la pretesa (da parte di alcuni autori) di profili di utilità sociale, spingono inevitabilmente il fenomeno destinatorio in un’area di eccessiva discrezionalità, sacrificando le esigenze di stabilità e certezza. Muovendo da questo primo punto, il ragionamento deve svilupparsi tenendo in considerazione sia la posizione dei creditori che la necessità di non irrigidire troppo tale atto, la cui peculiarità sta proprio nella atipicità del contenuto. Si è detto che il requisito di liceità, da solo, non potrebbe assurgere a parametro sufficiente per garantire un equo contemperamento delle ragioni private, anzi rischierebbe di condurre ed esiti sfavorevoli per l’interesse generale. Analogamente si è rilevata l’insufficienza della sola azione revocatoria, sol se si consideri che non sempre vi è un intento fraudolento del disponente e che i controinteressati potrebbero non essere creditori. Tuttavia tali considerazioni non appaiono decisive per escludere la validità della tesi cd. estensiva, la quale vanta a proprio sostegno gli argomenti più forti, primo tra tutti il dato testuale. A ciò si aggiunga che, dai pareri espressi dalle Commissioni Parlamentari, emerge la consapevolezza del valore del rinvio all’art. 1322 c.c.. Inoltre, non è priva di rilievo la considerazione di carattere sistematico per cui gli interessi non tutelabili attraverso l’art. 2645 ter c.c. possono essere soddisfatti ricorrendo all’istituto del trust, il cui ambito di applicazione è decisamente più ampio e meno incerto.
Dall’altro lato sembra ugualmente condivisibile il timore di una giuridicizzazione di interessi futili e capricciosi e la necessità di una fase di comparazione che garantisca equilibrio tra gli interessi in gioco, sebbene ciò non sembra legittimare l’introduzione di una soglia di rilevanza degli interessi connotata da profili etici o solidaristici. Non vi sono infatti elementi testuali dai quali desumere una simile compressione, ritenendosi altresì superata l’interpretazione della meritevolezza in termini metaindividuali.
Nel quadro appena delineato, sebbene appaia difficile determinare un orientamento prevalente, con maggiore convinzione si possono respingere quelle posizioni eccessivamente rigide, pur autorevolmente espresse, che tendono a legare la meritevolezza a profili di utilità ovvero solidarietà sociale. Invero sembra lasciarsi preferire la soluzione così come esposta dalla giurisprudenza da ultimo citata, incentrata su parametri semplici e certi: liceità, effettività e ragionevolezza della destinazione. Le parole d’ordine sono chiarezza ed obiettività, solo in tal modo si riuscirà davvero ad ampliare lo spazio dell’autonomia privata.
[1] BETTI, Sui principi generali del nuovo ordine giuridico, in RDCo, I, 1940, 222.
[2] BETTI, Diritto Romano, I, Parte generale, 1935, 201; BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato Vassalli, 1943, 23, secondo il quale «è tendenza costante della nuova legislazione quella di ispirare a finalità sociali tutta la funzione normativa del diritto; non basta allargare la nozione della illiceità della causa, ma occorre richiedere la positiva rispondenza dei negozi conclusi a funzioni di interesse sociale». Per una ricostruzione sommaria della elaborazioni ermeneutiche avanzate all’epoca della codificazione si veda anche GUARNIERI, Meritevolezza dell’interesse, in D. disc. Priv., sez. civ., 1994, XI, 324-326.
[3] C.M. BIANCA, Diritto civile. III, Il contratto, 2000, 459, il quale afferma che «il giudizio di meritevolezza dell’interesse non può prescindere dalla scelta costituzionale nel senso che l’iniziativa privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41 cpv Cost.)”; NUZZO, Utilità sociale ed autonomia privata, 1975, 98, per il quale «L’interesse sociale emergente dall’ordine costituzionale(…) può reagire sulla causa in concreto dell’atto determinandone l’illiceità, in quanto l’interesse con questo sia con esso contrastante». L’argomento è stato oggetto di recenti attenzioni da parte di autorevole dottrina, che ha sollecitato una reinterpretazione del concetto di meritevolezza non più in chiave negativa, quale limite, ma in chiave positiva, quale strumento al servizio dell’autonomia privata, ed in tal senso si vedano le riflessioni di M. BIANCA, Alcune riflessioni sul concetto di meritevolezza degli interessi, in Riv. Dir. Civ., 2011, I, 808, la quale vi attribuisce il valore di «predicato dell’autonomia negoziale», nonché di «grimaldello per il riconoscimento di nuovi schemi negoziali».
[4] ROSSI, Alcune riflessioni sulla nozione di meritevolezza dell’art.1322 del codice civile. L’art. 2645-ter, in Working Paper dell’Università degli studi G. D’Annunzio n. 3/2009, 2009.
[5] GORLA, Il contratto, I, Lineamenti generali, 1954, 225: «l’unica limitazione che si pone alla sanzionabilità del contratto in vista dell’interesse pubblico è quella della cosiddetta illiceità, cioè la contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume»;FERRI, Ancora in tema di meritevolezza dell’interesse, in Saggi di diritto civile, 1983, 339: «Se dunque la meritevolezza dell’interesse significa liceità dell’interesse, il principio del comma 2° dell’art. 1322 c.c. pur se espressamente affermato con riferimento ai soli contratti atipici, non individua un esigenza circoscritta a questi ultimi»; FERRI, Meritevolezza degli interessi ed utilità sociale, in Saggi di diritto civile, 1983, 324, il quale paventa il pericolo che una clausola generale di meritevolezza metta il giudice in condizione di esprimere «il peso della sua ideologia (e degli eventuali tatticismi che questa gli imponga), dei suoi estri personali, della sua conoscenza di cose giuridiche ed economiche con un’arbitrarietà non consentita».
[6] GAZZONI, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. Dir. Civ., 1978, 62: «l’altro giudizio (quello di meritevolezza) ha diversa portata non incentrandosi nella difesa dei principi fondamentali dell’ordinamento, ma piuttosto nella valutazione di idoneità dello strumento elaborato dai privati ad assurgere a modello giuridico di regolamentazione di interessi». In senso conforme si pone anche M. BIANCA, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, 1996, 215.
[7] Per un’ampia disamina della giurisprudenza si veda in particolare CONTURSI-LISI, Contratti Atipici, in GSDCC, 1997, I, 69-86, che ricostruisce i tentativi di separare il giudizio di liceità e di meritevolezza (riconoscendo priorità a quest’ultimo) nonchè di determinare un rapporto tra gli stessi, ad esito dei quali si è giunti tuttavia a semplici petizioni di principio con una sostanziale identificazione dei giudizi medesimi.
[8] M. BIANCA, voce “Vincoli di destinazione del patrimonio”, in Estratto dal volume di aggiornamento XV della Enc. Giur. Treccani, 2007, §5.2, 13.
[9] Si vedano in tal senso gli scritti di FALZEA, Riflessioni preliminari, in La trascrizione dell’atto di destinazione, 2007, 7: «il requisito di meritevolezza dell’atto di destinazione allo scopo non sia diverso dal requisito richiesto per qualsiasi contratto atipico e debba essere trattato allo stesso modo»; VETTORI, Atto di destinazione e trascrizione, in La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, 2007, 176, sostiene che la meritevolezza «è rivolta ed affermata in ordine ad una valutazione di interesse che non deve affatto essere prevalente rispetto ad altri interessi. […]Si è usato questo riferimento alla meritevolezza perché nella giurisprudenza prevalente il termine equivale a non illiceità»; PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. Dir. Civ., 2006, II, 161: «non si richiede una particolare pregnanza dell’interesse del disponente, cioè la verifica da parte dell’interprete di una sua graduazione poziore rispetto all’interesse dei creditori o alla libera circolazione dei beni», mabasta individuare «un interesse sufficientemente serio da prevalere sull’interesse economico generale»; OPPO, Riflessioni preliminari, in La trascrizione dell’atto di destinazione, 2007, 13, afferma che «non vi sono argomenti sufficienti per limitare la meritevolezza codicistica (ex art. 1322) dell’interesse e i possibili beneficiari»; PALERMO, Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell’assetto di interessi, inLa trascrizione dell’atto di destinazione, 2007, 77;GENTILI, Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell’art. 2645 ter c.c., in Rass. Dir. Civ., 2007, 16.
[10] Vedi nota 7.
[11] Parere espresso in data 28 giugno 2005, reperibile sul sito http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/bollet/200506/0628/html/02/frame.htm: «La trascrizione può essere effettuata soltanto qualora i relativi atti siano stipulati per atto pubblico; siano diretti alla costituzione di un vincolo di destinazione della durata non superiore ai novanta anni o analoga a quella della vita del beneficiario e siano destinati al perseguimento di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile. Ricorda, in proposito, che, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, il giudizio di meritevolezza di cui al citato articolo 1322 coincide sostanzialmente con l'accertamento di non contrarietà del negozio realizzato alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e non implica, di conseguenza, alcuna valutazione circa l'utilità sociale dell'atto: è rimasta isolata la pronuncia giurisprudenziale di merito secondo cui, perché gli interessi perseguiti possano essere ritenuti non meritevoli, non è necessario che essi siano contrari a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, bensì è sufficiente che non si prestino ad essere armonicamente integrati nella tavola dei valori dell'ordinamento».
[12] PALERMO, Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell’assetto di interessi, in La trascrizione dell’atto di destinazione, 2007, 77: « (…)per quello che può essere ormai considerato ius receptum, il giudizio di meritevolezza dell’interesse perseguito, al quale si riferisce l’art. 1322 secondo comma c.c., è essenzialmente un giudizio di ragionevolezza del disporre (…), non sembra che debbano essere svolti ulteriori argomenti per dimostrare l’assoluta inconsistenza di ogni tentativo, volto a ridurre l’ambito di applicabilità dell’art. 2645 ter c.c., facendo leva su esigenze solidaristiche, al soddisfacimento delle quali l’esercizio del potere di autonomia dovrebbe ritenersi subordinato».
[13] VETTORI, Atto di destinazione e trascrizione. L’art. 2645 ter c.c., in La trascrizione dell’atto di destinazione, 2007, 177:«Un filtro di meritevolezza dell’interesse, affidato al notaio o al giudice, non è coerente con l’equilibrio istituzionale tra iurisdictio e legislatio in uno Stato di diritto, basato sul principio di legalità perché il giudizio di conformazione della res e del patrimonio spetta solo e soltanto alla legge per esigenze di certezza ed ordine. Attribuire ad un interprete qualificato come il giudice, o ad un interprete professionale, come il notaio, un giudizio di prevalenza degli interessi in ordine a tali aspetti non è conforme ad una differenziazione dei poteri e delle rispettive funzioni in ordine alla circolazione dei beni».
[14] FALZEA, Riflessioni preliminari, in La trascrizione dell’atto di destinazione, 2007, 7: «il requisito di meritevolezza dell’atto di destinazione allo scopo non sia diverso dal requisito richiesto per qualsiasi contratto atipico e debba essere trattato allo stesso modo, rivestendo importanza, dato il richiamo espresso del testo legislativo, che l’atto di destinazione allo scopo, anche quando assume la veste contrattuale, rappresenta di per se un tipo legale».
[15] PALERMO, Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell’assetto di interessi, in La trascrizione dell’atto di destinazione, 2007, 76 : « […] si è diffusa presso i primi commentatori – in modo non adeguatamente motivato – l’opinione che possa parlarsi di meritevolezza, per quanto attiene al profilo teleologico, solo quando l’intento negoziale risulti orientato verso il soddisfacimento di esigenze suscettibili di essere generalmente condivise nell’ambito della collettività. Tale opinione, a mio avviso, non può essere accolta».
[16] OPPO, Prefazione, in La trascrizione dell’atto di destinazione, 2007, 13: «non vi sono argomenti sufficienti per limitare la meritevolezza codicistica ( ex art. 1322) dell’interesse e i possibili beneficiari: conseguentemente, non escluderei che persona fisica beneficiaria possa essere lo stesso disponente, anche a richiedere che il fine da lui perseguito non sia esclusivamente egoistico».
[17] PALERMO, Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell’assetto di interessi, in La trascrizione dell’atto di destinazione, 2007, 77: «A fronte di siffatto tentativo – operato sotto il convincimento che i potere di autonomia sia in qualche modo degradabile a funzione - è d’obbligo ribadire il valore primario, che la libertà di iniziativa riveste in campo negoziale e n che nella novella viene chiaramente evidenziato, sotto molti aspetti».
[18] PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. Dir. Civ., 2006, II, 179 : «non si richiede una particolare “pregnanza” dell’interesse del disponente, cioè la verifica da parte dell’interprete di una sua “graduazione” poziore rispetto all’interesse dei creditori o alla libera circolazione dei beni».
[19] FANTICINI, L’articolo 2645-ter del codice civile: “Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”, in Aa. Vv., La tutela dei patrimoni, 2006, 431: «Volendo ipotizzare un più intenso controllo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti, la disposizione de qua rischierebbe di creare ingiustificate disparità di trattamento rispetto alle situazioni disciplinate dalla legge straniera, la cui applicazione è esclusa solo “se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico” (art 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218); in altri termini, l’atipico “negozio destinatorio” italiano dovrebbe soddisfare (quantomeno per la trascrizione) requisiti ulteriori rispetto al suo omologo regolato da legge straniera e questo appare davvero incongruo».
[20] PALERMO, op cit., 77, afferma che «considerando che il giudizio di meritevolezza dell’interesse perseguito, al quale si riferisce l’art. 1322 c.c. secondo comma , è essenzialmente un giudizio di ragionevolezza del disporre», tuttavia rileva «l’assoluta inconsistenza di ogni tentativo, volto a ridurre l’ambito di applicabilità facendo leva su esigenze solidaristiche».
[21] CHINALE, Vincoli di indisponibilità, in Studi in onore di Sacco, II, 1994, 202.
[22] GAZZONI, Osservazioni, in La trascrizione dell’atto di destinazione, 2006, 216 : «La stravaganza, la futilità, la vanità avrebbero allora libero corso, prevalendo sull’interesse dei creditori e sullo stesso disposto dell’art. 2740 c.c. […] l’incostituzionalità dell’art. 2645 ter c.c. per violazione dell’art. 3 Cost. in punto di irragionevolezza sarebbe ben sostenibile».
[23] SCADUTO, Gli interessi meritevoli di tutela: “autonomia privata delle opportunità” o “autonomia privata della solidarietà, in Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata, Atti dei Convegni tenutisi a Rimini il 1° luglio e a Catania l'11 novembre 2006 (N. 1/2007), consultabili sul sito http://elibrary.fondazionenotariato.it/indice.asp?pub=5&mn=3 : «La sensazione è che l'irruzione scomposta dell'atto di destinazione nel nostro ordinamento, l'ambigua collocazione della disposizione, la discutibile riconducibilità della nuova figura alle pregresse aspettative della dottrina, la tensione del dibattito sul trust interno, il timore di uno scardinamento irrimediabile dei principi in tema di responsabilità patrimoniale e, quindi, l'evidente rischio che il vincolo di destinazione possa essere impiegato per fini di sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori, sotto simulate spoglie di fini di destinazione, tutto ciò ha indotto a pretendere una colorazione degli interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento che non si riesce a rinvenire nell'art. 2645-ter»;
[24] Sostengono questa tesi GAZZONI, Osservazioni, in op. cit., 2007, 216; ZOPPINI, Destinazione patrimoniale e trust: raffronti e linee per una ricostruzione sistematica, in Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata, Atti dei Convegni tenutisi a Rimini il 1° luglio e a Catania l'11 novembre 2006 (N. 1/2007); CEOLIN, Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato, 2010, 66; SPADA, Articolazione del patrimonio di destinazione, in Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata, Atti dei Convegni tenutisi a Rimini il 1° luglio e a Catania l'11 novembre 2006 (N. 1/2007); DI MAJO, Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto, in La trascrizione dell’atto di destinazione, 2007, 118; TROIANO, Destinazione di beni al soddisfacimento dei bisogni di una famiglia c.d. di fatto; OBERTO, Famiglia di fatto e convivenze: tutela dei soggetti interessati e regolamentazione dei rapporti patrimoniali in vista della successione, consultabile al sito http://giacomooberto.com/convivenzaesuccessioni/convivenzaesuccessioni.htm; QUADRI, La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata, 2004; MORACE PINELLI, Tipicità dell’atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua disciplina, in Riv. Dir. Civ., 2008, II, 472.
[25] GAZZONI, Osservazioni, in op. cit., 217: «potrebbe quindi dirsi che la finalità destinatoria deve poter essere ricompresa in quel concetto di pubblica utilità che un tempo era alla base del riconoscimento delle fondazioni»; ZOPPINI, Destinazione patrimoniale e trust: raffronti e linee per una ricostruzione sistematica, in op. cit..
[26] GAZZONI, Osservazioni, in op. cit.., 220: «Sul piano funzionale, poi, per quanto riguarda la ratio legis, insisto nell’idea che l’atto pubblico di destinazione sia da avvicinare, sul piano funzionale, all’atto di fondazione».
[27] GAZZONI, Osservazioni, in op. cit., 223, sostiene che sarebbe del pari consentito al beneficiario della destinazione, non rientrandosi nell’ambito della destinazione onerosa, di accollarsi «i costi relativi alla manutenzione dell’immobile e quelli necessari ad attuare la destinazione, dando luogo eventualmente a quei debiti per i quali vige il sistema della separazione patrimoniale», come previsto in tema di comodato e di donazione modale, senza che venga snaturata la causa del negozio. Contrariamente BARALIS, Prime riflessioni in tema di art. 2645 ter c.c., in Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata, Atti dei Convegni tenutisi a Rimini il 1° luglio e a Catania l'11 novembre 2006 (N. 1/2007),afferma invece che «non vi sono ragioni per limitare il vincolo ai soli atti gratuiti, ben potendo estendersi agli atti onerosi».
[28] GAZZONI, Osservazioni, in op. cit., 218; BIANCA, DE DONATO, PRIORE, D’ERRICO, L'atto notarile di destinazione. L'art. 2645-ter del Codice civile, 2006, 17, affermano che «la stessa durata del vincolo di 90 anni, che travalica ampiamente il termine fissato dall’art. 979 c.c. in tema di usufrutto, è una forte motivazione per una rigorosa cernita degli interessi da tutelare».
[29] GAZZONI, Osservazioni, in op. cit., 218, cita al riguardo il requisito richiesto dalla disciplina della fondazione e quella sulle annualità successive ex art. 699 c.c.; in tal senso si veda anche ZOPPINI, Destinazione patrimoniale e trust: raffronti e linee per una ricostruzione sistematica, in op. cit., il quale rileva il valore paradigmatico dell’art. 699 c.c., piuttosto che il riferimento all’atto di fondazione.
[30] GAZZONI, Osservazioni, in op. cit., 222, porta ad esempio le norme di cui agli articoli 2447bis e 170 c.c.
[31] SCADUTO, op. cit., rileva che «non pare di scorgere nell'art. 2645-ter alcun indizio che imponga o suggerisca una concezione della meritevolezza degli interessi necessariamente orientata nel senso della solidarietà, della pubblica utilità, o di altro particolare valore sociale o etico, interno ai canoni dell'ordinamento o ad essi del tutto estraneo».
[32] AMADIO, Note introduttive - Gli interessi meritevoli, in Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 357-2012/C, Atti di destinazione – Guida alla redazione, 54: «Così, nel settore no profit, dimostra il nuovo regime di riconoscimento persone giuridiche (DPR 361/2000: abrogaz art. 12 c.c.). Riconoscimento (consistente nell’iscrizione nel relativo registro) subordinato unicamente all’accertamento della “possibilità e liceità dello scopo” nonché all’”adeguatezza del patrimonio”, con abbandono di qualsiasi riferimento alla natura pubblica dell’interesse sottostante la costituzione. Non di diritto positivo, ma presente in più di un progetto di riforma, è l’analoga ridefinizione dello scopo della fondazione (nel senso di una sua riscrittura in termini non più di pubblica utilità ma di liceità).»; ZOPPINI, Destinazione patrimoniale e trust: raffronti e linee per una ricostruzione sistematica, in op. cit.; SPADA, Articolazione del patrimonio di destinazione, in op. cit..
[33] CEOLIN , Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato, 2010, 66; ZOPPINI-NONNE, Fondazioni e trust quali elementi della successione ereditaria, in Successioni e donazioni, I, 2010, 149; TROIANO, Destinazione di beni al soddisfacimento dei bisogni di una famiglia c.d. di fatto, consultabile sul sito http://www.dsg.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid300102.pdf, afferma che il «requisito che un tempo era, dall’opinione dominante, ritenuto alla base del riconoscimento delle fondazioni e che, dopo il d.p.r. 361 del 2000 (il quale si limita ora ad esigere, per il riconoscimento della fondazione, che lo scopo sia “possibile e lecito”), sembra permanere come presupposto di esistenza delle sole fondazioni di famiglia ex art. 28, 3° co., c.c.».
[34] DE DONATO,Elementi dell’atto di destinazione, atti del Convegno sul tema «Atti notarili di destinazione dei beni: Articolo 2645 ter c.c.», organizzato a Milano dal Consiglio Notarile di Milano il 19 giugno 2006: «La menzione dei disabili permea di sé l’intera norma e ne costituisce la chiave di lettura».
[35] SPADA, Conclusioni, in La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, 2006, 203, secondo il quale «non può e non deve restare senza significato che l’unico esemplare testuale di interesse, al quale può essere destinato il cespite, è quello dei disabili, di soggetti la condizione dei quali esige solidarietà, sotto qualsiasi etica, confessionale o laica che sia. »; DE DONATO, Elementi dell’atto di destinazione, loc. cit., il quale afferma che «più che legittimo appare quindi il dubbio che meritevoli di tutela ex art. 2645-ter c.c. possano solo essere, tra gli scopi di utilità sociale, quelli improntati al canone della solidarietà»; OBERTO, Atti destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trust: analogie e differenze, consultabile alla pagina web http://giacomooberto.com/2645ter/2645ter_e_trust.htm#_ftn100: «Più che legittimo appare quindi il dubbio che meritevoli di tutela ex art. 2645-ter c.c. possano solo essere, tra gli scopi di utilità sociale, quelli improntati al canone della solidarietà».
[36] SPADA, Articolazione del patrimonio di destinazione, in op. cit.; BARALIS, op. cit., secondo cui «è lo stesso art. 2645 ter c.c. che, al proprio interno, sembra indicare non una liberta incontrollata di interessi da tutelare, ma una gerarchia. Si rifletta: in primo luogo la meritevolezza viene rapportata a persone disabili, poi a pubbliche amministrazioni , quindi ad altri enti o persone fisiche […] Sembra doversi ricavare il ragionevole convincimento che le prime due categorie di soggetti sono quelle “elettive” nella selezione e cernita degli interessi meritevoli di tutela, mentre per le categorie generiche degli enti o persone fisiche la cernita dovrà essere più rigorosa».
[37] DE DONATO, Elementi dell’atto di destinazione, op. cit.: «La destinazione negoziale può coprire, non derogandole ma rendendole più stabili ed efficienti, le prospettive di tutela di coniuge e figli, già fissate nelle citate norme sia in relazione agli assegni di separazione o divorzio sia in relazione alla destinazione della casa adibita a residenza familiare, strutturando negozialmente, nei limiti di legge, i vari diritti ed obblighi, il loro contenuto e la loro durata»;OBERTO, Famiglia di fatto e convivenze: tutela dei soggetti interessati e regolamentazione dei rapporti patrimoniali in vista della successione, Relazione presentata al convegno sul tema «Donazioni e successioni nell’evoluzione civilistica e fiscale. Tutela dei legittimari e circolazione dei beni. Assetti patrimoniali e pianificazione fiscale», svoltosi a Milano nei giorni 3 e 4 ottobre 2006 e a Roma nei giorni 20 e 21 novembre 2006, disponibile sul sito http://giacomooberto.com/convivenzaesuccessioni/convivenzaesuccessioni.htm#_ftn1;
[38] OBERTO, Atti destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trust: analogie e differenze, consultabile alla pagina web http://giacomooberto.com/2645ter/2645ter_e_trust.htm#_ftn100,«Se è vero come è vero che le osservazioni di cui sopra costituiscono una forte motivazione «per una rigorosa cernita degli interessi da tutelare» e che la Costituzione (artt. 41 e 42) «fissa un criterio di socialità per l’attività economica privata e per la proprietà che deve servire per modulare il criterio fondante dell’interpretazione della nuova norma», ne deriva che potranno ritenersi sicuramente meritevoli di tutela interessi quali quelli legati al dovere di contribuzione nella famiglia tanto legittima (artt. 143, 167 c.c.), che di fatto, all’obbligo di mantenimento della prole, sia nella fase «fisiologica» (artt. 147, 148 c.c.), che in quella «patologica» (artt. 155 ss. c.c., art. 6, l.div.) del rapporto coniugale, allo stesso mantenimento del coniuge separato (art. 156 c.c.) e all’assegno in favore del divorziato (art. 5, commi quinto ss., l.div.), per i quali del resto non si esita a parlare di «solidarietà post coniugale». La famiglia costituisce dunque il terreno d’elezione per lo sviluppo di tali manifestazioni di solidarietà, che, ancorché dirette a soggetti determinati, finiscono con l’assumere una funzione sicuramente sociale»; parla di “solidarietà post-coniugale” C.M. BIANCA,Diritto civile. II. La famiglia – Le successioni, 2005, 277.
[39] Si vedano al riguardo gli atti parlamentari n. 3972 Disciplina della destinazione di beni in favore di soggetti portatori di gravi handicap per favorirne l'autosufficienza) e 5414 (Disposizioni in materia di destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilità e di discendenti privi di mezzi di sostentamento) presentati rispettivamente il 14 maggio 2003 ed il 10 novembre 2004, consultabili sul sito http://leg14.camera.it/_dati/leg14/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=3972.
[40] Cass. 15 marzo 2006, n. 5684, in Riv. not., 2007, II, 161;ROSSI, Commento all'art. 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi, in Comm. cod. civ., Artt. 143-230- bis, a cura di Cendon, 2009, 57: «I bisogni da soddisfare nell'ambito della famiglia non si presentano statici ed immutabili; basti considerare che essi variano, ampliandosi ed intensificandosi, a seconda della capacità economica e del connesso e dipendente tenore di vita familiare».
[41] TROIANO, op. cit., 12: «Si rammenti, in proposito, che la giurisprudenza intende con particolare ampiezza la formula “bisogni della famiglia”, con riferimento al fondo patrimoniale, ovvero nel senso che essa si presta a ricomprendere tanto i bisogni essenziali quanto le esigenze ordinarie del nucleo familiare o dei singoli suoi componenti, con esclusione soltanto delle finalità voluttuarie o futili (secondo la formula giurisprudenziale, “le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi”. Siamo, a quanto pare, assai lontani dal concetto di “pubblica utilità”». In giurisprudenza si veda anche T. Reggio Emilia, decreto del 12 maggio 2014.
[42] QUADRI, La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata, 2004, 331.
[43] MORACE PINELLI, Tipicità dell’atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua disciplina, in Riv. Dir. Civ., 2008, II, 472.
[44] SPADA, Conclusioni, in op. cit., 203: «Io credo che quello in discussione sia, è, un istituto - se la parola non è troppo togata rispetto ad un’operazione legislativa tanto sciatta- che una lettura intellettualmente severa ed eticamente rigorosa del materiale normativo dovrebbe limitare alla autonomia privata della solidarietà ed interdire l’autonomia privata dell’opportunità».
[45] NUZZO, Atto di destinazione ed interessi meritevoli di tutela, in La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, 2006, 66; M. BIANCA, Novità è continuità dell’atto negoziale di destinazione, in La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, 2006, 36; ID., La categoria dell’atto notarile di destinazione, in op. cit.; ID., voce “Vincoli di destinazione del patrimonio”, in op. cit.; BIANCA, D’ERRICO, DE DONATO, PRIORE, L’atto notarile di destinazione, 2006, 17; MURITANO-PISCHETOLA, Accordi patrimoniali tra conviventi e attività notarile, 2009, 76; BARALIS, op. cit.; DI PROFIO, Vincoli di destinazione e crisi coniugale: la nuova disciplina dell’art. 2645 ter c.c., in Giur. merito, 2007, 3183; LA PORTA, op cit., 104;
[46] NUZZO, op. cit., 68, secondo il quale bisognerebbe «attribuire al giudizio di meritevolezza dell’interesse perseguito attraverso la destinazione che aspira a divenire opponibile ai terzi, un rilievo relazionale, ciò nel senso che il giudizio di meritevolezza costituisce il risultato di una valutazione comparativa tra l’interesse sacrificato, che quello dei creditori generali, e l’interesse realizzato con l’atto di destinazione». L’autore prosegue ribadendo che «ogni volta che l’interesse perseguito dall’atto di destinazione appartenga alla stessa classe degli interessi rispetto ai quali è consentita dalla legge la costituzione di un vincolo di destinazione, si rientri nell’ambito degli interessi meritevoli di tutela che nell’art. 2645 ter c.c. giustificano la limitazione di responsabilità»; LA PORTA, op cit., 104, sostiene che «la valutazione di meritevolezza deve misurare e comparare l’interesse del disponente a destinare con il sacrificio imposto alle ragioni del credito e della circolazione e, alla luce della ponderazione, sfociare in un giudizio positivo o negativo, che la necessaria forma pubblica dell’atto impone, come in ogni caso di atipicità, in prima battuta al notaio, riservando al giudice dell’eventuale contenzioso l’ultima parola»;
[47] M. BIANCA, voce “Vincoli di destinazione del patrimonio”, in op.cit., 14.
[48] LA PORTA, op. cit., 104, sostiene che il valore relazionale della meritevolezza «non induce necessariamente ad assegnare all’interesse del disponente un particolare valore etico o comunque ultraindividuale; il costo del sacrificio delle ragioni della tendenziale invariabilità del contenuto del diritto reale e quello della specializzazione della responsabilità patrimoniale del creditore può essere sopportato anche in funzione della soddisfazione di interessi egoistici, purchè leciti e non meramente futili e/o capricciosi».
[49] BIANCA, D’ERRICO, DE DONATO, PRIORE, op cit., 16, ove si richiamano testualmente le posizioni di Gazzoni e Nuzzo, mentre in M. BIANCA, La categoria dell’atto negoziale di destinazione: vecchie e nuove prospettive, in op. cit., si richiama anche quella di Spada.
[50] ZOPPINI, Prime (e provvisorie) considerazione sulla nuova fattispecie, in La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, 2006, 100, il quale afferma che «la conseguenza principale di tale norma è che ogni ipotesi di destinazione patrimoniale potrà essere contestata, in quanto i soggetti interessati ad invalidare gli effetti dell’atto di disposizione potranno sempre aprire un contenzioso, destinato a durare una decina di anni, per verificare se tali interessi meritevoli di tutela sussistano oppure no. Ciò che si produce è, quindi, una significativa incertezza quanto all’appartenenza dei beni destinati».
[51] BIANCA, DE DONATO, PRIORE, D’ERRICO, op. cit., 2006, 17; M. BIANCA, La categoria dell’atto negoziale di destinazione: vecchie e nuove prospettive, in op. cit., cita oltre «la costellazione di norme sulla destinazione del patrimonio, anche altre norme che selezionano in modo chiaro ed esplicito gli interessi, per esempio la legge sull’impresa sociale, gli interessi costituzionalmente rilevanti, nonché la giurisprudenza della Corte Costituzionale sul giudizio di meritevolezza parametrato sulla base di valori costituzionali. Questa prospettiva mi sembra tra l’altro la più coerente al sistema e alla ratio della norma».
[52] TALAMANCA, Successioni testamentarie, in Commentario del Codice Civile a cura di Scialoja Branca (697-712), 1968, 427.
[53] BARALIS, op. cit., ritiene che il concetto di meritevolezza abbia un valore differente nell’art. 1322 c.c. rispetto all’art. 2645 ter c.c., operando nella seconda non come controllo di liceità (quindi causalmente), ma come controllo di pregnanza e congruenza con riguardo agli scopi della pubblicità immobiliare. In tal modo si recupera il significato latamente costituzionale dell’art. 1322 c.c. a cui la norma rinvia.
[54] VETTORI, op. cit., 177, secondo cui «attribuire ad un interprete qualificato come il giudice, o ad un interprete professionale, ma non espressione di un assetto istituzionale, come il notaio, un giudizio di prevalenza degli interessi in ordine a tali aspetti non è conforme ad una differenziazione dei poteri e delle rispettive funzioni in ordine alla circolazione dei beni».
[55] In tema di vincoli di destinazione ai sensi dell’art. 2645 ter c.c.: Trib. Trieste, decr. del 24 aprile 2006; Trib. Reggio Emilia, decr. del 23 marzo 2007; Trib. Lecco, decr. del 14 aprile 2012; Trib. Reggio Emilia, decr. del 18 dicembre 2013; Trib. S. Maria Capua Vetere, decr. del 29 novembre 2013; Trib. Roma, sent. del 18 maggio 2013; Trib. Vicenza, decr. del 31 marzo 2011; App. Roma, decr. 16 aprile 2009; Trib. Reggio Emilia, decr. del 7 giugno 2012; Trib. Reggio Emilia, decr. del 12 maggio 2014; App. Trieste, sent. del 19 dicembre 2013, n. 1002; Trib. Ravenna, decr. del 22 maggio 2014; Trib. Rovigo, decr. del 7 ottobre 2014; Trib. Udine del 5 luglio 2013; Trib. Verona, decr. del 13 marzo 2012; Trib. Trieste, decr. del 22 aprile 2015;
[56] Trib. Trieste, decr. del 24 aprile 2006, in Giust. Civ., 2006, 185, con nota di M. BIANCA, Il nuovo art. 2645 ter c.c.. Notazioni a margine di un provvedimento del Giudice Tavolare di Trieste.
[57] Trib. Reggio Emilia, decr. del 13 marzo 2007: «meritevolezza degli interessi perseguiti col negozio atipico si riduce, in realtà, ad una valutazione di non illiceità, in cui l'interprete deve limitarsi all'esame della non contrarietà del negozio alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume»; Trib. Lecco, decr. del 14 aprile 2012 : «questo Collegio non ritiene di condividere l’assunto di partenza del ragionamento illustrato, infatti il rinvio generico dell’art. 2645 ter c.c. alla meritevolezza ex art. 1322 comma 2 c.c. non legittima alcuna ulteriore delimitazione degli interessi che i privati possono perseguire costituendo un vincolo di destinazione, in questo senso parte della dottrina ha tratto argomenti dai lavori preparatori e dalla finalità perseguita di introdurre con ampiezza un istituto che potrebbe favorire investimenti nel nostro Paese; ma in questo senso depone in modo decisivo il tenore testuale e l’assenza di una definizione di solidarietà sociale, altrimenti lasciata all’assoluta discrezionalità del giudice, che avrebbe come unico criterio orientativo la ristretta menzione della disabilità o quella assolutamente ambigua di pubblica amministrazione; considerato quindi senza limiti il rinvio alla meritevolezza ex art.ed evitando di addentrarsi nel dibattito sulla definizione di tale ultima nozione, questo Collegio nota che senza dubbio la finalità perseguita nel caso di specie, che consiste nell’assicurare una soddisfazione proporzionale ai creditori non ancora muniti di cause di prelazione, deve reputarsi degna di riconoscimento dall’Ordinamento».
[58] Trib. Reggio Emilia, decr. del 18 dicembre 2013:«gli interessi de quibus, dunque, sono ascrivibili ad “altri enti o persone fisiche”, sicché la disposizione non può considerarsi delimitata, nella sua portata applicativa, da quei profili di solidarietà sociale che involge il riferimento “a persone con disabilità” (tale richiamo è peraltro irragionevole e censurabile, perché i disabili sono certamente persone fisiche e non un tertium genus). La generalità dei creditori di un imprenditore in stato di crisi (così erano individuati i beneficiari nel vincolo sottoposto all’attenzione del Tribunale vicentino) è un insieme di persone fisiche, enti, persone giuridiche e il dato letterale non avalla una lettura così restrittiva come quella sopra esposta (in questi termini, anche Trib. Lecco, 26/4/2012: “Il rinvio generico contenuto nell’art. 2645-ter c.c. alla meritevolezza di cui all’articolo 1322, comma 2, c.c., non legittima alcuna ulteriore delimitazione degli interessi che i privati possono perseguire costituendo un vincolo di destinazione.”)».
[59] Trib. S. Maria Capua Vetere, decr. del 29 novembre 2013: «[…]sol che si pensi al blando limite – richiamato dallo stesso art. 2645-ter cod. civ. – nascente dal concetto di meritevolezza degli interessi di cui all’art. 1322, secondo comma, cod. civ., per come tradizionalmente interpretato dalla dottrina e giurisprudenza) ».
[60] Trib. Roma, sent. del 18 maggio 2013: « […] agli interessi previsti dalla norma dell’art. 2645 ter c.c. (che devono connotarsi in senso etico e solidaristico, anche quando riferiti a singole persone fisiche)».
[61] Trib. Vicenza, decr. del 31 marzo 2011: «ritenuto che gli interessi meritevoli di tutela richiamati dalla norma sono quelli attinenti alla “solidarietà sociale” e non gli interessi dei creditori di una società insolvente in quanto, diversamente opinando, si consentirebbe ad un atto di autonomia privata, per di più unilaterale, di incidere sul regime legale inderogabile della responsabilità patrimoniale al di fuori di espresse previsioni normative».
[62] App. Roma, decr. 16 aprile 2009: «Questa Corte è consapevole che la norma, interpretata in senso stretto, abbia come precipui destinatari i c.d. trust (sebbene la rubrica abbia una portata più generale) e cioè, quei patrimoni vincolati per un lasso di tempo alla realizzazione d’interessi superiori a vantaggio di particolari soggetti, persone fisiche con disabilità o persone giuridiche private e pubbliche».
[63] Trib. Reggio Emilia, decr. del 7 aprile 2012: «Mentre la costituzione di un trust interno merita un giudizio positivo di liceità mercé il semplice rispetto della Convenzione e del limite dell’ordine pubblico, invece il cittadino italiano che volesse raggiungere lo scopo di vincolare determinati beni per un certo fine ai sensi dell’articolo 2645-ter Codice Civile dovrebbe sperare nell’esito positivo del vago giudizio di meritevolezza dell’interesse (Trib. Trieste, 7.4.2006)». Va sottolineato come tale arresto faccia riferimento ad un precedente pronunciamento la cui contraddittorietà è stata rilevata da M. BIANCA, Il nuovo art. 2645 ter c.c. Notazioni a margine di un provvedimento del Giudice Tavolare di Trieste, in op. cit..
[64] Trib. Reggio Emilia, decr. del 12 maggio 2014: «per affermare la legittimità del vincolo di destinazione, non basta la liceità dello scopo, occorrendo anche un quid pluris integrato dalla comparazione degli interessi in gioco, ed in particolare dalla prevalenza dell'interesse realizzato rispetto all'interesse sacrificato dei creditori del disponente estranei al vincolo (cfr. App. Trieste, sent. n. 1002/2013). Invero, come ha correttamente evidenziato il G.E., si osserva che il Legislatore, in chiave evidentemente riequilibrativa rispetto alle possibilità concesse con il vincolo di destinazione, ha subordinato l'efficacia dello stesso ad un riscontro di meritevolezza in concreto dell'assetto di interessi perseguito dalla parte; e tale riscontro deve essere particolarmente penetrante, proprio in ragione delle potenzialità lesive, nei confronti dei creditori, del vincolo unilateralmente apposto»; App. Trieste, sent. del 19 dicembre 2013, n. 1002 : «il richiamo all’art. 1322 c.c., secondo comma, non sembra consentire un’interpretazione della norma volta ad individuare la “meritevolezza” nella sola sfera della pubblica utilità o della solidarietà sociale; non appare, d’altro canto, sufficiente la mera liceità dello scopo, essendo invece necessaria una comparazione tra l’interesse, sacrificato, dei creditori generali e l’interesse realizzato con l’atto di destinazione».
[65] Trib. Ravenna, decr. del 22 maggio 2014; Trib. Rovigo, decr. del 7 ottobre 2014. Al riguarda si veda anche il decreto del Tribunale di Udine del 5 luglio 2013, il quale adito in materia concordataria, non esclude l’impiego del vincolo di destinazione ex art 2645 ter c.c., sebbene giunga ad una valutazione negativa in termini di “non fattibilità giuridica” del piano.
[66] Trib. Trieste, decr. Del 22 aprile 2015: «Appartiene invero ormai alla storia della dottrina civilistica italiana la considerazione che il legislatore fascista, nel coniare il giudizio di meritevolezza di interessi, intendeva assecondare il modello nazionalsocialista che tramite l’utilizzo delle clausole generali, aveva lo scopo di portare all’interno dei rapporti privatistici principi politici vagamente legali. […] sta di fatto comunque che tra autonomia privata ed utilità sociale esiste una netta distinzione di piano tra di loro non interferenti né strumentali.[…]. Lo sforzo che si può fare è quello di obiettivizzare la meritevolezza, per identificarla nell’idoneità del programma negoziale al raggiungimento di uno scopo lecito[…]. In ultima analisi la ricerca della meritevolezza degli interessi viene a coincidere con l’esistenza di un programma negoziale che sia effettivo e che non si concreti nella sola segregazione».
Scarica Articolo PDF